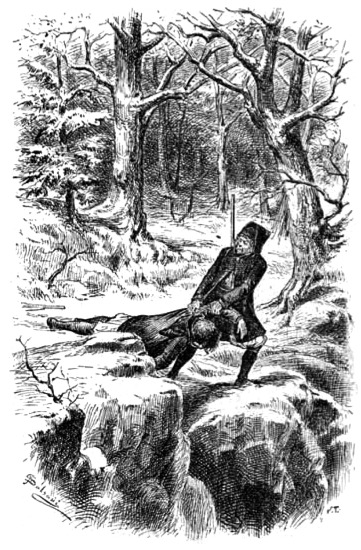
Title: Giovanni Tolu, vol. 2/2
Storia d'un bandito sardo narrata da lui medesimo
Author: Enrico Costa
Release date: July 27, 2025 [eBook #76575]
Language: Italian
Original publication: Sassari: Dessì, 1897
Credits: Barbara Magni and the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net (This file was produced from images generously made available by Sardegna Digital Library)
ENRICO COSTA
GIOVANNI TOLU
STORIA D’UN BANDITO SARDO
NARRATA DA LUI MEDESIMO
PRECEDUTA DA CENNI STORICI
SUI BANDITI DEL LOGUDORO
Con Vignette di Dalsani
Volume Secondo
SASSARI
PREMIATO STABIL. TIP. G. DESSÌ
1897.
[5]
Dopo essermi separato da mia moglie, non posso dire di essere stato sordo all’amore.
Avevo 27 anni, ero giovane, e sapevo di non essere antipatico, nè brutto. Siccome però io tenevo alla sobrietà, alla quale dovevo la virtù della prudenza, stetti in guardia. L’uomo, quando vuole, può esercitare un imperio sulle proprie passioni, ed io era uscito sempre vincitore dalle lotte: mi sapevo frenare dinanzi al vino e dinanzi alle donne. Solamente dinanzi al tabacco ed alla vendetta io mi sentiva debole, nè alcun freno seppi mai impormi — lo confesso.
Io sapevo per esperienza, che solamente nell’intemperanza si commettono le imprudenze. L’eccesso nel bere e la febbre amorosa non possono che togliere l’energia e offuscare l’intelletto. Il latitante ubbriaco, od innamorato, cade facilmente nella rete della giustizia. Il vino e la donna sono i due traditori del bandito; quindi io abborriva dall’uno e dall’altra: conoscevo la storia di [6] Noè, che aveva dato scandalo ai figli; e la storia di Sansone, ch’era stato tradito da Dalila.
Io ero uscito incolume da tutti gli assalti: le palle mi rispettavano. Ero stato compagno dei principali banditi del Logudoro, e li avevo veduti in poco tempo sparire dal mio fianco: — Antonio Rassu, arrestato; Puzzone, morto in carcere; Leonardo Piga e Derudas, in galera; Gio. Cossu, di Nulvi, freddato dai carabinieri; Antonio Spano, avvelenato; Cambilargiu, ucciso da un parente traditore. Io li aveva veduti scomparire ad uno ad uno nei primi anni della mia vita randagia... ed io sorvissi ad essi!
***
Nelle mie solitudini io ricordavo con dolore il mio amore tradito — l’amore calmo e sereno della sposa che v’incoraggia al lavoro e vi sprona ai risparmi quotidiani, per dare un po’ di benessere ai vostri figli, alla vostra famiglia. Io maledicevo quella ragazza sconsigliata che si era da me divisa, solo per dar retta ai mali consigli de’ miei nemici.
Maria Francesca viveva sola, abbandonata da tutti; e qualche vaga voce di contegno scorretto era pervenuta al mio orecchio, sebbene in paese ella avesse fama di buoni costumi. Ma, che m’importava della sua condotta? Mi ero separato da lei; per lei ero diventato un tristo; [7] ed a lei sola io doveva la vitaccia che menavo e che sarebbe finita con una morte violenta, o ignominiosa. Che importava a me di Maria Francesca? La disprezzavo, e null’altro!
***
Era il mese di agosto — della stagione a me cara, perchè mi ricordava la messe e i lavori della trebbiatura, ai quali mi ero dedicato nella mia sana ed onesta giovinezza. Girovagavo in quei giorni mezzo annoiato, in preda ad una stanchezza morale, più che fisica.
Avevo una cugina quindicenne — Mattea Merella — fidanzata a certo Paolo Fonsa. Quantunque non ancora maritata, mia cugina era andata a spigolare per conto del suo Paolo, in un campo poco distante da Florinas, nella regione Nuraghe Idale. Il fratello di Paolo, Francesco Fonsa, aveva preso seco, come spigolatrice per tutta la raccolta, Maddalena Pintus Marongiu — quella ragazza furba, colla quale ero andato alla festa di Mara, e che aveva suscitato sul mio conto un mondo di dicerie.
Io bazzicavo con frequenza in quell’aia, e prendevo svago a chiacchierare colla comitiva allegra delle spigolatrici e dei mietitori.
Un giorno, che Maddalena spigolava a me vicino, mi rivolse la parola:
— Come te la passi, Giovanni?
[8]
— Faccio la vita comoda, come vedi!
Maddalena mi gettò un’occhiata tenera; e mi disse con un sospiro:
— Te ne accorgi, eh? come sei andato! Se invece di Maria Francesca Meloni tu ti fossi ammogliato con qualche altra, forse oggi non lamenteresti quello che ti è accaduto!
— Cara mia; se al mondo si fosse indovini, forse non sbaglierebbe nessuno! So che tu sei innamorata e promessa sposa ad un pastore, ma nessuno sa come finiranno le cose. È il destino che ci tira per i capelli!
La ragazza tacque, e continuò alcun poco a spigolare; poi mi disse senza guardarmi:
— Ricordi, o Giovanni, la nostra gita alla festa di Mara?... e la colazione vicino al ponte? e l’andata alla fontana? Come eri burbero quel giorno con me! Mi tenevi il broncio perchè sapevi che ti volevo bene. Eppure non ho mai dimenticato che mi prendesti a braccetto insieme a mia cugina, per difendermi dalla folla che correva alla fonte... Certe cose non si possono dimenticare! Pare ieri... e sono passati più di quattro anni!
E Maddalena continuava a spigolare, mentre io andava fissando quella ragazza dal volto abbronzato, che in quel momento mi sembrava graziosa.
Io le dissi, affettando noncuranza:
— Anche tu sei ora legata; io ho potuto sciogliere il mio nodo, ma tu...
[9]
— Nessuno è legato a questo mondo! — mi disse Maddalena con voce tremante — ed io potrei sciogliermi, perchè sento di amarti come prima.
— Bada, ch’egli non ti senta!
— Chi?
— Lui... il tuo pastore.
— Che importa? Gli direi sul muso, che amo te più di lui: ecco tutto!
— Quale attrattiva potrei avere agli occhi tuoi? Perchè dovresti amarmi?
— T’amo, perchè ti ho amato prima; perchè sei un disgraziato; perchè sei forte e coraggioso!
Quel giorno mi allontanai; ma confesso che le parole di Maddalena avevano fatto uno strano effetto sull’animo mio. Il ricordo di quella creatura che avevo tanto disprezzato, e che ora mi teneva un linguaggio così affettuoso, m’intenerì. Ella, già così disprezzata, trovava ancora una dolce parola per me; mentre la donna onesta, che avevo prescelto a compagna, non aveva fatto che amareggiarmi la vita, trascinandomi al mal passo.
Ritornai più volte alta messe per chiacchierare con mia cugina e con Paolo, e per continuare i discorsi con Maddalena, che mi aspettava ansiosamente.
Il fidanzato di Maddalena — Gio. Antonio Pitieddu — era un povero pastore. Non potendo [10] abbandonare le sue pecore, se ne stava all’ovile, e veniva di rado all’aia per visitarvi la sposa. Era un giovane vizioso, che nelle sue frequenti visite a Sassari aveva menato una vita dissoluta.
I miei convegni si erano fatti più spessi. L’aia mi tentava, nè tardai ad accorgermi che vi ero spinto dalla passione. Maddalena mi dava l’ora degli appuntamenti, e fra noi si era stabilita un’intimità, che divenne quasi scandalosa.
Passarono così parecchie settimane.
Una maligna cognata di Gio. Antonio, che spiava ogni nostro movimento, un bel giorno ebbe il coraggio di dire a costui:
— Mi pare che ti comporti assai male con una fanciulla che non ti è ancora moglie! Apri gli occhi e intendimi bene! Lo stato della tua fidanzata mi è sospetto. O affretta le nozze se vuoi riparare al tuo fallo, o ritardale se non vuoi riparare al fallo degli altri. Ho detto abbastanza: la tua coscienza ti dica il resto!
La cruda e inattesa rivelazione turbò vivamente il pastore, che aveva stabilito le nozze per la fine di agosto.
— Sei una visionaria od una calunniatrice! — rispose Gio. Antonio alla cognata — e te lo proverò col rimandare il matrimonio alla fine di ottobre.
La madre e i parenti della sposa si adoperarono a scongiurare lo scandalo... e Maddalena andò a nozze il giorno d’Ognisanti, facendo ricredere [11] il marito, ma non persuadendo la cognata, che sapeva il fatto suo.
I due sposi si ritirarono nel loro ovile di Giunchi, dove si stabilirono.
***
Errante per la campagna, io capitavo qualche volta nella capanna di Giovanni Antonio, e continuai la mia relazione segreta con Maddalena, la quale mi aveva dichiarato che sentiva di amarmi più di prima.
I due coniugi erano poveri, e Maddalena si recava con frequenza a Florinas, per chiedere qualche soccorso a mia madre. La buona vecchia le dava sempre viveri, o qualche indumento, ma a malincuore, perchè aveva sospettato della tresca, e me ne moveva continuo rimprovero.
Anch’io soccorrevo il marito, e più d’una volta gli diedi qualche scudo, o lo provvidi di scarpe.
Il fratello, la cognata, ed altri parenti ed amici di Gio. Antonio — che con frequenza lo visitavano — continuarono a sospettare della mia segreta relazione con Maddalena; ma nessuno osò mai mormorarne apertamente, perchè si aveva paura del bandito.
Finalmente Gio. Antonio, aprendo l’orecchio alle insistenti esortazioni della cognata, credette vera la tresca, e si provò a farmi il broncio.
[12]
Non volendo più oltre turbare la pace domestica, sospesi per qualche tempo le mie visite all’ovile.
Cominciarono allora le lagrime e le smanie dei due coniugi: — la moglie piangeva il mio abbandono — il marito si disperava, temendo che mi liberassi di lui con una fucilata.
Un vecchio pastore, amico comune, venne a me per rivelarmi le inquietudini di quella famiglia, che io solo potevo salvare. Io gli risposi:
— Mi ha egli forse ucciso il padre, per temere la mia collera?
— Andiamo dunque a rassicurarlo! — mi suggerì il vecchio.
— Andiamo pure!
Mi presentai all’ovile, e Gio. Antonio corse al mio incontro festoso ed umile. Si venne a spiegazioni reciproche, e la pace fu ristabilita.
Continuai da quel giorno a visitare l’ovile, ma con più cautela e con meno frequenza.
Tuttavia devo confessare, che la mia relazione con Maddalena era durata per oltre sei anni.
Gli amori continuati sono un pericolo permanente per un bandito, ed io volevo sottrarmi agli adescamenti di quella donna.
Dopo un’assenza di più settimane, un giorno entrai nell’ovile di Giunchi.
Maddalena era sola, il marito lontano, e i tre figliuoli in fondo al cortile, intenti a giuocare.
Come mi vide, Maddalena mi corse incontro, [13] mi gettò le braccia al collo, e mi disse con accento vibrato e risoluto:
— Ormai son stanca di questa vita! Io non posso più vivere insieme ad un uomo che non ho amato, che non amo, e non amerò giammai! Portami via: voglio stare solamente con te. Mettimi in qualche molino, dove vuoi, anche serva presso qualche tuo amico, ma toglimi a questa solitudine che mi uccide!
Cercai invano di liberarmi da quelle braccia d’acciaio, e gridai a lei:
— No: assolutamente no! È tempo di mettere giudizio, togliendoci ad una posizione falsa. Tu devi rimanere con tuo marito per aver cura de’ tuoi figliuoli. Pensa che la tua bambina, fra pochi anni, diventerà una fanciulla, nè devi abbandonarla a sè stessa. Che speri da me? io sono un bandito!
— Non m’importa nulla de’ miei figliuoli: il mio mondo sei tu: portami via!
Il delirio febbrile di quella donna mi spaventò. Divenni furibondo, e tentai con tutte le mie forze di svincolarmi da lei. Vedendo che ella ritentava l’assalto, me ne scostai alquanto, le diedi un sonoro schiaffo, la buttai di peso sopra una sedia, e mi slanciai fuori della capanna.
Fui vigliacco, lo so, ma era tempo di finirla[1].
[14]
Da quel giorno non visitai più l’ovile, nè più rividi quella donna.
Maddalena non era certo lo specchio della moglie fedele, nè dell’amica costante.
Pochi mesi dopo la nostra separazione, ella fuggì dal tetto coniugale insieme ad altro giovane, col quale andò a convivere a Mara di Padria. Aveva abbandonato i figliuoli ed il marito con una crudeltà ed un cinismo senza pari.
Gio. Antonio, addolorato di quella fuga, visse alcun tempo tutto solo co’ figliuoli; indi parve rassegnarsi, e si unì illecitamente ad altra donna, a cui affidò il governo della sua casa.
Stabilita col suo amante nel povero villaggio di Mara, forse Maddalena avrà ripensato molte volte alla nostra malaugurata gita alla festa di Nostra signora di Bonuighinu.
La sua bambina primogenita si era fatta col tempo una bellissima fanciulla, ammirata da quanti la vedevano. Raggiunti i quindici anni, essa fu ingannata da un giovane, e fece la fine della madre.
È questa la trista storia di quella Maddalena Pintus, che fu la prima causa delle mie sventure. Chi lo sa? Se io l’avessi scelta a compagna, forse l’uno e l’altra saremmo stati più fortunati e meno colpevoli!
[15]
Ho bisogno di risalire a un mezzo anno addietro per parlarvi di Salvatore Moro.
Era costui un pastore proprietario d’Osilo, col quale correvo in buoni rapporti. Cercai sempre di proteggerlo, ma egli non corrispondeva con pari lealtà ed affetto alla mia benevolenza. Giunsi persino, per volerlo difendere, ad accapigliarmi con Cambilargiu. Questi un giorno mi disse:
— Fammi il piacere di tenermi compagnia fino ad Osilo. Salvatore Moro ha voluto ritenersi otto scudi sul salario dovuto a un mio nipote, col pretesto di presunti danni arrecatigli durante il servizio prestato. Se oggi non mi paga, ho risoluto di ucciderlo!
— Tu non lo ucciderai. Anche i padroni vantano diritti verso i servi. Noi rifaremo i conti, valuteremo i danni, e regoleremo le partite.
— Lo ucciderò se non mi paga! — ripetè Cambilargiu colla solita sua prepotenza.
[16]
— Lascia le furie! Se tu l’uccidi, io ucciderei te!
Cambilargiu ammutolì, ed io lo compiacqui.
Ci recammo insieme da Moro, e riveduti i conti risultò che i danni fatti dal servo ammontavano a soli tre scudi.
Nacque allora una viva contestazione fra le parti; ma la moglie di Salvatore, spaventata dal piglio minaccioso di Cambilargiu, corse a un forziere, ne tolse il danaro, e lo porse a me, dicendo:
— Ecco gli otto scudi! Vi è Dio per pagare mio marito!
Cambilargiu intascò senz’altro il danaro, ed uscimmo dall’ovile. Aveva raggiunto il suo intento, nè chiedeva di più. A simili estorsioni ricorreva ei sempre, quando si trovava corto a soldi.
***
Continuai nei rapporti amichevoli con Salvatore Moro, però non me ne fidavo.
Da qualche tempo mi ero accorto ch’egli covava il disegno di far soldi, traendo partito dai banditi che bazzicavano nella sua capanna. La polizia, in quel tempo, aveva messo in giro i suoi cagnotti, sperando d’impadronirsi dei banditi coll’aiuto delle spie, giacchè non lo poteva colla forza delle armi. Non tutti i pastori erano incorruttibili dinanzi alla lusinga del danaro o [17] della impunità. La speranza del lucro acciecava Moro, ed io stetti all’erta per non dare nella rete.
Un giorno ch’io scorrazzava per la campagna d’Osilo, insieme al bandito Derudas, ci fermammo all’ovile di Moro, che si era mostrato con noi di una cortesia insolita, epperciò a me sospetta.
Egli ci disse:
— Mi sembrate di cattiva cera. Il continuo strapazzo non può che nuocere alla vostra salute. Vi abbisogna un po’ di riposo. Come sapete, ho a mia disposizione la vicina chiesa campestre. Vi è acceso un buon fuoco, ed è un asilo sicuro per voi. Con qualche soldo che riuscirete a strappare ai vostri amici, e col poco che procurerò di darvi, potrete vivere tranquilli per una quindicina di giorni, senza bisogno di correre per monti e per balze da mattina a sera.
— Non mancheremo di approfittare della tua cortesia — disse il Derudas.
Io non risposi nulla. Allontanatici da lui, dissi al mio compagno:
— Senti: Salvatore non ha buone intenzioni; la sua generosa offerta mi è sospetta, perchè non può celare che un’insidia. Guardati dal venir qui! — io certo non ci vengo!
L’intenzione di denunziare qualche bandito era salda nell’animo di Salvatore Moro. A Cambilargiu non poteva certo pensare, poichè questo era suo compaesano, aveva molti parenti ad [18] Osilo, ed il Moro non avrebbe potuto a lungo godere del frutto del suo tradimento, se il tiro gli fosse riuscito. Io invece ero florinese, Derudas era d’Ossi, e il colpo poteva da lui tentarsi con probabilità di successo.
Ebbi pazienza, e dissimulai. Fu sempre mio sistema quello d’indugiare nella vendetta fino a procurarmi le prove che un nemico realmente mi offendesse. Ben sapevo che la calunnia è anch’essa un’arma valevole per sbarazzarsi di una persona molesta; poichè certi malevoli, non riuscendo talora a comprare il nostro braccio, tentano assai spesso d’insinuarci nell’animo l’odio implacabile verso una supposta spia.
Avevano intanto arrestato Derudas ed ucciso Cambilargiu a Luogolentu. Restavo io solo, ghiotta preda per un perfido pastore. Avevo sulla testa 400 scudi — la taglia più alta messa dal Governo finallora sul capo dei banditi sardi. Salvatore adocchiava dunque la mia pelle preziosa, e pensava di conciarla per ricavarne 2000 lire. Molti miei amici e parenti mi mettevano sull’avviso, ma io scrollavo le spalle dicendo: — Le prove mancano; non ho fretta!
Una notizia messa in giro mi colpì vivamente. Salvatore Moro si era dato alla latitanza per sfuggire alle ricerche della giustizia.
Latitante perchè? Qual delitto aveva egli commesso? Perchè darsi alla campagna senza una causa palese? C’era sotto un mistero! I [19] delitti sono noti ai banditi, e delitto alcuno non si era commesso nel circondano di Osilo, del quale il Moro potesse venir accusato. Dunque si trattava di una latitanza simulata per poter carpire la mia confidenza; di un’impunità fittizia che si voleva tirar fuori per giustificare una perfidia; di un mezzo escogitato per poter intascare il danaro della taglia, sfuggendo all’accusa di venale!
Questo piano — certamente concertato colla polizia — non rivelava che l’imbecillità di Salvatore Moro; nè io ero così babbeo da addentare all’amo.
Stentavo a prestar fede anche alla latitanza, quando un nuovo fatto mi diè motivo a sospettare del tranello.
Nel sito detto le Anime del purgatorio, a breve distanza da Sassari, nel punto dove si aprono le due strade di Osilo e di Scala di Ciogga, era avvenuto uno scontro fra Salvatore ed i carabinieri. Vennero scambiate alcune fucilate da ambe le parti, e la notizia fu recata la stessa sera ad Osilo e a Florinas, dai villici che transitano in quella regione, per il continuo commercio con Sassari.
Era stato un finto attacco a sola polvere, senza spargimento di sangue, e fatto ad arte in quel punto, perchè la notizia pervenisse pronta ai due villaggi.
Nessuno credette che quello scontro fosse avvenuto sul serio, ma io mi guardai dall’esternare [20] i miei dubbi ad alcuno. Finsi di credere, mi contenni, e per evitare pericoli me ne andai per un po’ di tempo alla Nurra.
Dopo avvenuto l’attacco delle Anime del purgatorio, il finto latitante aveva reso più frequenti le sue visite all’ovile di mio fratello Giomaria, chiedendo sempre mie nuove. Questo contegno insospettiva i miei parenti e gli amici, che m’informavano di tutto.
Un giorno il barracello Giulio Sechi — amico e collega di Giomaria — venne segretamente all’ovile per abboccarsi con lui. Egli gli disse:
— Trova il modo di avvertirmi non appena Salvatore Moro verrà nel tuo ovile. Ho bisogno di pedinarlo, poichè l’ho sorpreso due volte in colloquio con carabinieri.
— Possibile?!
— So quello che mi dico.
Venuto Moro all’ovile, mio fratello mandò un suo fido ad avvertire l’amico, il quale accorse e si pose in vedetta. Come Salvatore venne fuori dalla capanna, egli lo tenne d’occhio seguendolo per più di un’ora, finchè lo vide accostarsi a dodici carabinieri, coi quali scambiò alcune parole, in vicinanza d’una cantoniera.
Dopo quell’incontro, il finto latitante osò recarsi per altre tre volte nella capanna di Giomaria, per chiedere con insistenza dov’io mi fossi. Egli diceva d’essere un disgraziato che aveva bisogno della mia compagnia.
[21]
Impensierito dal complesso delle circostanze, Giomaria non stette più sul dubbio. Montò a cavallo, venne alla Nurra, e mi narrò l’accaduto per mettermi sull’avviso.
Confidai al mio antico padrone Paolo Sechi, nel cui ovile bazzicavo con frequenza, i casi capitati.
— Per carità, fa attenzione — mi disse — poichè la cattiva pietra è quella che fa crollare un buon muro!
— Non ho paura — risposi — poichè conosco le cattive pietre!
***
Mi portai difilato a Florinas. Lasciai la cavalla in casa dei parenti, e mi ricoverai in campagna. Ivi feci venire mia madre, che condusse seco una sarta col marito, per prendermi la misura di un cappotto, di cui avevo bisogno.
Poco prima che mia madre arrivasse, mi ero recato ad un terreno poco lontano dal paese, posto in Sa pigalva, per abboccarmi con Giomaria, che vi lavorava.
Mio fratello esclamò nel vedermi:
— Guarda combinazione! se tu fossi venuto un momento prima, avresti qui trovato Salvatore Moro!
— Da molt’ora?
— Da cinque minuti.
[22]
— Procura di vederlo... e chiamalo!
Mio fratello si spinse fino al ciglione, ed esplorò la campagna all’intorno.
— È strano: non si vede più!
— Allora dev’essere qui vicino. È facile che siasi ritirato nel boschetto. Guardaci!
Giomaria tornò quasi subito:
— È addormentato, supino, in mezzo agli alberi.
— Va, sveglialo, e digli che ci sono io. Osservalo bene in faccia. Mi dirai l’impressione che gli avrà fatto il mio nome.
Pochi minuti dopo, Giomaria comparve con Salvatore. Mio fratello trovò modo di dirmi, che egli aveva trasalito quando seppe che io lo volevo.
Salvatore Moro si fece avanti, armato di fucile, di pistola e di pugnale, come lo sono tutti i banditi. Io gli dissi con finta commiserazione:
— A te pure è toccata la trista sorte d’essere un bandito come me!
— Eh, fratello caro! sono proprio rovinato!
— Via, non lo sarai come tu credi!
— Sono rovinato, ti dico! La passata settimana ho avuto un attacco coi carabinieri, a pochi passi dalle Anime del purgatorio.
Ed io con affettata premura:
— Sei stato ferito, forse?!
— No, grazie a Dio.
— Avrai ferito qualche carabiniere, almeno?
— Non ne ho saputo niente!
[23]
Poi, cambiando tono, gli dissi:
— Sono ben lieto di trovarti qui. Fui incaricato di procurare uno starello di grano rosso d’Osilo per seminerio. Andremo insieme al tuo paese per farne ricerca, poichè debbo favorirlo ad un amico.
Salvatore non potè celare un movimento di soddisfazione, che tradiva un proposito da lungo tempo preso.
— Figurati se troveremo uno starello di grano rosso d’Osilo!
Intanto era venuta mia madre colla sarta per farmi prendere la misura del cappotto nuovo e per portarmi la biancheria di bucato, come soleva fare di tanto in tanto.
Come mia madre scorse Salvatore Moro, si turbò e impallidì. Essendo già informata da Giomaria delle continue insidie che mi tendeva il delatore, indovinò tutto. Ella certamente lesse nel mio sorriso sinistro il pensiero che mi dominava. Ne fu spaventata, e divenne inquieta.
Salvatore, dal suo canto, colla venuta di mia madre e della sarta, si era forse rassicurato sul motivo che mi conduceva a Florinas.
La vecchia e mio fratello avevano portato da mangiare e da bere, e facemmo pranzo assieme, compreso Salvatore.
Mia madie non faceva che lagrimare, poichè era a parte del tradimento di Salvatore e prevedeva quanto sarebbe avvenuto.
[24]
Io le dissi con tono di scherzo e con doppio significato:
— Sei una madre che piange i figli altrui, a quanto pare!
Appena pranzato caricai la pipa, ed offersi a Salvatore ed al marito della sarta un buon tabacco di contrabbando.
— È proprio eccellente! Dove lo hai? — mi domandò Salvatore.
— Ne ho due grossi mazzi presso un amico qui vicino; te ne regalerò un poco stassera, quando passeremo dinanzi al suo ovile per recarci ad Osilo. È meglio che noi partiamo sull’imbrunire.
— Certamente. Nella notte i latitanti viaggiano più sicuri!
Verso l’imbrunire presi commiato da mia madre e da mio fratello, e dissi a Salvatore che ero a sua disposizione.
Mia madre continuava a lagrimare, e mi seguì cogli occhi per un buon tratto di strada. Qualunque fosse l’esito della nostra gita notturna, la povera vecchia non poteva che addolorarsene. La sua anima così buona e così pia non faceva che pregare — pregare per me... e per gli altri. Ma che doveva io farci? Così voleva il mio destino.
Lungo il cammino io invocai colla mente la Beata Vergine perchè mi illuminasse la coscienza, rivelandomi se il mio compagno meritasse la morte. La coscienza mi rispose di sì, e fui tranquillo. [25] Raccomandai pure l’anima mia al Signore, nel caso in cui fossi rimasto soccombente.
Non ho mai trascurato simili pratiche religiose lungo il corso della mia vita. Ero stato sagrestano, e conoscevo la dottrina cristiana.
Camminammo entrambi per un’ora. Si era di gennaio, aveva nevicato, e la notte era molto fredda, quantunque non spirasse un alito di vento.
Tanto l’uno, quanto l’altro, badavamo a non darci mai le spalle.
Ci fermammo all’ovile di un comune amico, dove chiacchierammo per tre ore. Verso la mezzanotte ci rimettemmo in cammino. Salvatore doveva sentirsi contento, sapendosi mia guida e compagno per le terre del suo paese, di cui non ero abbastanza pratico. Per avventurarsi in un territorio quasi sconosciuto, bisognava nutrire cieca fede nel proprio compagno: condizione disgraziata di tutti i banditi!
Giunti a un certo punto in cui la strada si apriva fra due fitte macchie di lentischio, sentimmo le pedate del bestiame, che scappava al nostro avvicinarsi.
— Cammina piano e fa silenzio! — dissi al mio compagno.
— Perchè?
— Perchè questo è un punto in cui di frequente si appiattano i carabinieri. Io lo so!
— Tieniti pronto — soggiunsi, armando i [26] grilletti del fucile — io sono più esperto di te in queste faccende.
Salvatore montò anche lui i due grilletti del fucile, e stette all’erta colle canne abbassate.
— Sta attento a destra... io terrò d’occhio la sinistra. Oltrepassate le piante d’elce ci troveremo al sicuro.
Le tenebre si erano addensate, ma la strada era abbastanza chiara per il riflesso della neve.
Eravamo a Pala Montedda, in territorio di Ossi.
Si camminava sempre di conserva, a dieci passi l’uno dall’altro, ma sempre sbirciandoci colla stessa diffidenza e collo stesso intento sinistro. L’occasione era ghiotta per entrambi, poichè a lungo aspettata, e non dovevamo lasciarcela sfuggire. La vittoria è degli audaci.
Ad un certo punto mi fermai di botto, come in ascolto; e colla rapidità del lampo, puntando il fucile alla testa del mio compagno, feci fuoco.
Si udì una detonazione, e il sordo rumore di un corpo che stramazzava. Null’altro — non un gemito, non un sospiro.
Prima mia cura fu quella di ricaricare il mio fucile, appoggiando il calcio sul corpo del caduto; indi recitai un’Ave Maria ed un Requiem per il trapassato. Io ho sempre ucciso il corpo, non l’anima dei nemici; l’anima ce l’ha [28] data Iddio, e Dio deve riprendersela; il corpo è della terra, e alla terra deve ritornare[2].
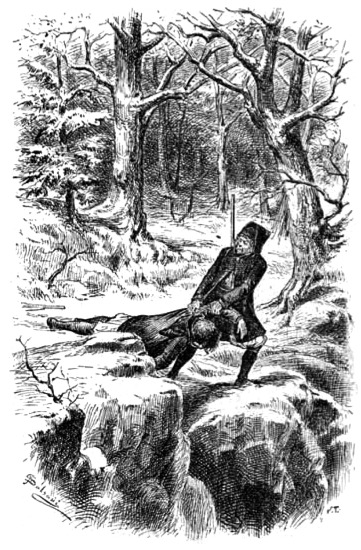
Recitata la preghiera, afferrai per un braccio il cadavere, lo trascinai per breve tratto, e lo lasciai cadere nello spacco d’una roccia vicina.
Dopo di che, coll’animo tranquillo, continuai tutto solo la mia strada.
Regnava in campagna il più profondo silenzio; non si vedeva anima viva. Nessuno mai seppe di quel duello a morte, avvenuto a mezzanotte in quella viottola deserta. Le piante d’elce e le macchie di lentischio furono i soli testimoni della scena di sangue.... ma mantennero il segreto![3]
***
Due giorni dopo compiuta la vendetta, io aveva insellato la mia cavalla, ed ero ritornato alla Nurra. Presentatomi all’ovile di Paolo Sechi, questi si fece alla soglia, e mi chiese con curiosità premurosa:
— Ebbene...?
[29]
— La cattiva pietra è tolta! — risposi — Speriamo, almeno per ora, che il buon muro non crolli!
***
La moglie di Salvatore Moro, non vedendo più ricomparire il marito, dopo due settimane ne aveva dato relazione alla polizia.
Un mese dopo, il pastore Antonio Giavesu riferì alla giustizia di aver rinvenuto un cadavere nel territorio di Ossi. Era stato spogliato da qualcuno, per appropriarsene le vesti.
Diverse autorità, i carabinieri, e i barracelli d’Ossi e di Florinas (fra i quali era mio fratello Giomaria) si recarono sul luogo per vederlo. Nato dubbio sull’identità dell’individuo, il pretore mandò a chiamare la moglie di Salvatore; la quale, dopo aver fissato il cadavere, diede in urli, esclamando:
— È lui!... è mio marito! L’uccisore non può essere stato che Giovanni Tolu!
Il pretore lasciò scapparsi alla presenza di tutti:
— Come sai, che fu Tolu? Dunque tuo marito gli faceva la spia!
Questa credenza era fondata nella popolazione.
Nel susseguente maggio, mentre mia madre trovavasi alla Grotta de Marmaru nell’ovile di [30] mio cognato Bazzone — in territorio di S. Gavino scapezzato — vi capitarono una signora ed un prete per chiedere un bicchiere di latte caldo. Essi affermarono di essersi trovati presenti nell’ufficio della pubblica sicurezza di Sassari, quando Salvatore Moro conferiva coll’ispettore, pronunciando più volte il nome di Giovanni Tolu. Era a cognizione di molti, che Moro avesse ricevuto in acconto ottanta scudi, incaricandosi della mia morte o della mia cattura.
[31]
Datomi alla campagna dopo l’attentato alla vita di prete Pittui, io non poteva dimenticare la Nurra, vasta regione che da giovinotto avevo visitato con frequenza, chiamatovi per i lavori del seminerio, per la mietitura, e per il raccolto del grano. Come ho già detto, ero salito in fama di uno dei più abili lavoratori di campagna. Le mie cognizioni agricole, il mio ardore, la mia instancabilità, mi avevano procurato la conoscenza di molti proprietari di terre e di bestiame. D’ordinario io veniva invitato come capo agricoltore, coll’incarico della scelta degli uomini adatti al lavoro; epperciò godevo d’una stima e fiducia illimitate.
Non potevo dunque dimenticarla, la Nurra, territorio accidentato, sicuro, adatto per i banditi, perchè ricco di montagne, di foreste, di macchioni [34] e di rifugi quasi inaccessibili ed inesplorati. I casali e gli ovili, posti a grandi distanze; i pastori ospitali e fedeli per indole; le rare visite dei carabinieri per la inaccessibilità dei luoghi, facevano della Nurra un soggiorno assai gradito ai latitanti del Logudoro e di altre regioni della Sardegna. Da tutta l’isola, infatti, vi accorsero in ogni tempo agricoltori, pastori, e banditi, i quali finirono per domiciliarvisi; e ciò si desume dai casati delle famiglie, molte delle quali rivelano l’origine degli abitatori — come i Bittichesu, i Rebecchesos, ed altri molti.
Sparsi per la Nurra saranno un 270 ovili circa; ognuno dei quali possiede in media un centinaio di rasieri di terra (circa 140 ettari).
Nei primi tempi che io vi andai (verso il 1845) la fama dei nurresi non correva troppo buona. Mi si disse dai più anziani, che non pochi lavoratori forestieri vennero uccisi dai proprietari, per non pagar loro alla fine dell’annata il salario dovuto.
Gli abitanti della Nurra erano protetti dai signori di Sassari; i quali assai spesso se ne servivano come bravi, massime nei tempi in cui più ardevano le inimicizie tra le famiglie cittadine.
La zona delle mie escursioni era ristretta. Il campo di azione era per me limitato ai soli territori della Nurra e di Florinas, ch’io conoscevo palmo a palmo. Mi spingevo qualche volta fino ad Osilo, a Sorso, o ad altri paesi lontani, [35] solo per compiacere i banditi coi quali mi univo. È consuetudine che l’uno serva di guida all’altro nel territorio del proprio paese.
Nei primi anni di banditismo, poco mi allontanai dal mio paese, dov’erano sparsi gli ovili dei parenti e dei fidi amici che mi soccorrevano, e dai quali potevo facilmente attingere informazioni su’ miei avversari, per affrontarli, o per sfuggirli. In seguito sbollì nel mio cuore il patrio entusiasmo. A Florinas non avevo più affetti; non avevo più nido, perchè me lo avevano distrutto i miserabili che giurarono la mia rovina. Più tardi la Nurra divenne la mia seconda patria, perchè in essa e a Portotorres erano concentrati tutti i miei affetti, come dirò nel corso della mia narrazione.
Anche fra i banditi vi sono i tristi, i miserabili, che vendono il proprio compagno, adescati dal lucro d’una taglia, o dalla speranza della propria impunità. Ma è cento volte da preferirsi il cader fulminato sotto le palle dei carabinieri, che viver libero, segnato a dito qual traditore e spia. D’altra parte questi tali non vivono sicuri neppure in libertà, poichè non tardano a cader vittima del proprio tradimento, per opera dei parenti del tradito.
Io posso dire di aver passato i miei trent’anni di banditismo fra le campagne di Florinas e quelle della Nurra.
La mia vita di bandito, in rapporto al soggiorno, [36] potrebbe dividersi in due distinti periodi. Durante il primo decennio mi fermai più a lungo nei dintorni del mio paese, facendo brevi soste nella Nurra, da me ritenuta come luogo di diporto e di villeggiatura. Nel secondo periodo, al contrario, feci brevi le soste nel territorio di Florinas, per fermarmi più a lungo nella Nurra, finchè la prescelsi a mia stabile dimora.
***
Come altrove dissi, mi esercitavo continuamente nella lettura. La storia dei Reali di Francia era fra i miei libri prediletti, e tuttora la conservo. Ho sempre letto con vivo piacere le avventurose gesta di Fioravante e di Buovo d’Antona; e confesso che esse eccitarono la mia immaginazione, contribuendo ad accrescere nel mio animo le ansie della lotta e del combattimento. Tutti gli altri libri, che in seguito lessi, erano dello stesso genere. I fatti d’armi m’inebbriavano.
Nelle mie prime gite alla Nurra, io visitava qua e là gli stazzi (casolari isolati) de’ miei vecchi amici, dov’ero accolto con molta cordialità, e dove trovavo conforti e soccorsi, che lenivano in parte le mie continue ambascie.
Nei famigliari colloqui con quella buona gente io dimenticava, almeno per brev’ora, le mie sofferenze e gli odî miei. Avevo bisogno di scambiare quattro parole con un mio simile, perchè [37] i ricordi dolorosi venissero con meno insistenza a martellarmi il cervello, e perchè i sogni di sangue turbassero meno le brevi ore del mio riposo. Il silenzio e la solitudine mi erano cari; ma io mi avvedevo che in seno ad essi fantasticavo troppo, diventavo più irrequieto, più irascibile, più feroce nei propositi di vendetta.
Quando mi trovavo solo — massime nelle fredde e tempestose giornate invernali — mi pareva che i miei pensieri nuotassero come in un lago di sangue; mentre invece quando mi trattenevo a scherzare colle donne e coi bambini dei pastori, dimenticavo di essere un fuggiasco maledetto, e mi pareva di vivere nel focolare domestico, insieme alla famigliola che avevo sognato. Raccontavo alle donne le barzellette, narravo ai pastori qualche passo della Storia sacra o dei Reali di Francia, e il tempo mi volava.
***
Il lungo ozio, mi aveva aguzzato la mente. Poco per volta mi ero perfezionato nella lettura e nelle nozioni popolari di medicina. Ero il medico della gente di campagna, perchè conoscevo la virtù di non poche erbe medicinali, e molti segreti per le cure, attinti all’esperienza.
Venivo chiamato con frequenza al letto degli ammalati, perchè conoscevo la febbre. Avevo sempre meco le lancette, e salassavo le donne [38] incinte e gli uomini di temperamento sanguigno; poichè a quel tempo il salasso era tutto; e quando l’uomo riusciva a cavarsi un po’ di sangue si credeva immune da qualunque malanno. Naturalmente io entrava negli ovili con circospezione, e tenevo sempre un occhio sull’ammalato e un occhio alla porta, poichè sapevo che i carabinieri non avevano troppo rispetto per l’uomo della scienza!
Le mie nozioni popolari di medicina e di chirurgia erano molte: tutte indispensabili ai banditi, i quali non possono ciecamente affidarsi alle cure di un medico.
Fra le altre cose, io era salito in fama per la guarigione delle fistole. Tagliavo un’erba che nasce nei luoghi umidi (da noi chiamata s’erva de sa rana, o de sus fistolas) pronunciando per tre volte il nome della persona ammalata; la facevo seccare al sole, la riducevo in polvere, e la somministravo per nove giorni di seguito al sofferente, sciolta nel caffè o nel brodo. Il difficile stava nel cogliere l’erba in tempo utile. Guai se si sbaglia il giusto punto della luna!
Parimenti famoso ero nella guarigione delle grosse piaghe alle gambe. Prendevo il femore di un uomo ucciso a malefizio; lo raschiavo, e ne applicavo la polvere sulla piaga. Consumato tutto l’osso, la persona era guarita. Non mi fallì mai una cura!
Narrerò in proposito un aneddoto.
[39]
Un giorno fui chiamato dal prete Matteo Sanna di Florinas, il quale camminava zoppo, a causa di molte piaghe alle gambe.
— Ti chiedo un favore — mi disse. — Tu che vai in giro per la campagna, e conosci tante vittime immolate per vendetta, devi procurarmi l’osso della gamba di un uomo morto di palla, o di pugnale. Ho bisogno di raschiarlo per guarirmi dalle piaghe che mi tormentano.
— Lei è prete — gli risposi — nè so se io possa, senza peccato, soddisfare al suo desiderio. Trattasi della profanazione di un sepolcro, e vorrei sapere se mi assolverebbe, se venissi a confessarmi da lei!
Il prete mi disse solennemente:
— Quando una cosa si fa per il bene, il bene uccide il peccato!
Gli portai l’osso desiderato, e il prete guarì. Questo buon successo mi rese più saldo nella mia convinzione[4].
Dirò un altro fatto. Venni un giorno chiamato a curare un certo tale, affetto da un grosso tumore al ginocchio. Sul tumore erano chiaramente segnati i due occhi, il naso e la bocca di una testa di morto. Interrogato l’infermo, egli mi confessò di aver avvertita l’enfiagione poco dopo di aver dato un calcio ad un teschio, capitatogli fra i piedi attraversando una viottola.
[40]
L’infermo e i parenti sapevano, al pari di me, che il rimedio infallibile era l’osso di un morto. Promisi di cercarlo, e indicai un posto in campagna per venire a ritirarlo.
Non dimenticherò mai quel giorno; poichè nel momento che consegnavo il femore ai tre amici dell’infermo, vidi a poca distanza da me quattro carabinieri immobili, che mi guardavano fisso. In due salti raggiunsi un’altura, dove mi seguirono i compagni. I carabinieri continuavano a piantarmi gli occhi addosso; ed allora feci loro segno colla mano di accostarsi. Per fortuna essi si allontanarono, dopo aver scambiato fra loro qualche parola. Mi persuasi quel giorno, che anche la professione di medico non va esente da pericoli!
***
Lo studio delle lettere mi tornava più gradito della medicina, poichè potevo coltivarlo con meno spasimi. Chiuso nel crepaccio d’una roccia, o sdraiato in mezzo a una folta macchia di lentischio, io leggevo stentatamente, ma con pazienza e molto piacere, i miei tre libri prediletti: l’ufficio della Beata Vergine, regalatomi del Rev. Dettori, rettore di Florinas; i Reali di Francia, che possedevo da lungo tempo; e una piccola Bibbia del Diodati, che avevo acquistata da un rivenditore ambulante di libri.
[41]
Ripeto dunque, che vivevo con piacere nella Nurra, dove meno erano i pericoli, e dove non mi mancava un po’ di svago, compreso qualche amoruccio, come narrerò in seguito.
Non tralasciavo, pertanto, di far frequenti gite al mio paesello natìo, quando sentivo il bisogno di rivedere la mamma e i congiunti, per cambiarmi la biancheria, o per chiedere notizie di nemici che non cessavano di tendermi insidie.
Le vendette da me compiute davano un po’ d’inquietudine ai miei compaesani, non esclusi i signori.
Comincierò dunque dal narrare le principali mie avventure nella Nurra, nonchè il risultato delle mie gite a Florinas, quando di tanto in tanto ero costretto ad andarvi.
[42]
Fu dopo il 1855, che mi determinai a fermarmi più a lungo nella Nurra di dentro.
Comunicata l’idea a mio cognato Ignazio Piana, che aveva colà molte conoscenze, egli mi raccomandò segretamente a un suo buon amico: certo Vigliano Masia, che aveva l’ovile nella regione di Fiume santo.
— Bisogna procurare, per alquanti giorni, un rifugio sicuro a Giovanni Tolu — gli disse.
— Vieni da me con lui sabato notte — gli rispose — ed io penserò a custodirlo.
Presentatomi a Masia con mio cognato, egli c’invitò a cena; poi mi accompagnò all’ovile di un suo cognato, dicendomi che ivi fossi rimasto tranquillo fino al suo ritorno.
Mi lasciò colà solo.
Nei dintorni di quella cascina abitavano diversi cugini di Masia; ed io andava a visitarli con frequenza, essendo tutti brava gente.
Dopo una diecina di giorni che rimasi fisso in quella cascina, Vigliano mi fece montare a [43] cavallo, e mi portò in giro per visitare gli ovili circonvicini. Gli amici comuni stavano sempre in vedetta, per avvertirmi quando scorgevano carabinieri in perlustrazione, o qualche nota spia che avrebbe potuto arrecarmi danno.
In quel frattempo io mi ero adoperato per assestare una vertenza sorta fra Vigliano e certi dispettosi suoi vicini, i quali da qualche tempo gli demolivano il muro di cinta d’una tanca. Scoperti da me i malevoli, e appianata la questione, mi cattivai la stima dell’amico.
Trascorsa così un’altra quindicina di giorni, Masia mi portò prima dell’alba nell’ovile di Paolo Sechi, suo compare di battesimo, e già intimo amico di Agostino Alvau. Picchiò alla bassa finestra con un segno convenzionale, e il pastore si alzò da letto per aprire la porta.
— Ti lascio quest’amico per dieci giorni — gli disse presentandomi — Verrò io a riprenderlo. Procura di custodirlo gelosamente!
Vigliano Masia, — che mi conduceva sempre di notte per non essere veduti — mi lasciò nell’ovile, senza dire a Paolo chi io mi fossi.
***
Rimasi alcuni giorni nell’ovile. Una sera mi addormentai, e feci un sogno, che mi rimase impresso nella mente, per le singolari circostanze che lo seguirono.
[44]
Sognai di trovarmi in riva al mare, vicino all’Argentiera, e propriamente nel luogo detto la Carazza grande, dove vidi un bastimento sfasciato, sulla cui prora era scritto a lettere grosse: Basto[5].
— Dentro a questo legno — pensai nel sogno — ci dev’essere qualche cosa di buono. Voglio entrarvi!
Montai sulla nave, col proposito di non accettare da bere da chicchessia, nel dubbio che mi si volesse avvelenare.
Mi trovai dinanzi ad una grande signora, a cui chiesi:
— Chi è lei?
— Sono la moglie del governatore di Basto. Per carità, non uccidetemi!
— Non vi uccido — risposi — ma datemi di quello che avete!
Mentre guardavo le tre sale sontuose che si offrivano in fila a’ miei occhi, vidi un signore sfarzosamente vestito e coperto di decorazioni, che le attraversò rapidamente. Egli si dileguò come in una nebbia.
Mi svegliai tutto agitato, ripensando alla mia visione.
Poco dopo fui chiamato a pranzo, e sedetti [45] a tavola coi padroni dell’ovile. — Paolo Sechi e sua moglie; Maria Antonia Dore — a cui narrai il mio sogno.
La sera di quello stesso giorno, proveniente dalla Stantarida, venne un servo, che disse a’ suoi padroni:
— Vostro compare vi prega di recarvi a visitarlo alla marina, poichè sulla spiaggia della Carazza grande trovasi un grosso barco sfasciato, là buttato dalla tempesta.
Ci guardammo in viso meravigliati. Paolo Sechi mi disse:
— Ma questo è il tuo sogno avverato!
— Andiamo insieme a vedere il barco — esclamai — Non sono mai stato da quelle parti.
Si partì tutti alla volta della Carazza grande, dove giungemmo a notte.
La mia meraviglia crebbe, quando mi accertai che la località era quasi identica a quella da me veduta in sogno. Fu questo uno dei fenomeni che più mi abbiano colpito nella vita, nè giunsi mai a spiegarmelo[6].
Era un legno a tre alberi, pendente da un fianco, vicino al quale stavano due barche algheresi, in cui erano sei o sette individui.
Spintomi fino all’alta roccia, quasi a picco [46] sul mare, puntai il mio fucile in direzione delle barche, e gridai forte:
— Venite a terra, o vi brucio uno per uno! Voi siete i ladri, e poi riferirete che il bastimento fu spogliato dai pastori della Nurra!
— Ch’io possa morire, se siamo ladri! — gridò uno dalla barca a me rivolto — Siamo in compagnia del vice console d’Alghero.
— Venite tutti da noi per provarcelo! — soggiunsi a voce alta — altrimenti vi faccio fuoco addosso!
Vennero allora a farsi riconoscere; e in seguito le due barche si portarono ad Alghero, per dar rapporto che i pastori nurresi avevano loro fatto resistenza, perchè il pistacchio (di cui era carico il legno) non venisse derubato.
Il vice console ordinò allora a due guardie di finanza di pernottare nell’ovile più vicino al mare, per poter di giorno meglio sorvegliare lo scaricamento del legno, incagliato sulla spiaggia.
Le ondate del mare avevano trasportato a terra una grande quantità di pistacchio. Alcune barche algheresi, due giorni prima, avevano rubato dal bastimento tutto lo zucchero, il caffè e molta tela.
Mentre ogni notte le due guardie se ne stavano tranquille nell’ovile a conversar colle donne, non pochi pastori si portavano alla spiaggia, per trasportare coi cavalli il pistacchio, che nascondevano dentro i macchioni, all’insaputa dei sorveglianti. [47] Avevamo appreso dalle stesse guardie, che quel frutto valeva a 15 scudi il quintale; e perciò si era riuscito ad accumularne nelle macchie per oltre 12 rasieri.
Ci eravamo pure accorti, che le due guardie, per proprio conto, facevano anch’esse man bassa su molti effetti appartenenti al bastimento. Un legno naufragato appartiene alla spiaggia su cui viene sbalzato dalla tempesta, e perciò ciascuno ha diritto alla preda[7].
La notte susseguente si scatenò un violento uragano. Il vento soffiò orribilmente da mezzanotte all’alba, e il mare mandava i ruggiti di un toro.
Io rimasi nel crepaccio di una roccia, in compagnia di alcuni pastori; altri tornarono alle loro capanne per custodirvi il bestiame.
Il vento impetuoso sbatteva il legno alle roccie, e il chiasso infernale non mi lasciò chiudere occhio in tutta la notte. Pareva un finimondo.
Verso le due dopo mezzanotte mi affacciai alla roccia. Pioveva a dirotto, e le ondate schiumose si frangevano con fragore agli scogli sottostanti. Il legno, a dieci metri dalla spiaggia, [48] si dondolava scricchiolando, ed aveva i fianchi aperti.
Poco prima dell’alba, insieme a cinque pastori, scesi fino alta spiaggia. Il mare era ingrossato, e vedevo galleggiare sui marosi, di qua e di là, alcuni pezzi quadrati, come piccoli bauli. Quei dadi curiosi uscivano ad uno ad uno dal fianco squarciato del bastimento, nè sapevo che cosa fossero.
Mi levai le scarpe, rimboccai i pantaloni all’altezza del ginocchio, ed entrai piano piano nell’acqua. Giunsi ad afferrare uno di quei dadi, che erano ricoperti di tela ben cucita. Tagliai con un coltello l’involucro, e mi accorsi che contenevano grossi pani di cera.
Poco mancò che io non fossi travolto dalle onde furiose. Due altri pastori, che erano entrati con me nell’acqua, sorpresi dai cavalloni, si videro perduti. Feci in tempo ad afferrarli per la mano, e guadagnammo la spiaggia.
Da solo, quindi, con molto coraggio e altrettanta pazienza, giunsi a tirare a riva una quindicina di quei grossi dadi di cera. Dieci ne nascosi accuratamente accanto ad uno scoglio vicino, collocandovi sopra grossi macigni; e cinque ne portai meco in vicinanza dell’ovile.
Uno dei pastori, mio compagno nella pirateria, mi sbirciava con occhio torvo e diffidente. Più tardi egli stesso mi confessò, che aveva temuto che io lo uccidessi in quel luogo deserto, per appropriarmi dell’intiero bottino.
[49]
Fui invece giusto. Eravamo in sei, e divisi la cera in sette parti uguali, assegnandone una ai padroni dell’ovile, ch’erano povera gente. Gli altri miei compagni si opposero vivamente, e vollero divisa fra essi anche la settima parte. Allora regalai una ventina di libbre di cera al proprietario dell’ovile, togliendola dalla mia porzione. Speravo, d’altronde, di rifarmi dal deposito di cera, che avevo nascosto nella spiaggia, sotto alle grosse pietre.
Corsi sull’alba allo scoglio per ritirare gli altri pani di cera; ma un nuovo uragano, sopravvenuto nella notte, me ne aveva portato via oltre la metà.
Vendetti più tardi la mia porzione di cera ad un prete di Florinas, e ne ricavai quasi cento scudi. Ne avrei avuto più di 200, se il mare furioso non fosse stato più ladro di me.
Prima di comprare da me la cera, il prete florinese volle spezzare i pani colla scure:
— Se vi è deposito di danaro — egli mi disse — sarà tuo; ma se vi è qualche pietra, io non voglio pagarla a prezzo di cera!
I timori del prete non erano infondati. Era tradizione, che una volta fu trovato un grosso pane di cera sulle spiaggie della Nurra, dentro il quale si rinvennero 3000 lire in marenghi, nascostivi per precauzione. Parimenti era noto, che un’altra volta un parroco aveva trovato una grossa pietra in un pane di cera, vendutogli da un bandito.
[50]
***
Il pistacchio non fu per noi rimuneratore al par della cera. Allettati dal prezzo di 15 scudi al quintale, tentammo di metterlo in commercio; ma la merce era troppo sospetta, e i pochi salumai e confettieri di Sassari, cui l’offrimmo, non vollero acquistarne. I dodici rasieri di pistacchio finirono per esser dati in pasto ai porci della Nurra; e certo nessun maiale d’Europa ebbe la fortuna principesca di essere ingrassato con quel frutto prezioso!
Durante il tempo in cui le guardie si fermarono sulla spiaggia della Carazza grande, per sorvegliare il legno naufragato, io rimasi con esse, spacciandomi per un porcaro della Nurra. Ero armato del solo fucile, perchè avevo nascosto in una macchia pugnale e pistola, per non destar sospetto. Le trattenevo spesso col tiro al bersaglio, per dar agio ai pastori di rubare il pistacchio.
Devo notare, che la famiglia di Paolo Sechi, a cui ero stato raccomandato, non disse mai ad alcuno ch’io mi fossi, ma mi presentava come un camparo. Ero molto conosciuto nella Nurra di Portotorres, dove avevo lavorato, ma pochissimo nella Nurra di dentro, e niente verso la spiaggia occidentale.
Le generose guardie, avevano permesso ai pastori di ritirare dal bastimento molto cordame, [51] utilissimo per i carri; ma non si erano mai accorte, che la loro fiducia era mal ricompensata.
Segnalo un curioso aneddoto.
Un giorno una di esse, che aveva preso a volermi bene, mi chiamò da una parte, e mi diede molte manate di pistacchio, dicendomi:
— Te ne faccio un regalo.
— A che servono questi semi? — le chiesi facendo l’idiota.
— Son buonissimi a mangiare. Con essi si fanno i confetti più fini.
— Vi ringrazio tanto! — risposi ipocritamente.
Quel credenzone non sospettava neppure, che a quell’ora io avevo prestato mano a rubargliene dodici rasieri!
Trasportato in Alghero tutto il carico, il legname, e gli attrezzi del barco naufragato, le due guardie presero commiato da noi, incantate dell’ospitalità dei nurresi, e liete di aver tutelato con coscienza gli interessi d’una nazione straniera!
***
Non sono d’altronde rare queste avventure nella Nurra. I pastori, che hanno gli ovili verso la costa occidentale, ricevono assai spesso i regali del mare; poichè le onde inferocite gettano di frequente su quelle spiaggie gli avanzi dei legni naufragati. Dopo una tempesta, non trascurano [52] i pastori la visita ai littorali, per portare a casa grosse tavole, antenne, ed altri attrezzi marinareschi. Conosco diverse capanne, la cui travatura è formata da antenne e pennoni vomitati dal mare.
Ricorderò, a proposito, un altro curioso episodio. Recatomi una volta ad esplorare le spiaggie, in compagnia di due pastori amici, rinvenimmo la carcassa di una grossa barca, incastrata fra due scogli. Penetrati dentro, non vi trovammo che una lunga catena, che dividemmo in tre parti uguali.
Rientrato all’ovile, che mi aveva ospitato, e chiestomi se avessi nulla rinvenuto, risposi scherzando alla moglie del pastore:
— Sì: abbiamo trovato ciò che meritiamo.
— Che cosa?
— Un pezzo di catena!
[53]
I banditi in generale, e in particolare quelli della Nurra, furono sempre avvicinati e protetti dai signori di Sassari, solo perchè questi, alla loro volta, speravano di essere spalleggiati nei loro odî e rancori di parte.
Erano tempi di lotta e di rappresaglie, e si aveva bisogno del braccio forte dei fuorusciti.
Nei primi anni che mi diedi alla macchia (verso il 1850) ogni partito aveva a disposizione i propri bravi per servirsene al bisogno. Ond’è che la protezione dei signori non tornava che a danno dei latitanti, poichè accendeva non di rado fra banditi e banditi una gara accanita, che si risolveva colle fucilate. Non si aveva talvolta altra ragione d’odio, che quella dei propri protettori. I banditi sposavano i dispetti ed i risentimenti altrui, con soddisfazione della giustizia; la quale si compiaceva di vederci distruggere l’un l’altro, senza mettere a repentaglio la vita dei carabinieri, e senza sborsare denaro per pagare le spese.
[54]
Abbiamo veduto la protezione di Cambilargiu pagata cara a Monte Fenosu; e potrei accennare ad altre persone ragguardevoli di Sassari, che coprivano altissime cariche.
L’amicizia dei signori ci tornò sempre fatale, ed è perciò che in ogni tempo ne diffidai. Conoscevo troppo quelli del mio paese! Legati talvolta a noi dalla sola paura, cercavano segretamente il mezzo per poterci distruggere. Io li odiavo, ma cercai di non inasprirli; li volevo male, ma li trattavo bene perchè non maltrattassero i miei congiunti di Florinas.
Non ci fidavamo neppure degli avvocati; poichè essi non difendono che i propri clienti, accusando talvolta il bandito avversario per il trionfo della propria causa.
Curiosi misteri che potrei rivelare! Oh, quanti porcetti, rubati al povero, comparvero alla mensa dei nostri avvocati! Quanti barbari omicidî commessi colla polvere e le palle regalateci dai nostri generosi protettori!
***
Fra gli uomini più ragguardevoli della Nurra, per ingegno, ricchezza e aderenze, era Antonio Careddu, che conobbi fin dai primi anni che mi diedi alla macchia. Dirò di lui quanto so per mia coscienza, o per narrazione fattami da pastori e compagni miei di esilio.
[55]
Antonio Careddu, di Sassari, era cognato di Giovanni Macioccu, avendo costui sposato una sua sorella. Stava nella Nurra, perchè comproprietario (insieme alla sorella) di tre buoni ovili: Guggiareddu, Guggia manna e il Calzolaio.
Antonio Careddu era un repubblicano, amico e compagno di Antonico Satta, insieme al quale aringava il popolo a Baddimanna ed altrove. Era stato studente, e ne sapeva più di un avvocato. Alla Nurra si andava tutti a consultarlo, ed egli ci affascinava colla calda parola e colla saggezza de’ suoi consigli, sempre giusti, retti, inappuntabili.
A Sassari erano allora due forti partiti: quello del vecchio sistema che aveva per bravi i fratelli Saba — e quello del nuovo governo, che aveva per difensori i Careddu e suoi congiunti[8].
Partito Antonico Satta per il continente, fu sostituito da Antonio Careddu per continuare le prediche rivoluzionarie. Dalla politica, che poco intendevamo, gli odî scivolarono nei rancori privati, accendendo le inimicizie fra diversi gruppi.
Ciccio Saba pretendeva, che la figliuola di Antonio Careddu fosse data in moglie al proprio [56] figlio — quasi a base di una pace che avrebbe fatto cessare le ostilità fra le due famiglie.
Antonio Careddu diceva con disprezzo:
— Ho capito: io dovrei dare mia figlia ai sicari Saba, per servirsene più tardi a portar loro il pane in carcere, quando saranno arrestati! Tutt’altro che la mia figliuola concederò ai Saba, se non metteranno giudizio!
Il rifiuto reciso inasprì Ciccio Saba, che si dichiarò nemico dei Careddu.
I Saba, falegnami costruttori di molini ad olio e di farina, erano stabiliti a Sassari, e speravano sulla protezione di persona influente presso la giustizia come magistrato.
Antonio Careddu si unì allora ai mugnai fratelli Vacca, osilesi, i quali un giorno chiamarono i quattro Saba, padre e figli, per accomodare un loro molino, situato verso Logulentu. Aggiustato il molino, come d’intelligenza, i Vacca, dopo il pranzo loro offerto, proposero il tiro al bersaglio, per passare la sera. Lo scopo non era altro che di far consumare le munizioni di polvere e di palle agli avversari.
Terminato il divertimento si apprestarono tutti a far ritorno a Sassari.
Antonio Careddu, con dodici uomini, si era impostato verso Baddimanna, aspettando il passaggio della comitiva.
I figli Saba, prevedendo qualche brutto tiro lungo la strada, attraversarono gli oliveti saltando [57] i muri. Il padre Ciccio, insieme ai Vacca e ad altri, avevano invece preso la viottola.
Ciccio Saba, che era alto di statura, esplorava di qua e di là gli oliveti, dubitando di qualche tranello. Come scorse gli uomini appiattati, si diede a gridare rivolto ai figli:
— Guardatevi, chè siamo morti!
E in così dire fece fuoco, uccidendone uno, certo Luzzu, pastore di Antonio Careddu.
Avvenne allora un terribile conflitto, in cui rimasero uccisi Antonio Delogu (servo di Luzzu) e Salvatore Saba. Due fratelli Vacca inseguiti dai Saba fino a Porta Rosello, furono feriti entrambi, come fu ferito gravemente Ciccio Saba, che in seguito guarì.
I Vacca, Giovanni Saba e qualche altro vennero arrestati.
***
Ma Antonio Careddu non era ancora soddisfatto, e pensò di distruggere i Saba superstiti, servendosi di certo Antonio Desini di Ploaghe, capo di una compagnia di sicari. Altro capo sicario volle Giovanni Macioccu, cognato di Careddu, e combinò con un certo Giacinto. Il primo di essi, Desini, si associò a certo Biddisò — il secondo, Giacinto, scelse per coadiutore un tal Cabriolu, già studente.
Il colpo doveva eseguirsi la mattina del lunedì [58] di carnevale, all’uscita del ballo del Teatro civico.
Fu concertata la posta all’imbocco della Via dei Corsi, prospiciente al vicolo di S. Andrea, dov’era la casa di Saba.
Come Ciccio Saba e i suoi figli, di ritorno dal teatro, giunsero dinanzi alla chiesa, i congiurati fecero loro fuoco addosso in mezzo alla folla che transitava nel Corso. Giovanni cadde fulminato, e Gavino morì poche ore dopo. Fu pur colpito a morte, accidentalmente, il figlio settenne del fabbricante di paste Dionisio, che trovavasi nel suo magazzino.
Della famiglia Saba non rimaneva che il padre Ciccio e il più giovane dei figli. Furono offerti cento scudi per togliere quest’ultimo dal mondo, ma i sicari si rifiutarono, ritenendolo troppo giovine[9].
***
L’agguato ai Saba era stato veramente ordito e condono a termine da Desini, da Biddisò e da Cabriolu; tuttavia Giacinto si era affrettato a presentarsi in casa di Macioccu, il quale gli sborsò subito i 300 scudi, prezzo convenuto per l’eccidio consumato.
[59]
Trascorso qualche giorno, il sicario Desini si presentò allo stesso Macioccu per essere pagato.
— Ho già versato la somma all’autore del colpo! — gli rispose.
— Il colpo è stato eseguito da noi, e perciò io credo non abbiate sborsato somma alcuna ad altri. Pagateci!
Macioccu, dopo essersi rifiutato ad altro pagamento, volle consultarsi con suo cognato Antonio Careddu, che trovavasi nel suo ovile della Nurra.
Non tardarono a recarsi colà Desini, Cabriolu e Biddisò, i quali si fecero accompagnare dal bandito Pietro Cambilargiu.
Come Macioccu li vide venire, voleva spararli addirittura; ma Careddu lo calmò, persuadendolo a lasciar loro esporre le ragioni.
Dopo aver persistito nell’affermare il pagamento già fatto, Antonio Macioccu finì per rivelare il nome di Giacinto, a lui presentatosi come capo sicario ed autore dell’eccidio dei fratelli Saba.
— Possiede nulla questo Giacinto? — domandò Desini.
— Possiede un oliveto a Sassari.
— Ebbene, allora ci farete il piacere di chiamar costui con un pretesto nella vigna. Noi ci nasconderemo dentro la casa rustica, e voi lo interrogherete. Alla nostra presenza egli vi rivelerà i veri autori dell’agguato. Lo costringeremo allora a firmare un atto d’ipoteca sul suo oliveto, [60] a risarcimento del danno recatoci coll’indebita appropriazione.
Antonio Careddu approvò il ragionamento dei tre sicari; ma Macioccu esternò il sospetto che essi avrebbero ucciso Giacinto.
— Dubbio puerile! — osservò Desini — Finchè non siamo soddisfatti del nostro avere, ci diventerà più cara la sua vita!
Fu accettata la proposta. Nascostisi i tre bravi nella casetta della vigna, Macioccu trovò mezzo di attirarvi Giacinto, invitandolo a declinare i nomi de’ suoi complici, col pretesto della riconoscenza.
Accortisi che il sicario esitava a rispondere, i tre compagni sbucarono dal nascondiglio:
— Dillo dunque: chi ha fatto il colpo?
Giacinto impallidì, e confessò di non aver preso parte all’uccisione dei Saba.
— Restituisci, dunque, il danaro preso!
— Non l’ho più.
— Ma l’oliveto, ce l’hai ancora?
— Sì.
— Sei disposto a sottoscrivere lo strumento di cessione?
— Dispostissimo!
Venne in seguito firmato l’atto notarile, col quale Giacinto vendeva l’oliveto a Macioccu.
Fatta la cessione, quest’ultimo sborsò altri 300 scudi a Desini, a Cabriolu ed a Biddisò, i quali finalmente si dichiararono soddisfatti.
[61]
Questa storiella, da molti ignorata, mi venne riferita da alcuni degli interessati e da Cambilargiu.
***
Antonio Careddu — ricercato dalla giustizia dopo l’assalto di Baddimanna — si era dato a fare il bandito nella Nurra.
Lo conobbi di persona, gli ero molto amico, e gli fui compagno di ventura per alcuni mesi.
Egli si recava da un ovile all’altro, si dilettava di caccia, e faceva il signore. Era un uomo piuttosto pingue e molto frugale; non beveva mai vino, nè liquori, ma prendeva il caffè tre volte al giorno. Si faceva portar tutto da casa, poichè aveva molto bestiame ed estesa proprietà.
Era ben voluto, stimato e rispettato dai pastori, poichè nè sapeva più di un avvocato. Lo consultavano tutti, e i suoi consigli erano seriamente apprezzati. Contava moltissimi amici fra i signori di Sassari, ed era in buoni rapporti coi nobili, e specialmente col marchese di Sant’Orsola.
Egli venne arrestato nell’ovile della Stantarida da dodici carabinieri, fra i quali erano il maresciallo Scaniglia e certo Pietro Puzzone, già carbonaio della Nurra e pratico di tutti gli ovili. Dicevasi che quest’ultimo si servisse dei parenti per facilitare le ricerche dei latitanti in quella regione.
[62]
Messo in carcere Antonio Careddu, non si tardò a fargli il dibattimento; ma per i molti amici che contava a Sassari, e per la sua buona condotta, venne assolto e rimesso in libertà.
Un suo amico calzolaio — certo Salvatore, condannato a molti anni di galera — gli aveva raccomandato la moglie... ch’ei fece propria. La moglie vera ed i figli di Antonio Careddu passarono allora sotto tutela della zia — sorella di lui e moglie di Macioccu.
Per questa sua condotta un po’ libertina, e per essersi separato dalla famiglia, Careddu fu abbandonato dagli amici signori di Sassari, i quali non ebbero per lui stima, nè riguardi di sorta.
Antonio Careddu visse molti anni nella Nurra consultato anche per questioni legali, tanto era d’ingegno.
Salvatore, intanto — il calzolaio che gli aveva affidato la moglie — era ritornato da galera. Appresa la tresca della sua compagna, meditò l’uccisione del falso protettore e dell’amico infedele.
Questo Salvatore aveva per compare di battesimo certo Baingio Deroma, un pastore sfacciato, che di frequente faceva pascolare il proprio bestiame nelle terre di Antonio Careddu. Costui lo pregava di dargli almeno qualche piccolo compenso, ma quegli faceva il sordo.
Un altro pastore vicino d’ovile — certo Giovanni [63] Luigi Manunta — imitando Deroma, introduceva il suo gregge nei tenimenti di Careddu, e questi tornò a dolersene con entrambi:
— Pagatemi almeno una trentina di scudi all’anno. Anch’io ho diritto di trarre qualche lucro dalle mie terre, nè parmi giusto che voi approfittiate del mio pascolo senza offrirmi compenso alcuno.
Consultato dai contendenti, io diedi piena ragione a Careddu, poichè il danno che gli recavano i due pastori oltrepassava i cento scudi, mentre l’amico era discreto nel domandarne soli trenta.
Manunta e Deroma promettevano di risarcire il danno, ma non pagavano mai.
Un giorno Careddu, inasprito più del solito, minacciò di far loro pagare la contravvenzione.
I due pastori vollero cogliere l’occasione, e concertarono di liberarsi del creditore importuno.
Vicino agli ovili di Manunta e di Deroma abitava un giovane — certo Gio. Andrea Ilde — il quale faceva all’amore colla figliastra di quest’ultimo.
— Se riuscirai ad uccidere Antonio Careddu — gli disse Deroma — ti darò in moglie la mia figliastra.
— Solo non mi attento: aiutami tu!
— Andremo insieme. Dopo che l’amico sarà ucciso, ti manterrò la promessa!
Si unirono, infatti, e diedero la caccia a Careddu, che tolsero di mezzo con una fucilata.
[64]
Il giovane Ilde fu preso dalla paura e si diede subito alla macchia; Deroma stette sul sospeso, fra il bandito e l’uomo libero. Entrambi vennero arrestati.
Mentre batteva la campagna, Gio. Andrea Ilde mi pregò più volte di prenderlo in mia compagnia; ma io lo tenni sempre lontano per aver ceduto ai consigli di Deroma. Acciecato dall’amore, egli si era lasciato trascinare ad un’azione indegna.
Il potente partito di Deroma, colle deposizioni in tribunale, seppe aggravare la causa di Gio. Andrea Ilde, scagionando il compagno; ond’è che questo fu assolto, e il giovane fu condannato alla galera in vita. Solite cose della giustizia!!
L’uccisione di Antonio Careddu non fu che una vigliaccheria. Quest’uomo non meritava simile fine, perchè era buono ed aveva tutte le ragioni del mondo.
Il calzolaio tradito aveva vendicato il suo onore, senza compromettere la propria libertà!
[65]
La vita randagia del bandito, l’ozio continuo, le visite frequenti a questo e a quell’ovile, fanno sì, che più degli altri egli senta il bisogno dell’amore.
Ho già detto che in nessun tempo la donna mi ha allettato; ed anche da giovinotto preferivo l’esercizio delle armi ai balli ed alle chiacchiere colle forosette.
Datomi alla campagna dopo l’attentato alla vita del prete, e inasprito per l’abbandono dell’ingrata che avevo scelto per compagna, provavo quasi ripugnanza a intrattenermi colle donne, che io trovava negli ovili, nei molini, o nelle aie.
Durante i primi mesi di latitanza avevo appreso, dall’esperienza de’ miei compagni, quanto la donna e gli amori riuscissero fatali al perseguitato dall’umana giustizia. È nel nido d’amore che si colgono più facilmente le belve; e i carabinieri lo sanno. Non pochi banditi caddero in questa rete, ed io ben lo sapeva. Chi ha un’amante ha una spia, e la sua perdizione è certa. [66] La donna, o per gelosia, o per vendetta, o per leggerezza, assai di frequente getta il suo amante fra le braccia della giustizia. La forza non deve mai darsi in braccio alla debolezza. Sono più pericolose le lusinghe e le moine d’una donna, che le manette dei carabinieri; da queste possiamo spesso liberarci, da quelle mai: bisogna soccombere!
Io sorrideva, ogni qual volta vedevo Cambilargiu, Spano e Derudas correre audacemente in cerca di donne, e fidarsene tanto! Non solo mi guardavo dall’imitare i miei compagni, ma badavo di non accompagnarli mai in questo genere di conquista. Mi sottraevo sempre con un pretesto.
La donna si affeziona facilmente al bandito. Non si può immaginare il fascino che sulla loro immaginazione esercita il coraggio, la forza, l’audacia di questi uomini erranti, che gettano lo spavento nelle popolazioni. Non si ha mai migliore amico e protettore di una donna — ma più grande è il loro attaccamento, più grande è il pericolo di essere tratto in arresto.
Non è vanto il mio; poichè non fui più fortunato degli altri. Ci troviamo più spesso nel caso di fuggire l’amore, che di andarlo a cercare. Non c’è bandito che non abbia la sua amante; e quasi tutte, d’ordinario, sono le mogli degli altri. I molini e gli ovili, in modo speciale, sono quelli che a noi forniscono queste innamorate.
[67]
Ben difficilmente un bandito fa relazione con una ragazza, se non è per sposarla. Le vedove sono quelle che più ci tentano e più ci danno l’assalto.
Non ancora trentenne, pieno di slancio e di fuoco, anch’io dovetti pagare il mio tributo all’amore — anzi a più amori; e devo subito confessare, che non fui mai fedele, nè costante. Ogni ovile ed ogni molino, dove capitavo per caso, era il mio ritrovo d’amore; ed io rivedevo l’amante ogni settimana, ogni mese, ed anche ogni anno, se l’occasione di avvicinarla non si presentava spontanea. L’idea fissa di un tradimento, di un agguato, di una sorpresa bastavano per frenare i miei bollori e per rendermi cauto; onde posso dire, che nella mia lunga carriera di bandito, per trent’anni, non ebbi mai a lamentare alcun disguido, nè alcun pericolo per causa di una donna. Ho avuto più fastidi assistendo agli amori degli altri, che agli amori miei; e ne avete le prove nell’episodio della vedovella di Derudas, da me narrato.
Sono molte le avventure amorose capitatemi nei primi dieci anni di vita randagia (dai trenta ai quarant’anni) — in seguito misi giudizio, e abbandonai del tutto la donna, poichè fui sempre per natura serio, riflessivo, e mi pareva cosa puerile correr dietro ad una gonnella. La mia dignità ne soffriva in faccia a’ miei compagni.
Dirò di un’altra fissazione. Mentre tutti [68] i miei compagni narravano con un certo orgoglio i loro casi amorosi, le avventure, le conquiste delle mogli altrui, io ridevo con loro, scherzavo, ma mai risposi con pari confidenza. Nessuno mai seppe le mie peripezie d’amore, nè mai dal mio labbro sfuggì il nome d’una donna che mi aveva amato. A me sembrava vigliaccheria denunziare o compromettere una debole creatura, la quale forse non aveva ceduto che alla forza delle nostre lusinghe, od alla paura! Conobbi banditi prepotenti (fra i quali Cambilargiu) che chiedevano amore ad una moglie altrui, minacciando di ucciderle il marito se si mostravano scortesi. Se l’amore veniva, io lo coglieva senza rimorsi; ma certo non lo provocavo, per non pagare d’ingratitudine il pastore a cui dovevo asilo e protezione.
***
Diversi casi mi capitarono, ma non mi fermerò sui particolari, poichè mi ripugna rivelarli. Accennerò di volo ad alcune avventure, oltre a quella di Maddalena, la cui relazione ebbe più lunga durata.
Mi trovavo, un giorno, chiuso in una casa di Florinas, il cui padrone era un vecchio che aveva moglie giovane. Mi avevano nascosto al pian terreno. Due figlie del padrone, di primo letto, entrambe maritate, venivano con frequenza [69] a visitare la madrigna e a veder me. Un giorno mi trovai solo con una di esse, e le rivolsi una galanteria.
— Sta attento per la mamma! — ella mi disse dolcemente, incoraggiandomi a continuare la corte.
Il marito era lontano, nella sua fattoria; e la chiusa dell’avventura fu, che ella mi invitò in sua casa, e mi dichiarò che un bandito disgraziato le aveva sempre destato una pietà profonda...
Un altro giorno mi trovavo in un ovile di fiducia, dove solevo recarmi di tanto in tanto. Si era tutti intenti a tosare le pecore; e il padrone, dopo avermi offerto un bicchierino d’acquavite, tornò fuori al lavoro co’ suoi compagni. Mi buttai sul letto perchè mi sentivo stanco ed avevo bisogno di riposare.
Mentre me ne stavo così sdraiato, tra veglia e sonno, entrò pian piano la moglie del pastore, e chinandosi dolcemente verso di me, mi domandò se mi sentissi male. Risposi di no; ed ella allora mi baciò due volte sulle guancie e scappò via.
Fu questa l’introduzione di un romanzetto che durò più mesi.
Un’altra volta avevo bisogno di passare una notte a Florinas per appurare certi miei sospetti. I due giovani figli di una vedova trentenne mi portarono in casa della madre, dove venni nascosto fino al tramonto del giorno successivo. [70] La vedovella s’interessò vivamente della mia sorte, volle conoscere alcuni episodi della mia vita, e fra noi due si stabilì una tenera relazione, che durò per molto tempo, quantunque a lunghi intervalli.
Queste avventure si ripeterono con molta frequenza, e si rassomigliavano tutte. Anche la Nurra non mi fu avara di amori. Ivi ebbi rapporti amichevoli per moltissimo tempo con la giovane moglie di un pastore, che faceva il soldato in continente.
Ebbi altra relazione con una donna, il cui marito si assentava spesso dall’ovile; ma questa mi creò qualche fastidio, come dirò a suo luogo.
Vedete dunque che le vedove e le maritate erano abitualmente le mie pietose confidenti!
***
Tacendo di tanti altri episodi galanti della mia vita di bandito (comuni a tutti i miei compagni d’infortunio) narrerò la mia ultima avventura, che lasciò più grata e più profonda impressione nel mio animo, per la tenacità dell’affetto col quale venni corrisposto.
Frequentavo nella Nurra l’ovile di un pastore proprietario, il quale aveva in casa una figlia giovane e bella, vedova da un anno. La sua taglia elegante, i suoi lineamenti delicati, il suo volto bianco e roseo (che sotto al nero [71] fazzoletto mi sembrava quello di una madonnina addolorata) mi avevano profondamente colpito. Io mi tratteneva volentieri dentro quella capanna, dove pur convenivano altre donne e qualche vecchio pastore degli stazzi vicini.
O dinanzi al focolare, nelle sere invernali (mentre qualche servo faceva al di fuori la guardia); o seduti nel boschetto vicino, nelle sere d’estate, io raccontavo le peripezie della mia vita: le persecuzioni di prete Pittui, l’ingratitudine di Maria Francesca, i fatti di Nuzzu o di Monte Fenosu. Gli astanti mi ascoltavano con religioso silenzio, e prendevano diletto ai miei racconti
La giovine vedovella (non ancora ventenne), colla bocca aperta, e co’ suoi grandi occhioni fissi ne’ miei, era la più attenta di tutti, e tratto tratto sospirava, asciugando qualche lagrima.
Quella donna aveva preso gusto a’ miei racconti, e appena entravo nella capanna mi si sedeva vicina, mi fissava con tenerezza, e mi pregava di narrare qualche barzelletta.
Soddisfatto, non so perchè, dell’attenzione che mi prestava quella bambina vedovella, io metteva tutto il mio impegno nell’infiorare le mie storielle, facendo pompa di tutta la mia erudizione, appresa dai pochi libri che avevo letto.
Per non parlar sempre de’ miei casi, cominciai col narrare le avventure di Fioravante, il figlio del re Fiorello, nato con una croce di sangue sulla spalla destra. Dissi dell’insulto fatto al suo [72] maestro Salardo, a cui tagliò la barba; della sua condanna a morte, commutata poi nel bando.
Io sapevo a memoria tutto il libro dei Reali di Francia; e quelle avventure gloriose di Fioravante (bandito al pari di me) commovevano alle lagrime la vedovella. Ella mi guardava fisso fisso quando narravo con enfasi le prove di valore del figlio del re Fiorello, il quale aveva liberato la bella cugina da tre saraceni che l’avevano rapita; oppure quando le raccontavo come Dusolina e Galerana si erano innamorate del giovane valoroso, e come l’ultima ne era morta di dolore. La vedevo impallidire, quando raccontavo come la bella Drusiana, figlia del re Erminione, si era pazzamente invaghita del prode Buovo di Antona, ucciso a tradimento dal proprio fratello Galione, mentre pregava in una chiesa.
Un altro giorno erano gli amori di Rebecca che io narravo; oppure il dolore di Giuseppe, venduto da’ suoi fratelli pastori; il sogno di Giacobbe, od il tradimento fatto a Sansone dalla donna a cui si era affidato.
Leggevo talvolta una pagina dell’ufficio della Beata Vergine; o tiravo fuori la vita di Sant’Agostino, il quale non aveva fatto una bell’azione, quando per consacrarsi a Dio si era separato dalla propria moglie[10].
[73]
Ero dunque il benvenuto in quella casa di pastori, e mi ero accorto che la vedovella mi guardava in un modo strano, quando raccontavo le storie di tanti eroi. Avevo pur notato, che essa si commoveva e piangeva più alle mie sventure, che a quelle di Fioravante, di Buovo d’Antona e di Giuseppe ebreo.
Quella vedovella mi aveva intenerito e turbato.
Una mattina, che capitai nell’ovile, la trovai sola. Era in maggio, e la campagna era tutta fiorita — come il mio cuore.
La vedovella era seduta in un canto, colla guancia appoggiata sulla palma della mano.
— Cos’è accaduto? — esclamai vivamente, accostandomi a lei.
— Ho un dente che mi fa male. Non ho potuto chiuder occhio in tutta la notte.
— Vediamo — dissi scherzando — sono un po’ medico e chirurgo.
La bella fanciulla si alzò da sedere, venne vicino alla finestra, ed aprì leggermente le due labbra, che sembravano due foglie di rosa.
— Un po’ di più — le dissi.
Ella sorrise, lo le presi la testa fra le due mani, finsi guardare il dente, e poi rapidamente la baciai sulla bocca.
Divenne rossa come bragia, sedette... e mi guardò fisso fisso, come quando le narravo la storia di Dusolina innamorata di Fioravante.
[74]
— Tu non hai più marito... ed io non ho più moglie! — le dissi; e null’altro.
Fu questo il bandolo di una matassa non arruffata, che dipanammo felicemente per oltre un anno.
Io aveva con lei frequenti colloqui, specialmente nel vicino boschetto, all’insaputa del babbo.
Giammai donna, in mia vita, mi amò tanto. Passato l’anno, la vedovella fu chiesta in moglie da un ricco pastore, e il padre trovò convenientissimo il matrimonio. Lei non voleva saperne, e fui io che la indussi con molte preghiere a non lasciarsi sfuggire il buon partito.
— Che puoi sperare da me?... Io non sono un uomo libero. La nostra relazione colpevole non potrebbe recare che guai ad entrambi. Pensaci! Tuo padre e i tuoi fratelli potrebbero vendicarsi... e io sono un bandito, che non ha nulla da perdere!
La vedovella finì per accettare la mano del pastore con ambascia indicibile, e si rassegnò al suo destino.
La mattina del giorno delle nozze — alle quattro dopo mezzanotte — poche ore prima che andasse a sposare, ella volle stare con me per ricordare il dolce passato e per darmi l’ultimo addio.....
Il boschetto tacque sempre quest’ultimo colloquio — e [75] lo tacqui anch’io. Oggi per la prima volta, lo rivelo![11].
M’incontrai più volte con quella giovane donna, ma le parlai sempre come a straniera. Feci di tutto per non trovarla mai sola... e ci sono riuscito. Fu l’unica penitenza che m’imposi per cancellare il mio peccato. Il marito di quella cara bambina (che mi era molto amico) mi pregava di andar con più frequenza nel suo ovile; ma io fuggiva da lui, perchè sicuro che un giorno o l’altro mi sarei tradito.
***
Per dimostrare l’orgoglio, che le donne in genere sentono per la relazione con un bandito, basterà il seguente fatto.
Un giorno alcune amiche, che si trovavano riunite in un’aia, intente al lavoro, presero a raccontarsi a vicenda le proprie simpatie, o relazioni amorose, lecite ed illecite.
La moglie di un agricoltore lasciò scapparsi:
— L’uomo che mi ama e che amo sorpassa i vostri: certo è, che nessuno oserebbe dargli uno schiaffo...
[76]
— È dunque Giovanni Tolu! — fece una compagna imprudentemente, forse nutrendo qualche sospetto.
La donna tacque con eloquente ed orgoglioso silenzio; e poco mancò che questo pettegolezzo non suscitasse seri guai, che per fortuna son riuscito ad evitare, ascrivendo l’incidente ad un puro scherzo.
E bastano queste mie piccole avventure per darvi un’idea degli amori di un bandito; il quale, errante per la campagna, senza tetto nè famiglia, non vive d’ordinario che di pascolo abusivo!
[77]
Andavo in quel tempo da un ovile all’altro per far relazioni; e nel vedermi armato fino ai denti, tutti si domandavano: — chi è costui?
— È un camparo! — si rispondeva dagli amici, i quali non volevano si conoscesse il mio nome.
Andato un giorno a caccia grossa con una comitiva di pastori, mi venne assegnata una posta. Volle il caso, che, per la soverchia carica di polvere, io non colpissi un capriolo, che mi passò dinanzi.
— Il camparo ha sbagliato! — si diceva con tono canzonatorio da’ miei compagni pastori; e ciò mi ferì nell’amor proprio, poichè sapevo di sparar bene.
In quella partita di caccia vennero uccisi due caprioli e due cinghiali. Avanzandomi verso la comitiva, che si era riunita intorno alle bestie morte, io domandai:
— Chi ha colpito il capriolo?
[78]
— Giovanni Antonio.
— Orbene: giacchè ho sbagliato il tiro, vi propongo di giuocare la pelle del capriolo al bersaglio: io ci metterò sopra altre venti lire!
Fu messo per bersaglio il piccolo sonaglio di una capra, a cinquanta passi di distanza.
Nessuno volle cimentarsi. Ci facemmo avanti io e Baingio Caliga (uno degli eccellenti tiratori della Nurra). Tirammo cinque colpi per ciascuno, mettendo sempre la palla dentro al sonaglio.
Paolo Sechi rideva, dando la baia agli altri; e allora tutti dichiararono, che si doveva a un caso accidentale se non avevo colpito il capriolo.
La domenica seguente invitai di nuovo a caccia quattro di quei pastori. Avevo bisogno di avvalorare la mia abilità nel tiro, sebbene nessuno mi conoscesse.
Da qualche tempo si era avvertito in quelle località un cinghiale gigantesco, che riputavasi una delle più grosse bestie vedute nella Nurra. Mi vennero assegnate due poste, dicendomi:
— Sta attento: se scoviamo il cinghiale ti passerà a destra; se sarà il capriolo, ti verrà da sinistra. Ora vedremo quanto vali a caccia!
Mi posi d’impegno. A quindici passi di distanza vidi il grosso cinghiale che veniva: feci fuoco, e gli misi la palla dentro l’occhio, trapassandogli il cuore.
Fu per me un vero trionfo. Avvicinatomi alla bestia morta gli scaricai a bruciapelo la pistola, [79] e poi le diedi una pugnalata; ma, nè la palla nè il ferro intaccarono la pelle, tanto il cinghiale era vecchio. Pesava 140 libre.
***
Continuai la mia vita girovaga di qua e di là nella Nurra di dentro, sempre per raccomandazione di amici e scortato da fidi pastori; fino a che mi determinai ad andar solo, dopo essermi impratichito dei luoghi.
Pur non tralasciando di recarmi di tanto in tanto a Florinas, continuai a far lunghe soste nella Nurra, prendendo parte cogli amici e conoscenti a partite di caccia, in cui (lo dico senza modestia) avevo pochi competitori.
Un giorno, trovandomi con quattro amici e con buonissimi cani, circondammo un folto macchione, donde di colpo sbucarono otto grossi cinghiali. Ne uccisi due scaricando ambe canne del fucile, mentre i miei compagni non riuscirono che a ferirne uno solo.
Diverse volte, da solo, mi riuscì di colpire parecchi cinghiali e caprioli. Una domenica puntai un cinghialone alla fronte, e l’uccisi; e l’indomani ne presi un altro, che mandai a mia sorella in Portotorres, in contraccambio del pane e del vino che mi aveva mandato.
La mia riputazione sull’eccellenza del tiro era già formata e riconosciuta nella Nurra.
[80]
In attesa delle occasioni propizie per aggiustare i conti co’ miei nemici di Florinas, io mi divertivo alla caccia; la quale, d’altra parte, è utile ai banditi per mantenersi in esercizio.
Trattavasi dunque di una caccia reciproca, senza tregua: io la davo ai cinghiali, e i carabinieri la davano a me. Tener d’occhio le mie spie; guardarmi dagli agguati della giustizia e dalla perfidia dei compagni — ecco le occupazioni abituali della mia vita randagia. Del resto noie, malumori, disinganni, e un’intranquillità rassegnata, di cui avevo fatto una seconda natura.
L’abituale mio genere di vita era il seguente. Di giorno visita a qualche ovile; informazioni per sfuggire a spie ed a carabinieri; un po’ di caccia, un po’ di lettura, e molto riposo. Di notte vegliare, il più a lungo possibile; mettermi in viaggio da un punto all’altro; e nella stagione estiva, nuova caccia ai cinghiali.
***
Per quest’ultima caccia, d’ordinario, si ha bisogno di un compagno. Darò qualche schiarimento.
Un giorno, per esempio, avevo preso meco un carbonaio della Nurra, il quale pretendeva di essere un buon cacciatore. Si andò nel cuore della notte ad una tanca di fieno, dove i cinghiali accorrono dai boschi, ghiotti del poco grano sfuggito qua e là ai mietitori.
[81]
Ci ponemmo in agguato, coll’orecchio teso. Come intesi le pedate delle bestie, mandai il mio compagno innanzi, perchè le tenesse d’occhio, badando a spararle se le venivano a tiro, ma senza molestarle se prendevano la mia direzione. Gli feci togliere le scarpe, perchè a questa caccia si va a piedi nudi, avendo i cinghiali un udito finissimo.
Il carbonaio si diresse al punto da me indicato; ma nel camminare faceva un chiasso tale, che perveniva al mio orecchio.
Indignato della poca cautela di quel semplicione, e sicuro che i cinghiali sarebbero scappati, lo raggiunsi:
— Ti vanti sì fino cacciatore, e fai il chiasso del bue?!
Per fargli allora un po’ di dispetto, e per punirlo, soggiunsi:
— So io dove sono i cinghiali. Andiamo piano; tu scalzo, ed io colle scarpe.
E così lo feci camminare, per un buon quarto d’ora, sul fieno tagliato e pungente.
Abituato com’ero a percepire i suoni più deboli, m’accorsi che i cinghiali mangiavano. Feci segno al compagno che si fermasse:
— Se vengono verso la tua direzione, punta e fa fuoco: qui abbiamo il campo netto. Se corrono al brutto, ci penserò io!
M’inoltrai pian piano, finchè vidi sotto una elce una troia, attorniata da otto cinghialotti, [82] tutti intenti al pasto. Il rumore, che facevano mangiando, impediva loro di sentire il mio leggiero calpestio. Quattro di quei cinghialotti appartenevano ad una grossa troia che avevo ucciso pochi giorni prima; e i poveri orfani (come hanno per istinto) avevano cercato le cure d’altra madre.
Feci ancora pochi passi, e li ebbi a tiro. La troia mi avvertì e si cacciò dentro un macchione; i piccoli, grugnendo, giravano attorno all’albero, annusando il fieno.
Era una notte di luna, e li distinguevo chiaramente. Messo in faccia il fucile, ne uccisi due con una doppia scarica.
Gli altri scapparono colla madre. Mi volsi allora al compagno, che avevo dietro, e gli gridai:
— Ora puoi mettere le scarpe, imbecille!
Il carbonaio mi guardò mortificato; ed io gli dissi:
— Una di queste bestie è tua; ma per punizione te le carico entrambe sulle spalle!
A questa caccia notturna non ho mai rinunciato nella stagione estiva. Vi andavo solo, o con un compagno. Essendo abituato a riposare di giorno, mi sentivo fresco la notte.
***
In tempi più tranquilli si concertavano le caccie grosse cogli amici. Si andava talvolta in venti, in quaranta, e persino in ottanta fra pastori [83] ed ospiti venuti alla Nurra. Avevamo con noi un numero considerevole di cani; e, quando capitava il buon filo, si uccidevano persino dieci capi, fra cinghiali e caprioli. Quanto più numerosa era la comitiva, tanto meno pericoloso era per un bandito l’esporsi in campagna; tuttavia, quando si concertavano simili partite di caccia, volevo conoscere i nomi di tutti coloro che vi prendevano parte; e se fra essi erano persone di dubbia fede, mi astenevo dall’andarvi, e pensavo a’ casi miei.
***
Fra i più valenti cacciatori della Nurra era famoso un certo Ledda, rinomato per la caccia notturna ai cinghiali. Un giorno il suo compare Antonio Furru — molto conosciuto dai pastori, poichè dicevasi fosse portato dai morti — lo esortò a dare una messa in suffragio dell’anima di due carbonai, di recente uccisi nella Nurra. Il Ledda si strinse nelle spalle, non curò l’avvertenza, e gliene colse danno. Mentre una notte, precisamente nel sito dove i carbonai morirono, faceva la posta a un grosso cervo, questi uscì di colpo da un macchione e gli si avventò. Datosi alla fuga, spaventato, la grossa bestia lo inseguì per un gran tratto di strada, dandogli molte cornate nella schiena. Fu tanto lo sgomento provato dal Ledda, che ne fece una grave malattia; e da quel giorno non fu più buono a nulla.
[84]
Ho detto che solevo riposare di giorno, per meglio vegliare la notte. Dormivo pochissimo, intieramente vestito, e sempre armato. Non tolsi mai le scarpe in trent’anni, salvo ogni quindicina di giorni, quando la mamma mi portava la biancheria di bucato, nei luoghi da me indicati. Dormivo per lo più in un macchione, o nelle spelonche, durante la stagione estiva; nell’inverno riposavo in qualche ovile, ma sempre vicino alla porta, lontano dal fuoco, e col fucile sulle ginocchia. Prima dell’alba ero fuori, qualunque tempo facesse. Quando accendevo un po’ di legna all’aperto, badavo al vento, e che il fuoco non fosse avvertito. Fumo e fuoco sono sempre due spie, se non si ha l’accortezza di saperli regolare.
Il mio sistema di vita non era abituale a tutti i miei compagni. A molti di essi, per esempio, piaceva star comodi; e preferivano dormir la notte, pensando solo a mangiare, a bere e a chiacchierare negli ovili; e da ciò la loro facile caduta in potere della Giustizia e delle spie.
Io vegliava nelle tenebre; e quando il sole era alto mi cacciavo non visto nelle roccie o nei macchioni, dove dormivo, o leggevo con tutto comodo. Questa solitudine mi tornava cara, poichè ho sempre sdegnato la compagnia d’altri. I compagni d’ordinario si cercano per avere un aiuto nella vendetta — ed io non ne avevo bisogno, perchè bastavo da solo a saldare i miei conti. La relazione co’ compagni c’impone obblighi — ed [85] io non mi prestavo ad uccidere gente che non mi aveva offeso.
Tanto lungo il giorno, quanto lungo la notte, regolavo le mie occupazioni. Conoscevo la strada del sole e di tutte le stelle, e mi bastava guardare il cielo per conoscere l’ora[12].
[86]
Molti furono gli appostamenti e le caccie datemi dai carabinieri, sì a Florinas che alla Nurra, ma coll’astuzia e la prudenza pervenni a sventarli. Salvo a Nuzzu ed a Monte Fenosu, tutte le altre volte sono riuscito a svignarmela senza ricorrere al fucile.
Così stesso posso dire delle spie, maschi e femmine, nelle quali incorsero molti miei compagni. Ho già parlato della moglie di Derudas, della quale non volli vendicarmi perchè non ho mai creduto degna di punizione una gonnella, all’infuori di quella di un prete!
Di spie avrò sempre argomento di toccare lungo la mia narrazione, e così pure di carabinieri; ma voglio qui notare qualche fatto isolato e più importante.
Un giorno mi recai dalla Nurra a Florinas, per assistere alle nozze di una mia cugina. Mandata la cavalla in casa di mia madre (come solevo fare) feci chiamare mio fratello, a cui dissi:
[87]
— Domani notte vieni a trovarmi nel solito ritrovo, insieme al capitano dei barracelli, col quale voglio conferire.
Era di maggio, nel pomeriggio di un giorno piovoso.
Non avendo veduto nessuno, mi recai al villaggio, presso mio cugino Gio. Maria Nuvoli, facendo avvertire mio fratello che venisse là col capitano.
La pioggia continuava insistente, e i due chiamati non venivano.
Verso la mezzanotte sentii sbuffare il cavallo nella casetta attigua, posta all’estremità del villaggio. Quando un cavallo sbuffa, vuol dire che sente l’alito di gente estranea alla casa.
Spensi il lume, e dissi al padrone di casa, ch’era con me:
— Che vuol dir ciò? Il cavallo avverte qualcuno che si accosta. Se fossero stati mio fratello e il capitano non sarebbero passati per il cortiletto.
Mio cugino si spaventò. Io lo spinsi in un angolo della stanza, dicendogli:
— Non muoverti di lì! Se picchiano correrò io ad aprire.
Era mio sistema, quando mi sapevo circondato in un luogo chiuso, di saltar subito fuori, affrontando il pericolo — mezzo sicuro per sfuggire all’agguato.
Tesi l’orecchio, ed udii le pedate di più persone che si allontanavano dalla porta.
[88]
Tenni pronte le armi: il fucile in pugno, la pistola legata al polso, e il pugnale alla cintola. Aspettavo che gli sconosciuti si facessero all’uscio.
Mio cugino tremava. Nella casetta vicina, da cui ci divideva il muro, dormivano la figlia ed il genero. Ad un tratto sentimmo la voce di quest’ultimo:
— Babbo: l’acqua cola dalle tegole e cade sul nostro letto. Ce ne veniamo da te!
Consigliai Nuvoli di farli venire.
I due coniugi, infatti, uscirono in istrada, e il babbo aprì loro la porta.
Interrogati entrambi, risposero di non aver veduto nessuno sulla strada. Io dissi al giovine, ch’era barracello:
— Va a vedere: in vicinanza ci devono essere carabinieri.
Quegli uscì fuori, e rientrò dicendo che il luogo era deserto.
Allora gli ordinai d’insellare il suo cavallo e di portarlo in istrada. Montai di un salto in sella, e mi allontanai a spron battuto, dopo aver mormorato all’orecchio del barracello:
— Domani vieni a ritirare il tuo cavallo da Sos badigius de clexia.
Non mi ero ingannato. Poco discosto dal villaggio erano otto carabinieri, venuti nella notte per darmi l’assalto. Seppi che tre di essi volevano entrare addirittura nella casa di Nuvoli — cinque vi si opposero, osservando ch’io mi trovava in [89] luogo forte e buio, donde avrei potuto ucciderne almeno tre. Dovetti quel brutto tiro ad una spia dei signori, i quali avevano immaginato che non sarei mancato allo sposalizio, e che probabilmente avrei chiesto un ricovero a mio cugino Nuvoli. Non credo, però, che mi avessero veduto entrare in paese.
***
I carabinieri erano avidi di prendermi; e a proposito narrerò un altro fatto, accadutomi nel tempo che avevo a compagno il bandito Derudas.
C’era nel molino di San Lorenzo, presso Florinas, una giovane e belloccia mugnaia, maritata ad un vecchio e un po’ scioccone. Questa donna amoreggiava coi carabinieri, ed andava con piacere a portare qualche sacco di farina alla caserma di Codrongianus, dove i soldati se la tenevano a chiacchierare. Il marito, di frequente, si recava alla caserma per cercarvi la moglie, ma il piantone gli rispondeva... che non vi era andata.
I carabinieri, con le tenerezze, erano riusciti a far di quella donna una spia, per potersi impadronire di me e di Derudas, che frequentavamo il molino di San Lorenzo.
Mi accorsi della trama, e non passai più nel molino. La bella si lamentò con Derudas dell’assenza mia, e questi venne a confidarmi che la peccatrice desiderava la nostra compagnia.
[90]
— Quella donna sa far di tutto... e ci farà anche la spia — risposi — Bada a te: io non mi fido!
Una sera sul tardi la bella Maria uscì dalla caserma con una bisaccia di viveri, che andò a deporre nella chiesetta campestre di San Lorenzo, distante dal molino un 200 passi. La stessa notte dieci carabinieri andarono ad acquartierarsi nel sacro recinto, e vi rimasero chiusi sei giorni e cinque notti.
Fui avvertito da un amico, e compresi l’idea dei carabinieri. Essi volevano prendere i due piccioni nel molino; ma i piccioni erano stati furbi[13].
Trascorse alcune settimane, passai una mattina dinanzi al molino di San Lorenzo, e mi feci al limitare della porta.
Maria, tutta sola, era intenta a pettinarsi nel centro della stanza.
Come alzò gli occhi e mi vide sulla soglia, notò il mio viso arcigno: impallidì, diè un grido e... si lasciò cadere sconciamente a terra.
La guardai, mi venne da ridere, e scrollando le spalle passai oltre, pago dell’effetto del mio sguardo.
[91]
***
Le delazioni a mio danno continuarono sempre.
Un giorno sull’imbrunire, a Florinas, un avvocato diceva ad un altro signore:
— Bisogna pensare da una buona volta a liberarci da Giovanni Tolu. Tolto lui di mezzo, i suoi parenti, che oggi a noi s’impongono, diventeranno mogi al nostro comando. Il paese è intranquillo, ed è dovere di ogni cittadino mettere quel ribaldo nell’impossibilità di nuocere!
Quando i due signori così parlavano, fermi in un viottolo, volle il caso che una mia nipote li udisse dalla finestra, sotto la quale essi cianciavano.
Ne fui informato.
Appena si sparse la voce delle minaccie di costoro, a me riferite, gli altri rispettabili del paese se ne impressionarono vivamente, prevedendo qualche mia vendetta.
Si diedero tutti attorno, per persuadere i miei fratelli e i miei congiunti, che nessuno pensava a farmi male.
Fra le altre persone impegnate, venne a me il fratello di uno dei ciarloni, beneficiato allora nella cattedrale di Sassari. Egli, alla larga, mi esortò a far da bravo, a perdonare, e a non prestar fede a certe dicerie.
[92]
Figurarsi se io poteva dubitare delle orecchie di mia nipote, che mi voleva bene!
Risposi al canonico:
— So che lei, come confessore, ha l’animo disposto ad assolvere tutti i peccati, di cui un zoticone si accusa. Se vuole che anch’io perdoni, deve dirmi di qual peccato intende parlarmi. Ella — mi scusi — non è che un credenzone, il quale vuol cuoprire le piaghe degli altri, senza preoccuparsi di quelle che ha in casa!
E senz’altro piantai il canonico.
Conosciuta la mia risposta, i due signori chiacchieroni credettero prudenza uscir di casa accompagnati; e la paura li acciecò talmente, che giunsero ad asserire d’esser stati una sera da me inseguiti. Era questa una solenne bugia, che mi fece sorridere. Credendosi da me pedinati in campagna, un giorno essi fecero una mezz’ora di strada alla corsa, per salvare, la pelle... di cui non sapevo che farmi!
***
Quantunque bandito, non ho mai tralasciato le mie pratiche religiose. Leggevo sempre l’ufficio della Beata Vergine; recitavo le orazioni del mattino e della sera; pregavo per i defunti, e frequentavo la chiesa e la confessione.
Il rettore Dettori, di Florinas, mi conduceva dentro la chiesa, facendomi passare per una scaletta [93] segreta, che dalla sua casa vi comunicava. Mentre al di fuori i barracelli facevano la guardia, io, bandito, tutto solo col prete, servivo ed ascoltavo la messa allo stesso tempo, e mi confessavo una volta all’anno.
Questo rettore in quel tempo mi diceva:
— Figlio caro: tu devi dare le spalle a tutte le dicerie che corrono, a riguardo dei supposti signori che ti fanno la spia.
Io rispondeva:
— A me basta che non mi cerchino. Lei però, come padre spirituale, che conosce e vuol bene a tutti questi signori, dovrebbe avvertirli che facciano il proprio dovere, badando al fatto loro; poichè se mi cercano, correranno il pericolo della vita. Lei può far loro del bene. Veda? noi adesso siamo in chiesa, nella casa del Signore; io mi sento contrito, perchè mi sono confessato e comunicato; eppure, se questi signori mi sapessero qui, sarebbero capaci di darmi l’assalto anche a piedi dell’altare.
— No, figlio mio!
— Le dico di sì! Or senta, signor rettore. Se i suoi amici qui mi assalissero, io li ucciderei, perchè ho il dovere di conservare la mia vita con tutte le forze. Mi sono riconciliato con Dio, non farò male a nessuno; ma se mi cercano, mi trovano, e non rinunzio al mio diritto di difesa!
Questo parroco, mio confessore, aveva una paura maledetta di me.
[94]
Un giorno capitai nella valle di Nolo gialvu; dove mi trovai col rettore Dettori, col notaio Oppia, e diversi altri colà convenuti por assistere alla tosatura delle pecore di Don Ignazio Piras.
Vedendo un libro nel taschino della mia giacca, il notaio mi chiese di che trattasse.
— È l’ufficio della Beata Vergine in latino regalatomi dal rettore — risposi.
— Che ne capisci tu?
— Qualche cosa ne capisco, perchè ho fatto il sagrestano.
Il rettore allora soggiunse gravemente:
— Ancorchè lui non lo capisca, Iddio accoglie le sue orazioni, perchè conosce tutte le lingue. Basta in Tolu la fede, e Dio lo ascolterà.
Don Ignazio voleva che quel giorno rimanessi là a pranzo colla brigata; ma io ricusai per far piacere al rettore, il quale si mostrava intranquillo alla mia presenza.
***
Narrerò sulle spie un altro episodio, avvenutomi nella Nurra.
Fra le donne mie favorite era la moglie di un pastore nurrese, certa Anna Maria, colla quale ero in relazione da qualche tempo.
Il pastore, non so se per qualche imprudenza della moglie, o per la relazione di qualche maligno, [95] entrò in sospetto, divenne geloso, e mi guardava in cagnesco.
Accortomi del suo malumore, feci l’indifferente, e lo tenni d’occhio.
Non potendo egli prendermi di fronte, perchè mi temeva, pensò di vendicarsi in altro modo; e si diede allo spionaggio, per farmi cadere nelle mani della giustizia.
Anna Maria, in confidenza, mi pose sull’avviso, ma io dubitavo delle minaccie di quel gradasso geloso.
In quel tempo un carabiniere disse in segretezza ad un suo e mio amico nurrese:
— Senti. Tu conosci Giovanni Tolu; digli che Tomaso gli fa la spia perchè è geloso della moglie. Che si guardi, poichè noi dobbiamo fare il nostro dovere!
Un altro giorno il brigadiere del mandamento di Portotorres mandò due carabinieri a Tomaso, per richiamarlo alla promessa fatta sul conto mio. Il pastore rispose, che ben presto avrebbe fornito indizi sicuri.
La moglie del pastore, che voleva salvarmi ad ogni costo, mi confidò la trama, ed io le diedi parola che non me ne sarei vendicato.
Alcuni carabinieri in perlustrazione, giunti una mattina all’ovile, dissero a Tomaso in presenza della moglie:
— Non ti accorgi, dunque, che sei un disgraziato? Tu cammini da stolto, perchè sei acciecato [96] dalla gelosia. Se Giovanni Tolu sa che gli fai la spia così apertamente, sarà capace di spararti, anche se tu avessi il tuo figliuolo in braccio!
Informato di questi fatti, e non volendo recar danno al marito di Anna Maria, io mi ridussi a rendere meno frequenti le visite all’ovile di Tomaso, per dargli agio a frenare la sua gelosia... che non era infondata. Capitavo da lui ogni due o tre mesi, ed egli forse si persuase dell’insussistenza di una colpa.
Posi ogni studio per sfuggire agli agguati, ma non pensai neppure a vendicarmi di Tomaso, che me li preparava. Egli non era che un tradito traditore, e meritava tutta la mia indulgenza. Devo d’altronde dichiarare, che non ho mai attentato alla vita di un marito ingannato, anche sapendolo spia. Colla clemenza verso gli offesi mi pareva di soffocare un po’ di rimorso.
[97]
L’ho detto: sono tre gli obbiettivi di un bandito: — vendicarsi anzitutto dei nemici che furono causa della sua disgrazia; liberarsi dai traditori e dalle spie; difendersi dalla forza pubblica, quando da essa viene assalito. L’uomo, uscito onesto dal suo paesello natìo per darsi alla campagna, non pensa ad altro. Il miserabile invece, approfitta della condizione in cui fu messo dal destino, per fare anche il grassatore ed il sicario. Ciò però non esclude, che anche il bandito buono, molto spesso, non finisca per decidersi a fare il sicario e il grassatore, sedotto al malfare dai cattivi compagni, o da coloro che vogliono sbarazzarsi di un nemico incomodo, pur conservando la riputazione di benefici e onesti cittadini.
Ond’è che il bandito nato onesto, invece di poter contare sul consiglio di chi dovrebbe metterlo sulla buona via, si vede costretto a lottare, non colla propria coscienza, ma con la coscienza di coloro che hanno in animo di traviarlo.
[98]
Rifuggente per indole dai compagni; abborrente per istinto dalla rapina; sdegnoso di chiedere l’altrui aiuto nelle mie vendette, nonchè di prestarmi di strumento alle vendette altrui, io pervenni a non intingere mai nei due misfatti per me orrorosi. Non fui mai ladro, nè sicario — e me ne vanto!
Nè crediate che da siffatti eccessi io rifuggissi per forza di virtù, o per sentimento di religione: no! Non rubavo, perchè non sentivo il bisogno di rubare, e perchè tenevo alla fama di non essere un ladro. Tutti mi davano danaro, anche spontaneamente, se sapevano che io versavo in istrettezze. A che rubare, quando i pastori e non pochi signori mi offrivano rifugio e pasto? Dirò più tardi com’io sia riuscito a ragranellare un po’ di patrimonio, dopo che il pensiero di formarmi una casa nuova ed una nuova famiglia tornò a carezzarmi il cuore, avido sempre di pace, di affetto e di conforto.
Non volli ad altri prestare il mio braccio, perchè me lo sentivo debole quando l’ira e l’odio non mi acciecavano la mente. Quanto al servirmi del braccio altrui per colpire un mio nemico, lo ritenevo maggior debolezza e vigliaccheria. Dirò crudamente, che non avrei provato soddisfazione alcuna nella vendetta; io volevo tutto il vanto di affrontare il nemico e di ucciderlo con le mie mani; se altri me lo avesse ucciso, ne avrei sentito vergogna e umiliazione. Temevo [99] troppo il disprezzo e le beffe dei compagni banditi, i quali avrebbero detto: Se ha ricorso a noi, è segno ch’ei non è buono, od ha paura!
Ho errato, forse, nei primi tempi del mio banditismo, quando cioè — giovane ardente e inconsiderato — ho commesso azioni, che nella età virile ho in seguito deplorato, quantunque mai me ne sia pentito. I fatti d’armi, le avventure audaci, il coraggio bellicoso furono sempre — e lo sono anche oggidì — le mie letture predilette. Esse mi esaltavano. Chiuso nel crepaccio di una roccia, sdraiato in seno ad un macchione — sotto ai raggi del sole, o quando sulla campagna imperversava un temporale — io seguiva sulle pagine dei libri le gesta degli eroi, senza curarmi degli uragani, delle spie, e dei carabinieri, dai quali mi credevo al sicuro.
Ma torniamo ai sicari.
Certi signori, o ricchi proprietari, non proteggono solamente il bandito perchè ne hanno paura o ne ambiscono la difesa; non mancano i malevoli (più tristi assai di noi!) che al bandito ricorrono, per servirsene come di strumento di odî privati, di rancori di parte, od anche talvolta per avidità di lucro, togliendo di mezzo un erede incomodo.
Ben pochi a me ricorsero, poichè conoscevano la mia natura; ma i miei compagni erranti si prestavano assai spesso a questi servizi per [100] scopo di guadagno, e specialmente Cambilargiu, Antonio Spano e Derudas.
— Omicidio più, omicidio meno — essi dicevano — non aggrava nè alleggerisce la nostra condizione.
***
Ho già accennato più volte ad inviti fattimi per uccidere un terzo. Citerò ora qualche caso isolato.
Mentre battevo la campagna, venni invitato a recarmi in casa di Pietro Pintus, dove trovai l’amico suo, Antonio Luigi di Banari.
Questi mi disse, che voleva parlarmi a quattr’occhi.
Mi fece attraversare tre camere, l’una dentro l’altra, e dopo aver chiuso con precauzione la porta e aver origliato alle pareti, tornò a me, e mi disse:
— Mi chiamo Antonio Luigi, sono ricco, ho cavalli, ho buoi, ho grano, ho danaro. Sono furibondo perchè mi hanno ucciso due nipoti: Vendicami, e domanda quello che vuoi!
Io risposi risoluto:
— A quest’ora lei sarà informato, ch’io non sono buono a nulla. Se mi fossi sentito un uomo di abilità, avrei già fatto molto per mio conto, in odio a’ nemici miei.
Il ricco proprietario riprese:
[101]
— Per me dovresti fare un’eccezione. Io potrei non poco giovarti nelle tue cause, perchè sono in relazione con persone influenti. Tu ben sai che i fratelli Solinas, oggi a Sassari, sono miei cugini, ed ho colà diversi amici impiegati presso la Reale Governazione. Dunque, servimi, e sta tranquillo: sarà per il tuo bene. Non sarai da me abbandonato finchè vivi e finchè vivo. Che rispondi?
— Le ripeto che ogni insistenza torna vana. La servirò in tutt’altro, ma non in quest’affare. Non sono buono a nulla!
E dal mio labbro non trasse altro, che la promessa del silenzio sulla proposta.
***
Un’altro giorno ebbi un abboccamento con un proprietario di Banari, certo Gian Paolo, che mi disse:
— È già un anno che Matteo Trudda mi tormenta, facendomi dispetti d’ogni genere. Vorrei liberarmene!
— E perchè non l’uccidete? — gli dissi con sarcasmo.
— Tu sei un bandito... e potresti più facilmente imbatterti in lui. Sarei disposto a dare cento scudi subito!
— Sarò franco. Io non posso ucciderlo per due ragioni: la prima perchè non faccio il sicario; [102] la seconda, perchè Matteo Trudda è mio amico!
Il proprietario sbarrò tanto d’occhi e impallidì. Certo egli pensava, che cercando di togliersi un nemico, se ne aveva creato due. Lo vidi turbato, ed ebbi pietà di lui.
— Vi toglierò io d’impaccio — dissi — Voi cercherete di non far male a Matteo Trudda, che è un bonaccione, quantunque faccia lo spavaldo. Dal mio canto, mantenendo il segreto, io cercherò di persuadere il vostro nemico di vivere in pace con voi.
E così feci. Abboccatomi con Trudda, gli raccomandai di non far torti a Gian Paolo.
Il risultato delle mie pratiche fu questo: che i due nemici vissero in buoni accordi, e si protessero a vicenda, solo perchè temevano l’ira mia. Li misi in pace colla paura!
***
Un signore di Tissi venne un giorno a trovarmi nelle campagne di Florinas. Egli mi disse:
— Tu devi tenermi compagnia per uccidere un uomo. Appena lo avremo ucciso, tu ti accompagnerai col prete Salvatore Masala, mio cognato, il quale si è dato alla macchia.
Io gli risposi secco:
— Che vuoi? non sono tagliato per queste cose!
[103]
— Ci sono io! tu, forse, non sparerai. Finchè vive quell’uomo, mio cognato non potrà riacquistare la sua libertà. Bisogna toglierlo di mezzo!
— In mia compagnia tu non potresti far nulla. Se è vero che il dente ti fa male, strappalo colle tue mani. Odio i nemici miei, non quelli degli altri!
Il prete Masala era in relazione con una donna. Accusato di averle ucciso il marito, si era dato alla macchia, e venne alla Nurra per fare il bandito. Era il più alto prete della Diocesi. Dopo un po’ di tempo volle costituirsi in carcere; venne processato, ed assolto.
La compagnia di un prete bandito m’avrebbe certo giovato, poichè con lui avrei appreso a leggere correntemente ed a scrivere; ma io ne diffidai, temendo che finisse per denunziarmi. Ai preti non mi piacque dar mai confidenza; li veneravo in chiesa, ma li sfuggivo fuori.
***
Tralasciando alcuni altri episodi dello stesso genere, che riporterò nel corso della narrazione, voglio chiudere con uno speciale.
Non fu solamente dai privati, che mi si propose di fare il sicario: ebbi l’invito anche dal Governo.
Per gli eccitamenti di un notaio e di un sotto ispettore demaniale piemontese (persone [104] amiche e influenti, cui stava a cuore la mia trista condizione) mi lasciai convincere ad invocare la grazia sovrana. La supplica fu fatta capitare nelle proprie mani del re, per mezzo del fratello dell’ispettore, impiegato nella Casa reale.
Trascorsero tre mesi, senza una risposta.
Un giorno il brigadiere dei carabinieri di Codrongianus si rivolse a mio fratello Peppe, dicendogli che mi voleva comunicare cosa di molta importanza; e che se io rifiutavo a presentarmi a lui disarmato, avrebbe incaricato della missione il sindaco di Florinas, come di dovere.
Io risposi, che preferivo presentarmi al sindaco.
Il sindaco, in tutta segretezza, mi comunicò: che il Governo era disposto a concedermi la libertà provvisoria, per procurarmi l’impunità colla denunzia di tre banditi: il mio compagno Derudas, Antonio Spano e Pietro Cambilargiu. Mi si dava inoltre la piena facoltà di agire da solo, o di servirmi dei carabinieri, che si sarebbero messi a mia disposizione.
Rifiutai sdegnosamente, poichè non volevo macchiare il mio nome e quello del paese con una simile infamia[14].
[105]
Il sindaco si scusò meco di esser stato costretto come ufficiale pubblico a comunicarmi la proposta del Governo. Soddisfatto del mio rifiuto, egli mi battè sulla spalla, mi disse bravo! e mi regalò uno scudo[15].
***
Io continuai ne’ miei propositi di vendetta. I frequenti messaggi dei signori di Florinas non valsero a disarmare l’ira mia. Io non doveva perdonare. Perdonano i deboli ed i vigliacchi — ed io non ero vigliacco, nè debole! Che poteva farmi la giustizia? Non avevo che una vita da darle, contro le cento che avrei tolte ai nemici.
Con questi propositi feroci continuavo a scorrazzare tra la Nurra e Florinas, aspettando che gli avversari venissero a tiro del mio fucile.
Correva l’anno 1856, da me chiuso colla morte di Salvatore Moro. Da soli cinque anni battevo la campagna. Cinque anni che mi parvero secoli. Ma non avevo fretta!
[106]
Erano trascorsi sette anni dal giorno in cui, volontario proscritto, battevo la campagna di Florinas e della Nurra, dando la caccia a’ miei nemici, e sfuggendo la loro caccia. Ero assalito assai spesso da una noia tormentosa, da una stanchezza spossante, ch’io sentivo più nello spirito che nel corpo. Vi erano momenti di sconforto e di fastidio, in cui più tenace sentivo il bisogno dell’isolamento e della solitudine, quantunque l’uno e l’altra maggiormente mi accasciassero, poichè più assiduo mi assaliva il pensiero delle mie disgrazie.
In quei momenti angosciosi, chiudendo gli occhi, io vedeva sfilare ad uno ad uno i ricordi più cari e dolorosi. Ricordavo il mio passato, la mia laboriosa gioventù, il mio primo incontro con Maria Francesca, le serene occupazioni della casa materna, e i consigli del vecchio mio babbo, così onesto, così rigido, così scrupoloso ne’ suoi doveri. Oh, se quel buon vecchio avesse potuto levar la testa dal suo sepolcro e mi avesse [107] veduto! Le mie mani si erano lordate di sangue umano, eppure non avevo mai sentito rimorso; mai ne’ miei sonni, posso asserirlo, nessuna delle vittime da me immolate era venuta a rinfacciarmi la mia ferocia: indizio che esse meritavano la punizione loro inflitta, per il male che mi avevano fatto. Sentivo invece, in quei momenti, ridestarsi più intenso l’odio verso i distruttori della mia felicità; e l’ombra nera di quel prete fatale grandeggiava sinistramente nelle mie visioni — non per esercitare la sua missione di pace e di perdono — ma per strappare dal mio labbro nuove maledizioni al suo indirizzo. Era forse questa la sua penitenza nell’altro mondo: la divina giustizia lo aveva condannato a mantenermi vivo nell’anima il sentimento dell’odio antico, perchè le memorie delle sue scelleratezze non si cancellassero in terra! Egli aveva fatto molto male agli altri co’ suoi intrighi, co’ suoi ricorsi, colle sue malìe, e più volte me n’ero accorto. Io ben sapeva, che il prete, nel dir la messa, vede i defunti e i condannati a morte violenta; e sull’altare medita i diabolici malefizî a danno altrui.
***
Con questi brutti pensieri per il capo, io girovagava per i dintorni di Florinas, in una calda mattina di luglio.
[108]
La campagna era arsa, le foglie secche e polverose, il sole scottante. Eppure io mi compiacevo di quell’arsura canicolare e di quello squallore, a me più cari del tiepido alito della primavera e del lieto verde dei pioppi e dei mandorli fioriti. Io — l’uomo dell’aratro e della messe — amavo il caldo soffocante, le spighe color d’oro, i covoni sparsi per le aie, le cavalle trottanti nel lavoro della trebbiatura; amavo quel silenzio eloquente rotto dal canto stridulo e monotono dei grilli e delle cicale; mi facevano fremere le canzoni amorose, il chiacchierìo festevole dei mietitori e delle spigolatrici, che in gruppi di venti e di trenta ingombravano le aie. Ripensavo alla mia antica professione, alla mia innocente giovinezza, non turbata da paure e da sogni di vendetta.
Possedevo allora un buon cavallo di corsa, che di tanto in tanto mandavo a correre per i paesi dell’isola, quando sapevo che vi era una festa.
Quella mattina mi diriggevo ad un’aia, per cercarvi il padrone del fantino che doveva cimentarsi alla corsa. Vi trovai il fantino, ma il padrone era assente.
Insieme alle donne che lavoravano nell’aia, vidi certa Maria Vittoria Mancone, cugina di mia moglie.
Avvicinatomi al muro per chiamare il fantino, Maria mi si fece incontro e mi disse:
[109]
— Se tu fossi venuto ieri, avresti veduto la tua figliuola!
Corrugai la fronte e mi feci serio, fingendo un’indifferenza glaciale; ma le parole di quella ragazza mi destarono nell’anima una strana agitazione, che non sapevo spiegarmi.
Senza rispondere alla donna, dissi al fantino, in modo che mia cugina sentisse:
— Domanda al tuo padrone se ti lascia venire due o tre volte da me, per stirare[16] il cavallo. Verrò qui domani per avere la risposta.
Maria Vittoria tornò allora a dirmi:
— Se mi assicuri che verrai domani, io porterò qui tua figlia.
Coll’indifferenza sul volto, ma coll’ansia nell’anima, risposi freddamente a mia cugina:
— Portala pure.
E mi allontanai.
Lo confesso: quel giorno mi parve un secolo. Io moriva dalla voglia di vedere quella bambina, che neppur conoscevo. Povera creatura! era la figlia d’un bandito, lei! un’orfana prima di nascere, poichè entrata nel mondo due mesi dopo ch’io n’ero uscito. Che colpa a lei d’esser nata? Che colpa a lei s’era venuta per tenerci compagnia, e ci aveva trovati disgiunti?
[110]
Oh, come avrei stretto al mio cuore quella bambina, se il pensiero d’una madre snaturata non avesse avvelenato il sentimento pietoso che mi parlava all’anima!
Maria Francesca — mia moglie — continuava a viver sola in una catapecchia fuori mano, lontana dai genitori. Faceva la sarta per campare la vita... e campava male. Il paese, fino allora, non aveva mormorato sul di lei conto; ma voci vaghe e sinistre erano già pervenute al mio orecchio. Mi si era riferito che un uomo era stato veduto entrare ed uscire dalla sua casetta a notte inoltrata ed all’alba. Il paese dormiva tranquillo sull’onestà di Maria Francesca Meloni; ma le mie spie vegliavano, e vegliavano i miei parenti sulla condotta d’una donna, cui avevo dato il mio nome, sebbene da lei fossi diviso... e per sempre. Maria Francesca era giovane, era bella, era sola, era poverissima: quattro circostanze critiche, delle quali gli scaltri avrebbero approfittato. I signori di Florinas, che vivevano d’ozio e di crapula, non l’avrebbero certo rispettata!
Un uomo s’introduceva nella casa di quella disgraziata; ma chi era? Non lo sapevo ancora, nè m’importava di saperlo. Ma della mia bambina che sarebbe avvenuto? Quale educazione avrebbe potuto ricevere? Ecco il pensiero fisso che mi tormentava, alla vigilia di vedere la mia figliuola. Potevo io lasciarla presso quella madre? [111] Le madri diventano snaturate, noncuranti delle proprie creature, quando sono tormentate dalla febbre d’una passione amorosa. Li avevo ben io veduti, i figli di Maddalena Marongiu, quando quella donna si era a me unita tradendo il marito! E quante volte non avevo io comprato le scarpette ed un giubetto alla bella bambina dell’adultera, quando la vedevo lacera e scalza nell’ovile di Giunchi? Mia figlia avrebbe fatto la stessa fine; nè sapevo neppure se il drudo di Maria Francesca sarebbe stato pietoso, come io lo fui!
***
In preda a questi foschi pensieri, che mi tormentarono per 24 ore, tornai l’indomani a mezzogiorno all’aia.
Mi feci al solito muro e chiamai il fantino.
Questi venne a me.
— Ebbene? — gli dissi — che ti rispose il padrone?
— Per far piacere a Giovanni Tolu è disposto a lasciarmi andare alla corsa anche per otto giorni!
— E tu sei contento?
— Contentissimo.
— Va bene. Ringrazia per me il padrone, e salutalo.
Così dicendo finsi di allontanarmi. Il fantino mi gridò dietro:
[112]
— Ve ne andate? È qui la vostra figliuola!
Mi voltai freddamente:
— Dov’è?
— Qui vicino: coricata fra le bisaccie e le robe dei mietitori.
Scavalcai il muro e mi diressi al punto indicatomi. Dubitavo ancora di una mistificazione. Temevo che la cattiva madre avesse scambiata la mia bambina con un’altra.
Camminai in punta di piedi, temendo di svegliarla.
Giunsi sul luogo, e vidi una bambina rosea sdraiata su alcune gonnelle e cappotti ripiegati. Ella dormiva placidamente. Le mietitrici, lontane, erano intente al lavoro.
Stetti alcuni minuti contemplandola in silenzio. Il mio cuore batteva violentemente. Mi pareva di sentire delle lagrime agli occhi.
— Sì: questo è mio sangue! è mia figlia! — esclamai quasi inspirato da uno spirito misterioso che mi parlava all’anima[17].
Feci alcuni passi indietro, e dissi al fantino:
— Va subito a chiamare la zia!
Maria Vittoria accorse, ed io le dissi:
[113]
— Sveglia tu la bambina; io non l’oso, perchè non mi conosce e si spaventerebbe.
Appena svegliata, dissi rivolto alla zia, tanto per cominciare un discorso:
— Di chi è figlia, costei?
E quella stupidamente:
— Che sappiamo noi di chi sarà figlia?!
Queste parole mi fecero fremere.
La bella bimba — a cui la zia in precedenza aveva annunziato l’arrivo del babbo — udendo le parole di Maria Vittoria, si mise a piangere in modo, che non ci fu verso di calmarla.
Vedendo inutile ogni sforzo, pregai la zia che conducesse seco la bambina, per riportarmela più tardi, quando l’avrebbe veduta tranquilla.
Maria Vittoria si rimise al lavoro, ed io rimasi solo, coll’occhio fisso sul giaciglio, dove la mia piccina aveva riposato.
Dopo una diecina di minuti vidi la bambina venir sola alla mia volta, mandata dalla zia per portarle la gonnella, che si trovava fra gli indumenti e le bisaccie dei mietitori.
Io le rivolsi dolcemente la parola, componendo il mio volto ad un sorriso:
— Vieni qui, Maria: non aver paura: sei la mia figliuola!
E così dicendo la carezzai, baciandola più volte sulle guancie.
[114]
— Va a portare la gonnella alla zia... e poi torna qui... dal tuo babbo!
Aiutai la bambina a caricarsi la gonnella ripiegata; indi si allontanò. Io l’accompagnai cogli occhi lagrimosi e col cuore gonfio di emozione, aspettando con ansia il suo ritorno.
Pare, però, che non si decidesse a tornare indietro, poichè la zia dovette lusingarla, dicendole che le avrei dato danaro.
A questa promessa ella cedette, e si avvicinò a me tutta esitante e vergognosa.
Tolsi dalla mia bisaccia un uovo e un pezzo di pane, che addentò avidamente.
— Oh il pane bianco! — esclamò.
Io riceveva con frequenza il pane fresco di semola, che mia madre faceva apposta per me.
— Non ne mangiate, dunque, di questo pane, voi?
— Oh, no!
— Che pane mangi?
— Pane d’orzo.
— Siete dunque molto poveri?
La bambina mi guardò senza rispondere.
— Vedi — soggiunsi — mamma Bazzone (così i nipoti chiamavano mia madre) ha una cassa piena di danaro. Io le dirò che ti faccia un bel vestito nuovo di panno; e tu ne andrai con lei a San Gavino di Portotorres. Mamma Bazzone t’insegnerà la dottrina, ed io ti farò insegnare a leggere ed a scrivere. Ricordalo, veh! [115] quando ti chiamerà mamma Buzzone, vacci subito. Tu verrai poi da me con Petronilla, ed io vi darò i confetti!
Petronilla era la sua piccola cugina, figlia di Felice, il mio fratello maggiore.
La bambina mi guardava con stupore, sbocconcellando il pane con appetito.
La presi in braccio, la baciai più volte, e la condussi così da un punto all’altro dell’aia, facendole mille domande. La bambina aveva preso con me confidenza, e si mostrava meno timida.
— La sai la dottrina?
— La mamma non me l’ha insegnata.
— Te la insegnerà mamma Bazzone, se andrai spesso da lei.
Si era fatto tardi; le tenebre cominciavano a calare, ed io avevo quasi dimenticato la mia trista condizione, gli agguati ed i nemici miei.
Feci passare la figliuola dalle mie braccia in quelle della zia Vittoria, e ci separammo.
Accompagnai cogli occhi quelle due figure, e non mi mossi, finchè non le vidi scomparire dietro a un folto cespuglio.
Allora mandai un profondo sospiro, e continuai ad errare per la campagna, felice di quell’incontro che aveva gettato tanta luce nel mio povero cuore.
[116]
***
Pochi giorni dopo mandai a dire a mia madre che venisse a trovarmi nella vigna dello zio (in Calchinada) conducendo seco le due nipoti, Petronilla e Maria Antonia.
Esse vennero; ed io, che avevo le tasche piene di confetti, cominciai a distribuirne a profusione all’una e all’altra.
Petronilla si diè a divorarli facendo festa, ma la mia bambina li lasciò nel cartoccio, come glie li avevo dati.
— Perchè non mangi i confetti? — chiesi alla mia figliuola.
— Li conservo per la mamma — mi rispose timidamente.
Il nome di mia moglie mi gelava il riso sulle labbra.
Si fece pranzo a mezzogiorno colle provviste portate da mia madre. In sulle prime la mia bambina non voleva toccar nulla; ma, pregata da me, si diede poi a mangiare con avidità.
— No, no: così non voglio! — esclamai — Temo che ti faccia male.
Passai la giornata giuocando con la mia figliuola, fino a stancarla. Ad un certo punto ella mi disse, carezzandomi la barba:
— Mi avevi promesso danaro. Non me ne dai?
— Ma sì, che te ne do. Dimmi quanto vuoi.
[117]
Pensò alquanto, poi disse:
— Voglio... cinque soldi!
— E a chi li dai? — le chiesi un po’ serio.
La bambina mi fissò impacciata; e per non dirmi che li dava alla mamma, preferì tacere e più non volle danaro.
Chi le aveva detto che il nominare la mamma mi faceva dispiacere?
In quei giorni avevo ideato un mondo di progetti. Dissi a mia figlia:
— Non sai? ho fatto la bandiera a S. Paolo. Se tu verrai da me con mamma Bazzone, ti farò vestire tutta di panno, ti farò un bel giubbetto, un paio di scarpe nuove, e ti farò condurre alla festa sul mio cavallo. La bandiera sarà tua!
La piccola Maria, ch’io teneva fra le ginocchia, apriva tanto d’occhi e mi guardava:
— L’ho visto, sai, il tuo cavallo? lo portava il fantino Francischello, e si rizzava diritto diritto, facendo colle zampe così...
E la bambina imitava colle manine l’inalberarsi del cavallo.
Erano tutte sciocchezze, ma io mi divertiva un mondo.
Dissi a mia madre:
— Hai inteso? Porta la mia figliuola da mia nipote Giustina, la sarta, e falle fare un bell’abito di panno, alla sarda; poi falle fare un busto, un corsetto, il giubbone, un paio di calze, e le scarpette nuove. Pago io!
[118]
Poi dissi alla bambina:
— Questo vestito vecchio, che ora indossi, appena avrai il nuovo, portalo alla mamma tua, e dille che lo conservi. Penserà il babbo, d’ora innanzi, a farti gli abiti belli!
Ciò dissi per scherzo, ma la bimba non lo dimenticò; e quando un mese dopo ebbe le vesti nuove, presentò le vecchie alla mamma, ripetendo quanto io le aveva detto.
***
La bambina aveva indossato gli abiti alla vigilia della festa di San Paolo. Così vestita uscì sulla strada; e vedutala un mio zio prete, chiese al vicinato:
— Di chi è quella graziosa bambina?
— È la figlia di Giovanni Tolu!
Il prete allora le regalò mezzo scudo; e l’avvocato Paolo Satta, che si trovava quel giorno a Florinas, chiamò la mia bambina per darle una pezza di sette reali e mezzo.
Quando mi si riferirono queste cose, mi sentivo orgoglioso di essere il babbo della piccola Maria Antonia[18].
[119]
Poco dopo rincontro con la mia bambina, mi era nata l’idea di portare come voto una bandiera a San Paolo, nel giorno della festa. Ne parlai per il primo al mio parente Piana, il marito della serva di prete Pittui, col quale mi ero un po’ riconciliato. Egli si offrì spontaneamente a contribuirvi per la metà; ma essendosi in seguito unito ad altri, non volli più sapere di soci, e feci eseguire la bandiera a tutte mie spese.
La mia bandiera era bellissima, speciale. Mi ero rivolto a diversi negozianti della piazza di Sassari, i quali pensarono a tutto. Vi spesi oltre 400 lire; poichè 76 scudi mi costò la stoffa e l’asta, 4 scudi l’effigie di San Paolo, e 2 scudi la colomba da collocarsi sulla sommità della croce.
La festa di San Paolo ha luogo nelle vicinanze del villaggio di Monti ai 17 di agosto. È propriamente la festa dei banditi, e chiama gran folla di devoti da ogni parte della Sardegna, specialmente dal capo settentrionale.
[120]
Alla vigilia della festa i miei fratelli, con uno zio di mia madre, accompagnati da una quindicina di persone, tutti a cavallo, mossero da Florinas per San Paolo di Monti. La mia bambina sedeva in arcione con lo zio Giomaria; il mio fratello Peppe portava la bandiera da me provveduta.
Avevo raccomandato a mia madre di dire ai parenti che avessero dato alla mia figliuola abbastanza danaro, e che non l’avessero disgustata.
Col cuore straziato per non poter andare alla festa, ma fiero di quella comitiva che conduceva la bimba e la bandiera mia, rimasi per un’ora sul ciglione della strada, per dove la cavalcata doveva passare.
Li vidi finalmente da lontano, in un nembo di polvere, e mi si gonfiò il cuore. Quando giunsero a me dinanzi, si fermarono tutti. Io gridai a mio fratello Peppe:
— Spiega la bandiera, perchè si veda!
La fissai con orgoglio, e diedi uno scudo alla bambina; la quale, tutta lieta e sorridente, mi disse:
— Babbo: dallo a Tiu Mia (Zio Giomaria) che ha il mio danaro!
Tornai ad avvertire la comitiva, che non disgustassero la mia figliuola, ma che le dessero quanto avrebbe chiesto, soddisfacendo ogni suo desiderio. Avrei rimborsato qualunque spesa.
[121]
La comitiva si mosse continuando la sua strada; ed io commosso l’accompagnai cogli occhi, salutando con una mano la figliuola, e rasciugando coll’altra una lagrima di tenerezza.
***
Alla festa di San Paolo di Monti accorreva in altri tempi un gran numero di banditi; i quali vi godevano piena libertà, essendo stato vietato ai carabinieri d’intervenirvi.
Si recavano colà i soli banditi dei dintorni, poichè i lontani non si fidavano per i molti sentieri sospetti e pericolosi.
Verso il 1854 avvenne a San Paolo una rissa sanguinosa, in cui un festaiuolo uccise un torronaio pattadese. Dietro a quel caso, dall’anno susseguente, il Governo mandò alla festa un forte nerbo di soldati, obbligando i festaiuoli a recarvisi disarmati. Il divieto delle armi allontanò per sempre i banditi dalla chiesetta di Monti.
I devoti entrano prima in chiesa per fare orazione; indi rimontano a cavallo, spiegano la bandiera, e fanno per tre volte il giro della chiesa, fermandosi ogni volta dinanzi alla porta per salutare il santo. Ciò eseguito smontano di nuovo da cavallo, rientrano in chiesa, e dispongono le bandiere in bell’ordine ai due lati del simulacro.
Messe le bandiere a posto, e fatta la preghiera, si pensa a far custodire alla meglio i cavalli; [122] e poi di nuovo tutti uniti in chiesa, per recitare una terza orazione.
L’anno ch’io mi recai alla festa di San Paolo (verso il 1846) contai sul luogo 72 bandiere — senza tener conto di altre 14 che mancavano da Bottida, poichè il paese era in lutto per un attacco sanguinoso fra due partiti. Si può quindi immaginare il numero dei festaiuoli devoti; toccavano i quattromila.
***
Non mancarono i parenti e gli amici di darmi ragguaglio sul viaggio della mia bambina e sull’ammirazione che destava la mia bandiera.
La mia bambina, meravigliata di quanto vedeva, si accostava ogni tanto allo zio:
— Tiu Mia, dammi danaro!
— Quanto vuoi, figliuola?
— Mezzo reale.
— Che ne fai?
— Per comprare i confetti.
Come lo zio glie li comprava, Maria Antonia non faceva che distribuirli alle bambine e ai bambini che l’attorniavano, cosichè ben pochi glie ne rimanevano. Quando li aveva esauriti tornava a mio fratello:
— Tiu Mia!
— Che vuoi?
— Mezzo reale!
[123]
E così continuò il giuoco dei mezzo reali da baracca in baracca. La mia bambina pagava, gli altri mangiavano, ed io fui soddisfatto del buon cuore della mia figliuola verso i piccoli compagni di baldoria.
A festa finita furono tutti di ritorno a Florinas, ed io di nuovo li aspettai sul ciglione della strada per vederli e salutarli colla gioia nel cuore.
Quando l’allegra comitiva a cavallo giunse vicino al convento di Ploaghe, i frati si fecero al portone per vederla sfilare.
Il vecchio guardiano disse a voce alta ai suoi confratelli, indicando lo stendardo spiegato:
— È questa la più bella bandiera finora andata a San Paolo di Monti!
Entrati in Florinas, si recarono tutti in casa di mamma Bazzone per accompagnarvi la bambina e per deporvi la bandiera. Ivi fu fatta larga distribuzione di confetti e di torrone alla famiglia, come avevo raccomandato.
In seguito la comitiva si sciolse, e ciascuno si ritirò nella propria abitazione.
La mia bambina, dopo essere andata dalla mamma per farle parte dei confetti e dei torroni, era ritornata in casa della nonna per i preparativi di un nuovo viaggio, che doveva effettuarsi due giorni dopo.
[124]
Uno dei progetti da me fatti, dopo il primo incontro colla bambina, era stato quello di separarla dalla madre, presso la quale la credevo in pericolo per l’avvenire.
Ponderate le cose, consigliatomi colla vecchia, e tutto combinato, fu stabilito di aspettare unii buona occasione per allontanare la bimba da Florinas.
A Portotorres io aveva due sorelle, Maria Andriana e Giustina, maritate a due pastori, colà domiciliati. Era dunque in quel paese che pensavo di collocare la mia figliuola, facendovi a lungo fermare la nonna per meglio assisterla e sorvegliarla, e dubitando che le mie sorelle non avessero tutto il tempo necessario per incaricarsi di lei.
Ne’ miei propositi non frapponevo indugio; ond’è che mi ero dato attorno per effettuare il mio disegno.
Si trovava in quei giorni a Florinas la moglie del mio amico Antonio Giuseppe Zara, un [125] carrozziere florinese, da qualche anno stabilito a Sassari. Costei aveva ricevuto una lettera dal marito, che la richiamava a Sassari; e si pensò di approfittare del legno spedito, per far viaggiare la vecchia e la bambina.
Il giorno susseguente alla festa di San Paolo, la bambina prese commiato dalla mamma, e venne con la nonna a Sassari, dove rimasero una sera. L’indomani, colla carrozza dello stesso Zara, si trasferirono a Portotorres.
La vicinanza di questo paese alla Nurra (mio abituale soggiorno) e la convenienza di poter far dare dalle mie sorelle una buona educazione alla mia bambina, mi avevano determinato a questo passo.
La mamma, ogni sera, conduceva la mia figliuola e gli altri nipotini alla basilica di San Gavino, per far loro insegnare la dottrina cristiana — sempre cantarellando, com’era il sistema d’allora.
Quando avevo piacere di abbracciare o di conferire colla mia bambina, mandavo un messaggio segreto alla nonna; e mio cognato si affrettava a portarmela all’ovile, o ad altro luogo da me designato.
Sedevo Marietta sulle mie ginocchia, giuocavo con essa come un bambino, e cercavo di darle consigli e ammaestramenti. Poi toglievo da tasca l’Ufficio od altro libro, e cercavo d’insegnarle le lettere iniziali.
[126]
Era davvero curioso, vedere il bandito terribile, armato fino ai denti, in uggia alla giustizia, passeggiare fra i macchioni con una bambina di sette anni in braccio! Col cuore pieno di gioia, io baciavo la mia creatura, guardandomi attorno con diffidenza, per sfuggire al pericolo di una brutta sorpresa di carabinieri.

Pareva che al mio fido cane fosse noto il valore del tesoro che custodiva. Esso faceva le feste alla bambina, e sembrava più attento nel far la guardia. Spesse volte l’innocente creatura andava a carezzare il cane e gli sedeva vicino, appoggiandogli la testa sul dorso. E dire che non c’era uomo che avesse osato accostarsi a quella bestia feroce!
Venuta l’ora di separarci, io baciava a più riprese Maria Antonia, e le raccomandavo di far da brava e di essere ubbidiente alla nonna ed alle zie. Dio sa che cosa pensava quell’innocente del mio ritiro selvaggio! Non immaginava certamente la ragione per cui non visitavo la casa della zia, rinunziando alle sue carezze.
— Dove vai adesso, babbo? — mi domandava [127] talvolta, quando le dicevo ch’era l’ora di separarci.
— Vado... a caccia!
— A uccidere gli uccelli?
— Sì: gli uccelli cattivi: i buoni li lascio in pace!
Oh, se i miei giudici fossero stati presenti a queste scene, forse mi avrebbero perdonato!
***
Appresa la dottrina in chiesa, diedi ordine che la bambina fosse mandata alla scuola di Portotorres. Io volevo che la mia figliuola imparasse a leggere ed a scrivere; volevo che per il momento non servisse nessuno.
Per molti anni la mia figliuola frequentò la scuola di Portotorres, sempre sorvegliata dalla nonna, da mie sorelle e dai miei cognati. Mia madre conviveva con una delle figlie, non avendo aderito al mio desiderio, che era quello di ritirarsi in casa a parte, per meglio dedicarsi alle cure della nipotina disgraziata.
Mia figlia contava tredici anni, quando l’insegnante ordinò, che ciascuna scolara cucisse una camicia da uomo, senza portare il lavoro a casa.
Quando ciò seppi, diedi ordine alla nonna che comprasse per la mia figliuola una tela finissima, perchè potesse meglio lavorare, e perchè non si torturasse le dita.
[128]
Il risultato fu ottimo e lusinghiero. La camicia eseguita dalla mia bambina fu giudicata fra le migliori della scuola.
Per meglio assicurarmi che la mia figliuola studiava, pretesi che essa mantenesse con me una corrispondenza epistolare.
Le lettere di mia figlia (che talora mi facevo leggere da altri, poichè stentavo a decifrare il manoscritto) fecero in me nascere il vivo desiderio d’imparare a scrivere. Mi procurai un quaderno; e, colla pazienza di un carcerato, appena ricevevo una lettera di Maria Antonia, ne imitavo le lettere maiuscole e le minuscole; fino a che, dopo due anni, io ero riuscito a rispondere alla mia prima scolara, la quale era diventata la mia maestra. Leggevo gazzette e libri e mi mantenevo in continuo esercizio. Io debbo a quella creatura il poco che so. Nelle mie saccoccie, insieme alle palle, alla polvere ed al coltello, non mancavano mai i quaderni ed il calamaio. Facevo allo stesso tempo il bandito e lo scolaro!
***
In quel frattempo la maestra di Portotorres, volendo correggere una scolara che aveva commesso non so che impertinenza, la percosse e la buttò in terra; tantochè la poverina ne fu malconcia, ammalossi, e ne morì agli otto giorni.
[129]
La maestra era in intimi rapporti col pretore di Portotorres; e raccomandò alle scolare, con minaccie, che nulla dicessero delle percosse date alla scolara morta.
Interrogata la mia bambina dal giudice istruttore, essa si chiuse nel silenzio: non disse bene, nè male. Spaventata però dai continui interrogatori e dalle minaccie della maestra, essa divenne ribelle, e non volle andare più a scuola.
Ciò saputo, feci venire a me la figliuola e le dissi:
— Tu ritornerai alla scuola quando ci sarà una nuova maestra: colla vecchia mi aggiusterò io!
Capitavano spesso nella Nurra, per partite di caccia, amici e consiglieri comunali di Portotorres; ed io mi dolsi con essi del poco conto che tacevano di una maestra che uccideva le scolare.
— O mandatela via — conchiusi — o penserò io a licenziarla!
Seppi, dopo pochi giorni, che il comune aveva diminuito sensibilmente lo stipendio alla maestra, con lo scopo di costringerla ad andarsene.
Intanto io, per affrettare le pratiche, scrissi una lettera all’insegnante, invitandola a recarsi da me. Le dicevo, fra le altre cose, che, anche bandito, potevo offrire ad una signora un pollastro od un capretto.
[130]
La maestra mi rispose con lettera che non poteva soddisfare al mio desiderio, dovendo trasferirsi ad Ozieri, sua nuova residenza. Mi pregava inoltre di lasciar andare con lei la mia figliuola, la quale era studiosissima e poteva far progressi. Intanto mi dava l’indirizzo della casa di Ozieri, presso la quale sarebbe stata a pensione.
Non mi curai più di lei. Il comune aveva nominato una maestra del paese, il cui marito era insegnante della scuola maschile. Questa donna, trovandosi incinta, aveva incaricato la mia figliuola di prendere la lezione alle compagne. Lusingata da simile fiducia, Maria Antonia si determinò a frequentare la scuola per altri due anni.
***
Mia madre si recava di tanto in tanto a Florinas per visitarvi i parenti, ma ritornava subito a Portotorres per sorvegliare Maria Antonia. Ero io che pensava a mantenere la vecchia; e ci tenevo!
Fin dal primo anno che avevo ritirato la bambina da Florinas, Maria Francesca si era recata a piedi fino a Portotorres, per rivedere la sua creatura. La prima volta trovò in casa mia sorella Andriana, la quale si rifiutò a mostrarle la bambina, dicendole ch’era a scuola.
[131]
La seconda volta vi trovò invece mio cognato, il quale, più pietoso, non solo la ricevette, ma l’ospitò in casa una notte, con cruccio della moglie, e con cruccio mio quando me lo riferirono.
Al terzo anno la madre disgraziata si ammalò gravemente di angina, e fece scrivere una lettera alla figliuola, dicendole che voleva abbracciarla prima di morire.
In famiglia non sapevano dove io mi trovassi per chiedermi consiglio. Mio cognato allora, dietro il caso urgente, condusse addirittura la mia figliuola a Florinas per abbracciare la mamma.
Montai sulle furie quando ciò seppi, e sgridai fortemente mia sorella, dicendole che non volevo, senza mio ordine, che la figliuola uscisse da Portotorres. Scrissi subito la seguente lettera a Maria Antonia[19]:
Cara figlia,
«Ti voglio subito in casa a Portotorres. Tu hai fatto uno sbaglio recandoti a Florinas senza il mio consenso. Sei partita senza un mio consiglio e senza i soldi che ti avrei dato. Non lo farai più un’altra volta, spero.
Tuo babbo
Giovanni Tolu.»
[132]
La madre di Maria Antonia, a cui il sindaco mostrò la lettera, asserì che era falsa; ma il sindaco dichiarò che conosceva la mia scrittura.
Mia figlia era ritornata a Portotorres, dopo quattro giorni di assenza.
***
Continuai intanto ne’ miei esercizi calligrafici, e mi ero dato a leggere con più passione libri di ogni genere, specialmente i sacri e quelli che trattavano di fatti bellicosi. Fra gli altri avevo preso diletto a leggere la Bibbia del Diodati. Un mio nipote che studiava per farsi prete, mi avvertì un giorno ch’era un libro da dare alle fiamme.
— Io lo trovo bello e buono, e non lo brucio! — gli risposi.
Volli nondimeno consultarmi con altro prete parente (il teologo Cugurra rettore di S. Catterina) il quale mi disse:
— In fondo non è che un ristretto (!) della vera Bibbia, ma i precetti vi sono sani. Così li osservassero tutti i cattolici, in questi tempi di miscredenza e di pazzie quarantottesche!
Ciò inteso, continuai la lettura del libro sacro di Diodati, e tolsi ogni scrupolo dalla mia coscienza.
[133]
Dopo il ritiro della mia bambina da Florinas, io sentiva nell’anima un sentimento che non sapevo spiegarmi, una gioia mai provata, che mi rendeva quasi felice. Sopportavo con più rassegnazione il disagio e la solitudine; sentivo più vivo il bisogno di amare, e meno intenso l’odio verso i miei nemici Mi sembravo un altro! Un repentino cambiamento si era in me operato. Vi erano momenti in cui mi sentivo capace anche di perdonare.
Quella bella creatura ingenua, quella bambina innocente aveva portato un raggio di sole nella mia anima: mi aveva fatto dimenticare tutte le amarezze che la madre aveva versato nel mio cuore.
Oramai non ero solo: io aveva una casa, avevo una famiglia, per formar la quale ero andato incontro all’odio di tutti.
Preoccupato com’ero di quella fanciulla, per più mesi non avevo potuto pensare ad altri: a null’altro, tranne che a preservarmi dalla persecuzione delle spie e dei carabinieri; perocchè [134] la vita e la libertà mi erano divenute care, dopo aver avvinto al mio destino il destino della mia figliuola, alla quale dovevo procurare tutte quelle felicità, che a me erano state tolte.
Singolare sentimento! Io avevo pietà degli infelici; sentivo il bisogno di proteggere i deboli contro i prepotenti; diventavo buono.
Pensai ch’era necessario dedicarmi al lavoro: preparare un avvenire alla mia figliuola. Non potevo, come prima, sprecar danaro a capriccio — ogni soldo faceva bisogno in casa.
Colla vendita della cera, tolta al legno naufragato, io ero riuscito a raggruzzolare una bella sommetta, gran parte della quale avevo già speso per la bandiera di San Paolo. Ma non ero stato inoperoso. Avevo acquistato un po’di grano, che davo in prestito per il seminerio a’ miei fratelli ed ai cognati, dividendo con essi gli utili a metà. Ne avevo pur prestato ad altri, e nelle mie escursioni non dimenticavo di sorvegliare i campi seminati, per vedere se i lavori erano stati eseguiti con cura e coscienza. Seguivo ansiosamente il corso delle stagioni, preoccupandomi degli eccessivi caldi e dei freddi eccessivi: ogni vento mi turbava, perchè pensavo a’ miei germogli. Mettevo a frutto i danari, che di tanto in tanto mi davano gli amici e i proprietari, e vedevo giorno per giorno crescere il mio piccolo patrimonio. Meno ricercato dalla giustizia, io più non menavo la vita oziosa dei primi anni di banditismo: [135] lavoravo, quasi, come ai bei tempi della mia giovinezza.
Avevo quasi dimenticato l’odio a’ miei nemici.
***
Una mattina, recatomi presso Florinas, mi trovai con Giovanni Antonio Piana, il marito della serva di prete Pittui, già ferito al braccio, e col quale, come dissi altra volta, mi ero riconciliato.
Sedemmo insieme in aperta campagna, e scambiammo alcune parole sui casi della nastra vita. Non so come, egli fece cadere il discorso sul ferimento del suo braccio, avvenuto nove anni addietro. Si doleva vivamente di non aver potuto sfogare la sua collera contro gli autori del tiro, attribuito ai due ladri, da lui fatti arrestare come capitano dei barracelli.
— Ma non li ho perdonati! Se mi verranno a tiro non li risparmierò sicuro! — così esclamò Piana, minacciando l’aria coi pugni stretti.
Io dissi pacatamente, senza guardarlo:
— E faresti male!
— Perchè?
— Perchè uccideresti due innocenti. Essi non ti hanno offeso. Fui io che ti ho sparato!
Giovanni Antonio impallidì, fece un brusco movimento, e mi guardò fissamente, quasi dubitando di uno scherzo. Io rimasi serio.
[136]
— Tu?! — ripetè, fissandomi sempre.
— Proprio io! — gridai con forza, piantandogli gli occhi in faccia, quasi per avvertirlo ch’ero disposto a ripetere il colpo, se non smetteva il piglio minaccioso.
Egli chinò la fronte, e ammutolì tutto tremante. Io continuai con vivacità:
— Fui io, sì! Ti ho sparato perchè tu facevi parte dei misteriosi congiurati, che nell’inverno del 1851 (nove anni fa!) si riunivano in casa di prete Pittui, col proposito di uccidermi, o di farmi cadere nelle mani della giustizia. Insieme ai fratelli Rassu, ai fratelli Dore, allo Zara, al Serra, e parecchi signori di Florinas, tu dichiarasti ch’era facile il colpirmi. Ma volle Iddio che i colpiti foste voi!... Se io ti ho ferito al braccio, anzichè al cuore od alla testa, tu devi solamente ringraziare i tre compagni, coi quali quel giorno stavi, e ch’io non volevo offendere. Al mio occhio non rimaneva scoperto che il tuo braccio, ed al braccio ho puntato per darti una lezione![20]
Giovanni Antonio, colla testa bassa, ascoltava e taceva. Pensai alla mia bambina, e conchiusi:
— Non se ne parli dunque più! Il tuo braccio è ormai guarito, e i tuoi complici sono quasi tutti morti di palla, o di pugnale. Se oggi te ne [137] parlo per la prima volta, è solo perchè voglio risparmiarti l’uccisione di due innocenti.
Da quel giorno non ebbi più alcuna questione con Piana, che tacque questo nostro dialogo. Avevo deciso di far punto alle mie vendette, e di vivere tranquillo insieme alla mia figliuola.
***
In una brutta giornata d’inverno era stato ucciso, nella Viddazzone, un toro ad Antonio Sechi, uno dei fratelli degli amici miei della Nurra.
I sospetti di Antonio caddero su Salvatore Dachena. Risentito del colpo, risolvette di vendicarsi, e venne a trovarmi.
— Mi fai un piacere? — mi disse.
— Sentiamo.
— Dimmi prima se me lo fai!
— Non lo so.
— Ti voglio meco per una notte.
— Per che fare?
— Uccideremo Salvatore Dachena, quando uscirà dalla sua capanna per qualche bisogno. Mi ha ucciso il toro!
— Scherzi? questo è un uomo che fa il fatto suo; non è mai andato alla Viddazzone per ammazzar buoi. Il toro te lo avrà ucciso qualche altro.
— No. So che me lo ha ucciso lui!
— Lasciami pensare, e poi ne riparleremo. [138] Trattandosi del fratello de’ miei cari amici, voglio occuparmene.
Ci separammo. Io mi recai subito da’ suoi fratelli Paolo, Ambrogio e Giovanni Sechi.
— Sono in dovere di avvertirvi, che Antonio ha deciso di uccidere Salvatore Dachena, che egli crede l’uccisore del suo toro. Spetta a voi decidere se questa vendetta sia giusta, o inconsiderata.
— Nostro fratello fu sempre senza testa — disse Paolo — Farebbe invero un bell’affare togliendo dal mondo uno dei nostri più cari amici!
— Aggiustatevela tra voi — risposi — Vi prevengo che egli ha chiesto la mia cooperazione per sbarazzarsi del nemico; ed io son ben lontano dal prestarmi a tali servizi!
Allora i Sechi chiamarono il fratello Antonio e lo rimproverarono acerbamente per le sue sfuriate. Gli fecero osservare, che, non avendo figli, ei poteva sbizzarrirsi a suo talento; mentre essi avevano famiglia, nè volevano fastidi di sorta. Se egli era ben sicuro del suo fatto, poteva compensare il danno col togliere un altro bue dalla tanca del nemico: non però con un assassinio, che avrebbe tolto la pace e la tranquillità a due famiglie.
Le cose si aggiustarono e non si parlò più di vendetta. Io intanto ero riuscito a scuoprire il vero autore dell’uccisione del toro, ma non volli denunziarlo per non suscitare nuovi guai. Tacqui, e non mancai alle regole di cavalleria.
[139]
Da qualche tempo Antonio Sechi mi teneva il broncio, ed un bel giorno lo fermai:
— Perchè quel muso lungo con me? Metti giudizio!
— Non credevo che tu fossi così facile a riferire ai miei fratelli quanto ti avevo confidato!
— Miserabile! Non ti accorgi che sei appassionato e cieco, e che i tuoi fratelli vedono più lontano col naso, che tu cogli occhi? Io ho fatto il mio dovere, e tu farai il tuo desistendo da una vendetta insensata.
Antonio, che in fondo era di buon conto, finì per persuadersi che aveva torto, e mi ringraziò di avergli fatto risparmiare un eccesso.
— Sì: ti ho risparmiato un carico di coscienza; e so quello che mi dico. Un uomo non si uccide per un bue: si uccide per gravi ragioni d’onore e di odio fondato!
I fratelli Sechi mi ringraziarono di non essermi prestato ai capricci di Antonio, il quale era eccitato per il toro rubatogli. Io però non meritava i suoi ringraziamenti, ch’erano dovuti solo a Maria Antonia — alla mia bambina[21]!
[140]
Visitavo da mattina a sera tutti i campi seminati con grano mio, ed ogni tanto davo appuntamento alla mia figliuola, per parlare delle cose nostre, o per raccomandarle l’ubbidienza alla nonna ed alle zie.
Frequentavo, come prima, tutti gli stazzi della Nurra, e, più di tutti, gli ovili dei fratelli Sechi, sui quali potevo contare, perchè fedelissimi amici.
Trovandomi una sera alla Sposada, nell’ovile di Giovanni Sechi, chiesi a costui:
— Sai dirmi dove sia l’ovile di Giovanni Andrea Sedda?
Giovanni mi guardò con occhio diffidente, poichè sapeva che il Sedda aveva molti nemici, e pensava forse che io fossi incaricato di eseguire qualche vendetta per conto d’altri.
— Che ne fai di Giovanni Andrea?
— Desidero abboccarmi con lui, perchè ho appreso che egli ha ucciso due caprioli ad un [141] tiro. Ho bisogno di una pelle per regalarla ad un amico. Non fantasticare, via! Giovanni Andrea mi è amico.
— Quando vi siete conosciuti? — mi domandò Giovanni, non ancora rassicurato sulle mie intenzioni.
— Lo conobbi nelle tanche di Santa Barbara, quando facevo l’agricoltore col suo compagno Baingio Dedola. Sono ripassato di là, per caso, al tempo della messe, ed egli mi ha pregato di far ricerca di una cavalla smarrita, che io infatti rintracciai in una tanca d’Osilo.
Giovanni Sechi parve convinto, e mi rispose:
— Giovanni Andrea Sedda sta nell’ovile di Santa Giusta.
Andai a trovarlo in sul tramonto; ma nell’ovile non trovai che la moglie, la quale non mi conosceva, e si mostrò titubante e dubbiosa.
Allora, per rassicurarla, le consegnai il mio fucile:
— Mettilo là in un canto, e dimmi dov’è tuo marito. Sono inerme!
La donna mi prese l’arma e mi disse:
— Mio marito sarà qui a momenti.
Aspettai il suo ritorno. Quando Giovanni Andrea si presentò all’ovile e mi vide, ci abbracciammo con affetto. La moglie, fuori di sè dalla gioia, ci riabbracciò entrambi. Si era assicurata [142] che la mia visita non aveva uno scopo sinistro[22].
— Sei contenta, adesso? — le dissi — Dammi il fucile, poichè non posso farne senza. Tuo marito mi è amico!
Pernottai nell’ovile. L’indomani, dopo pranzo, si andò insieme a caccia di lepri e di pernici, in compagnia di altre quattro persone. I cani scovarono una lepre, che io sparai col fucile carico a palla, colpendola alla testa. Poco dopo, sempre a palla, presi di mira una pernice lontana e l’uccisi.
Giovanni Andrea mi fece i complimenti, dicendosi impressionato della mia bravura nel tiro, che conosceva solo per fama.
Verso sera, quando ci trovammo soli, egli mi propose, in tutta segretezza, di tenergli compagnia per togliere di mezzo un suo nemico.
— Chi mai?
Egli esitò alquanto, poi mi disse:
— Antonio Francesco Piu.
— Tuo cognato?!
— Lui! Andremo a Portotorres a trovarlo; saremo in sei. Tu sparerai, se ci sarà bisogno, altrimenti poco importa: avrai ugualmente i 200 scudi che ho deciso di darti.
Io gli risposi serio:
[143]
— Dimmi, Giovanni Andrea: saresti tu contento ch’io ti uccidessi, se tuo cognato mi offrisse 200 scudi? Tu, son certo, mi sborserai simile somma con sacrifizio, mentre tuo cognato potrebbe anche duplicarmela... Via, ricorriamo ad altri mezzi! A me basta l’animo di mettervi in pace, senza spargere sangue e senza gettare la discordia nelle vostre famiglie.
Giovanni Andrea esclamò:
— Non sai tu, dunque, che siamo otto uomini in causa, e se lui vive possiamo ritenerci perduti?
— Non preoccupartene. Dimmi solo: ci hai tu amici, nella Nurra, che ti vogliano bene?
— Ne ho molti.
— Ebbene, portami dal tuo più fido!
— Conosci Agostino Deroma, ricco proprietario della Nurra?
— Oh altro! è un uomo buono, e mi piace. Andremo insieme da lui.
Giorni dopo, infatti, andammo insieme all’ovile di Saccheddu, in San Giorgio.
Trovandomi solo con Agostino, gli dissi:
— Dimmi, Agostino: vuoi tu bene a questi fratelli Sedda?
— Sinceramente, come se mi fossero figli. Li ebbi pastori fin dal giorno che li ho allevati in casa mia.
— E ad Antonio Francesco Piu vuoi tu bene del pari?
[144]
— Gli voglio bene, perchè per tre volte mi è compare di battesimo.
— Vorresti, dunque, fare un buon servizio per il bene comune delle due famiglie?
— Ben volentieri, se mi sarà possibile. Dimmi che cosa vuoi.
— Orbene: tu devi andare a Portotorres per presentarti al tuo compare Antonio Francesco Piu. Fissandolo bene in viso per vedere l’effetto delle tue parole, gli dirai così: «State in guardia, compare, poichè ho veduto Giovanni Tolu in stretto colloquio con Giovanni Andrea Sedda ed altri vostri cognati!» Mi riferirai al tuo ritorno l’impressione risentita da Piu. Null’altro.
— Se non è che questo, sei bell’e servito!
Ritornato Agostino da Portotorres, mi riferì in confidenza, che Antonio Francesco Piu aveva impallidito e si era turbato.
— Benissimo. Ora lo abbiamo in mano! — esclamai contento; e rivolto ad Agostino:
— Chiedo un altro favore. Fra una quindicina di giorni ti recherai di nuovo da Antonio Francesco per riferirgli in nome mio, che ho bisogno urgente di abboccarmi con lui.
La risposta di Piu a Deroma fu questa:
«— Dirai a Tolu, che non posso per ora recarmi da lui; ma, se avesse bisogno di qualche cosa, me lo faccia sapere, chè lo renderò soddisfatto, senza pur bisogno dell’abboccamento.»
Raccomandai allora ad Agostino Deroma [145] di comunicare al Piu, ch’io desiderava la sua riconciliazione coi cognati e cogli altri suoi nemici.
La risposta fu, che sarei stato soddisfatto.
Le cose prendevano dunque una buona piega, ed io non frapposi indugio a conchiudere la pace.
Parlai di questo fatto con Giovanni Sechi e con altre persone autorevoli e assennate della Nurra; ma tutti mi dichiararono di non aver fiducia nella parola di Piu, il quale non era uomo da mantenerla; motivo per cui sarebbe tornata vana la generosa opera mia.
— Dio voglia che egli mi dia la parola! — risposi — se poi vi mancasse, penserò io ad aggiustarlo!
***
Fermo nel mio proposito, trovai modo di riunire una settantina di persone in un dato punto; e quindi invitai Piu a recarsi alla Nurra.
Egli vi accorse in compagnia di tre suoi amici: Antonio Vincenzo Melis, Miali Ghera, e Filippo Cano, il famoso cacciatore.
Per luogo di riunione era stato scelto un vasto campo nella regione di Puttu Esse, sebbene io avessi proposto di riunirci in montagna, per essere più al sicuro. Mi si era fatto osservare, che essendo in settanta, e tutti armati, si [146] poteva far fronte a cento carabinieri, in caso di un assalto.
— Quando i pericoli sì possono evitare — soggiunsi — è sempre meglio. Parmi stoltezza mettere a repentaglio la vita per futili motivi.
Gli amici insistettero, ed io mi lasciai convincere a rimanere in Puttu Esse.
Tutta la mattina fu impiegata nel divertimento del tiro al bersaglio. Il bravo cacciatore Filippo Cano prendeva diletto a misurarsi con me, ma io fui fortunato, e lo vinsi in tutti gli spari; poichè tenevo a non fallire un colpo, quando mi trovavo in compagnia d’altri.
Mentre le carni erano tutte al fuoco — poco prima di andare a pranzo — determinai di sbrigare la cerimonia delle paci.
La numerosa comitiva, divisa qua e là in gruppi, era intenta a discutere e a chiacchierare allegramente. Chiamai allora da una parte Antonio Francesco Piu e i suoi tre amici, e dissi loro, ridendo:
— Vogliamo finirla colle ciancie? Bisogna prima far le paci!
— Figlio mio — prese a dire Miali Ghera, ch’era il più anziano — noi nulla sappiamo di queste ragioni e di queste paci. Fa tu; disponi come meglio credi, e noi seguiremo il tuo consiglio.
— Ebbene, m’incaricherò io della cosa; ma fate silenzio e lasciate per un poco le ciancie.
[147]
— Aggiustati, figliuolo! noi siamo qui a tua disposizione.
Mi rivolsi a Piu, ch’era presente e non parlava.
— E tu, Antonio Francesco, dichiari di sottostare a quanto farò io?
— Ti ho dato la mia parola e la manterrò fino alla morte. Quello che ti piacerà fare sarà sempre ben fatto: per me e per gli altri!
— Sai che cosa dico? Dio vi guardi da una leggerezza! Colui che mancherà di parola, non avrà più da fare coi propri nemici, ma con me: con Giovanni Tolu, che ha assunto l’incarico di ravvicinarvi. Il bandito della Nurra, saprà punire il traditore della fede!
— È intesa! — esclamarono tutti.
Feci in seguito chiamare Giovanni Sedda, e tolsi da tasca una reliquia, che tenero involta in un fazzoletto. Questo talismano, benedetto da un prete, lo portavo sempre meco, poichè serviva per il bestiame malato. Lo si cuopriva di terra e vi si faceva passar sopra la mandra. Talvolta le faceva bene, tal altra non faceva nulla.
Presa in mano la reliquia, dissi rivolto a Sedda:
— Farai, tu, quanto ti comanderò di fare?
— Sono disposto a farlo!
— Orbene: tu, che sei il più anziano della famiglia, dovrai cresimare un figlio di tuo cognato Antonio Francesco Piu; e così voi sarete compari [148] d’olio santo. T’impongo pure in penitenza, che, tanto tu, quanto i parenti e gli amici tuoi, ogniqualvolta vi recherete a Portotorres, non dimentichiate di far visita a Piu nella propria abitazione; e se Piu per caso non vi fosse, visiterete la moglie, o la famiglia, o la sua casa. Voglio che ciò si adempia! Farai tu il tuo dovere?
— Lo farò.
— Lo giuri?
— Lo giuro.
Recitato il mio sermone, invitai Antonio Francesco Piu e Giovanni Sedda a mettere la mano sulla reliquia benedetta. Compiuto il giuramento, dissi loro:
— Manca ancora una formalità.
— Quale?
— Il bacio della pace.
I due cognati si abbracciarono e si baciarono con trasporto.
Ottenuta la conciliazione di questi due, feci chiamare l’altro fratello Baingio Sedda, a cui domandai:
— Farai tu quanto ti comanderò di fare?
— Fino a morire!
— Orbene: appena tua moglie ti partorirà un figlio od una figlia, devi invitare Antonio Francesco Piu, tuo cognato, a tenertelo a battesimo; e così sarete compari; e quando ti recherai a Portotorres, o vi andranno i tuoi parenti ed amici, non dimenticherete di visitare in casa la [149] sua famiglia. Così voglio, e così sia. Sei disposto ad ubbidirmi?
— Con tutto cuore.
— Lo giuri?
— Lo giuro.
Alla mia esortazione seguì il solito giuramento sulla reliqua, l’abbraccio, e il bacio della pace.
Allo stesso cerimoniale sottoposi Giovanni Andrea Sedda, terzo cognato di Antonio Francesco Piu.
Venne poscia la volta di Giovanni Foi e di Baingio e Salvatore Pinna, ai quali feci la stessa esortazione, invitandoli al giuramento, all’abbraccio ed al bacio.
I chiamati erano stati sei, poichè Piu mi aveva dichiarato di non conoscere altri nemici. Io non insistetti per prudenza, ma sapevo che ve n’erano parecchi altri, a lui ignoti. Non volli menzionarli per non tradirli, disposto com’ero ad adoperarmi perchè non gli facessero male.
Compiuta la cerimonia delle paci, si andò tutti a pranzo, in numero di oltre settanta.
***
Sdraiati sull’erba si mangiò con molto appetito, e regnò fra i numerosi commensali la più schietta allegria.
Sul finire del pranzo Filippo Cano, l’ottimo [150] cacciatore, buttò in aria un piatto, e poi lo mandò in frantumi con una fucilata a pallini.
— Buttàtene un altro in aria! — gridai scherzando — chè non voglio lasciar solo un buon tiratore come il signor Filippo!
Fu lanciato un piatto a grande altezza; ed io, che avevo il fucile carico a palla, lo puntai e feci fuoco, rompendolo in due. Tutti i commensali proruppero in applausi, vantando il mio difficile tiro.
La comitiva volle in seguito divertirsi a tirare ad una grossa bottiglia, alla distanza di 200 passi. Io me ne stavo in distanza, senza prender parte alla gara. Parecchi amici si accostarono a me:
— Perchè non spari?
— Perchè da un’ora non siete riusciti ad uccidere una bottiglia. Se io sparo l’uccido, e voi non vi divertirete più.
— Pròvati!
Puntai la bottiglia. Il primo colpo mi andò fallito; col secondo mandai la bottiglia in frantumi.
In altra parte del campo una ventina di tiratori erano intenti a sparare, a 70 passi di distanza, un piccolo bicchiere, nel quale avevano messo un fiore di papavero. Nessuno ebbe la fortuna di colpirlo.
Io, che stavo in disparte, conversando coi fratelli Sedda, mi avvicinai alla brigata:
[151]
— Perdio! voi fate vergogna ai tiratori. Siete da mezz’ora consumando polvere e palle, e non riusciste a rompere un bicchierino.
— Colpiscilo tu, dunque!
— Non col mio fucile — dissi sorridendo — ma colla mia pistola.
E armato il grilletto puntai... e il bicchierino andò in pezzi.
Era la terza vittoria che io riportavo quel giorno, dinanzi alla numerosa brigata, là convenuta per assistere alle paci. Non dovevo certo vantare a mia superiorità sugli altri. Fin da ragazzo mi ero esercitato nel bersaglio, e la mia condizione di bandito mi aveva aguzzato maggiormente l’occhio. Ci era di mezzo la vita, se io falliva un colpo!
Quel giorno, nel campo di Puttu Esse, erano intervenute molte donne, per preparare il pranzo a settanta persone; ma vi mancava la moglie di Antonio Francesco Piu, dalla quale da tempo egli viveva separato. Questa separazione era stata la causa prima dell’inimicizia coi cognati.
Alcune di queste donne, verso sera, mi chiamarono in disparte, per raccomandarmi di rendere complete le paci, col ravvicinamento del marito alla moglie.
— Per oggi dovete rinunziarvi — risposi — Vi prometto di occuparmene un’altra volta.
Sull’imbrunire presi commiato dalla comitiva, e ciascuno tornò a casa.
[152]
***
La riunione a Puttu Esse aveva avuto luogo nei primi di maggio del 1858. Venuta la festa di San Gavino — la quale chiama molto concorso a Portotorres — consigliai i cognati e le cognate di Piu di condurre con loro alla casa di quest’ultimo la moglie Maria Antonia e le sorelle, come per fargli visita.
Si eseguì quanto io avevo consigliato.
Quando Antonio Francesco Piu, entrando in casa, vide la propria moglie, parve comprendere, e le disse tra il dolce e il grave:
— Tu sei già stata altra volta in questa casa. Se vuoi rimanere, sei padrona; se vuoi andartene, fa il piacer tuo. Dal canto mio ti dico, che sarebbe meglio di fermarti!
Si pianse tutti di commozione, e fu una giornata indimenticabile. I cognati e gli amici presero commiato da Antonio Francesco Piu, lasciandolo solo con Maria Antonia; la quale, da quel giorno, visse in pace col marito, e benedisse la provvidenza che le aveva risparmiato tante amare lagrime.
Quando la comitiva tornò alla Nurra, le andai incontro sorridendo:
— E Maria Antonia? — chiesi.
— È col marito! — risposero tutti allegramente, e mi narrarono la scena avvenuta.
[153]
— Vedete? — conchiusi. — Quando c’è Dio per lo mezzo, le cose si aggiustano sempre; ma bisogna credere in Dio, e non fare la vita dei beduini!
Antonio Francesco Piu si era riconciliato coi nemici, e la giustizia volle tutti dimenticarli. Ed è così che si fanno le paci: coll’amore, e senza spargere una goccia di sangue.
Non pochi pastori della Nurra avevano dubitato della fede di Piu; eppure s’ingannarono. Le paci durarono a lungo, e fu una grazia per le due famiglie, ch’erano alla vigilia di distruggersi a vicenda.
Soddisfatto e felice dell’opera mia, io ritornai nella solitudine: alla mia vita randagia e tribolata. Tutti erano contenti — meno io ch’ero riuscito ad ottenere la pace altrui.
Per me non vi era che la dolce immagine della mia bambina; e quando alla sera, stanco e sconfortato, mi sdraiai in un macchione, recitai la mia solita preghiera pensando a lei — alla mia piccola santa!
[154]
Le paci fatte a Puttu Esse, nonchè la riconciliazione dei coniugi Piu, valsero a rendermi popolare nella Nurra, attirandomi le simpatie di molte persone rispettabili di Sassari e Portotorres.
La mia riabilitazione cominciava.
Datomi alla macchia nel 1851, per sette anni i miei casi si erano svolti in un’alterna vicenda di bene e di male. La mia vita era stata come un’incostante giornata di novembre: — qua un lembo d’azzurro, là una nuvoletta che offuscava il sole; a levante uno sprazzo di luce, a ponente un orizzonte nero, che preannunziava il temporale.
Forte nell’amore della mia figliuola, da tre anni vivevo tranquillo. L’odio non aveva più tormentato il mio cuore, e la giustizia era stata meno feroce nel perseguitarmi. Ma forse non meritavo tanta felicità, poichè il destino volle mettermi di nuovo a dura prova.
Sull’imbrunire di un giorno di maggio, in Badde Cubas, percorrevo a cavallo un cammino reale (così noi chiamiamo una strada di passaggio, [155] e di molto trafico in aperta campagna). Tormentato da più giorni da un foruncolo all’anca, avevo ripiegato a mo’ di cuscino il mio cappotto sulla sella, per meno inasprire la piaga.
Ad un tratto mi trovai di fronte ad una brigata di sette uomini, che cavalcavano di conserva. Li credetti carabinieri, poichè uno di essi montava un cavallo grigio, simile a quello che soleva portare il brigadiere.
Piedi di sprone al cavallo e mi cacciai in un cammino falso (scorciatoia poco battuta).
La trottata a precipizio mi aveva inasprito il foruncolo, in modo che n’ebbi la febbre per parecchi giorni.
Non senza disagio giunsi a Monte Rasu, all’ovile della vedova di Paolo Sechi (l’amico del famoso bandito Alvau) dove con frequenza solevo recarmi. Deciso di fermarmi colà fino a guarire, consegnai il mio cavallo ad un servo, perchè me lo custodisse in una tanca vicina, per averlo pronto in caso di bisogno.
Parecchi giorni dopo il mio arrivo all’ovile, erano usciti dalla stazione di Portotorres quattro carabinieri a cavallo, diretti alla Nurra. Essi passarono in Puttu Esse, dove un certo Cosimo Mannu lavorava la terra, insieme ad altri compagni.
Era costui ritenuto dal popolo come un indovino, perchè in fama che ogni notte i morti lo portassero in giro.
[156]
Vedendo passare i quattro carabinieri, egli aveva esclamato rivolto ai compagni:
— È strano! Io vedo due morti su quel cavallo!
— Non ti accorgi che sono quattro carabinieri vivi? — gli dissero i compagni per canzonarlo.
— No, vi dico! due di essi li vedo morti, e non ritorneranno a Portotorres!
Questa predizione, che mi venne riferita più tardi dagli stessi lavoratori, aveva fatto il giro della Nurra, e fu argomento di chiacchiere, le quali avvalorarono la chiaroveggenza di Cosimo Mannu.
Io intanto me ne stavo tranquillo a Monte Rasu, poichè l’ovile era un ritiro sicuro.
Dopo essermi aggirato una mattina nei d’intorni di Monte Rasu, entrai un momento nella capanna isolata, dove si trovava Maria Antonia Dore, vedova di Paolo Sechi, intenta alla lavorazione dei formaggi.
Entrato per mangiare un boccone in fretta e furia, mi ero chinato sul focolare (scavato nel centro della capanna) per accendermi la pipa con un po’ di bragia.
Mentre stavo curvo, frugando colla pinzetta nella cenere, intesi il latrato del mastino, ch’era legato a poca distanza dall’ovile, e in pari tempo lo scalpitare di più cavalli che si avvicinavano.
Mi rizzai in piedi sgomentato, ed armai i due grilletti del fucile, che impugnavo colla sinistra.
[157]
La capanna aveva due porte d’ingresso (l’una di contro all’altra) chiuse da battenti, in cui era praticato un largo finestrino, per lasciar passare l’aria e la luce — come è uso in quasi tutte le case di campagna, e specialmente nella Nurra.
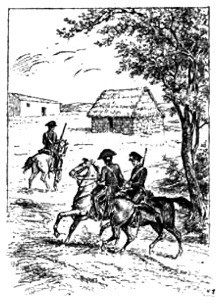
Come levai gli occhi al finestrino che avevo di fronte, vidi un carabiniere che guardava dentro la capanna col fucile sul pronti. Gli altri tre compagni, arrivati subito dopo, erano smontati da cavallo, fermandosi a buon tiro verso le due porte — in modo da impedirmi l’uscita, se avessi tentato scappare.
Era l’identico caso di Monte Fenosu — ma con maggior probabilità di riuscita per parte dei carabinieri, poichè sicuri che la belva si trovava al sicuro.
Raccolsi tutto il mio sangue freddo, e pensai di sfuggire all’agguato, ricorrendo ai mezzi che mi erano abituali: all’audacia ed al coraggio.
Puntai addirittura il carabiniere che avevo [158] di fronte, e feci fuoco. La mia palla lo aveva passato da parte a parte, ed egli precipitò di sella.
La vedova di Paolo Sechi, che accudiva ai formaggi, si era data a correre di qua e di là, strillando come forsennata; ma io, che volevo non risentisse alcun danno, fui pronto ad afferrarla per la vita, e la buttai in un canto della capanna, dicendole:
— Che fai? Vuoi morir forse crivellata dalle palle?
Così dicendo mi voltai di scatto verso la porta opposta; posi il dito sul grilletto della canna carica, e mi precipitai con impeto all’aperto. Veduto l’altro carabiniere, che alla distanza di 45 passi cercava di colpirmi, mi fermai di botto, lo presi di mira, feci fuoco, lo vidi cadere, e continuai la corsa verso il largo.
Raggiunto il muro di cinta della tanca, e non riuscendo a scavalcarlo per il foruncolo che mi tormentava l’anca, mi diressi all’imbocco della viottola vicina, dov’era legata la cagna che allatava i piccini. Questa mi si avventò come una tigre, addentandomi la giacca. Liberatomene con uno strappo, presi allora una seconda viottola, dove i due carabinieri mi raggiunsero, facendomi tre scariche quasi a bruciapelo.
Continuai a correre come un capriolo, fra le palle che mi fischiavano all’orecchio.
Seppi in seguito, che i carabinieri, credendo di avermi gravemente ferito, erano venuti a frugare [159] fra le macchie, sperando di rintracciare il mio cadavere. Ma io in quel momento ero già lontano, salvo, e recitavo il rosario per l’anima dei trapassati.
I due carabinieri, da me feriti gravemente, furono la stessa sera trasportati su due carri a Portotorres, ed entrambi morirono.
Fu asserito da taluni, che i quattro carabinieri non erano venuti a Monte Rasu in cerca di me, ma bensì in cerca d’acqua per abbeverare i cavalli. Niente di più falso! Essi non avevano bisogno di spingersi fino all’ovile di Paolo Sechi per provvedersi d’acqua. Usciti da Portotorres avevano passato la notte nell’ovile di Vigliano Addis e dei fratelli Gianichedda, dov’era molt’acqua. La mattina seguente, verso le 9, avevano attraversato il fiumicello di Boturru, coll’acqua al ginocchio, e vi potevano abbeverare i cavalli. Percorso altro breve tratto di strada, erano passati dinanzi all’abbeveratoio della Sposada, con acqua abbondantissima e buona. Di là a Monte Rasu non sono che 10 minuti di strada; motivo per cui non era la sete dei cavalli che li spingeva alla capanna isolata, dov’io mi trovavo, sofferente per il foruncolo.
Era precisamente a Boturru che essi avevano a lungo conferito con certo Domenico Tignosu, loro fiduciario; e già sognavano di avermi nelle mani.
Domenico Tignosu, dopo lo scontro di Monte [160] Rasu, si era infatti affrettato a lasciar la Nurra per stabilirsi a Sassari, prevedendo giustamente ch’io non gli avrei risparmiato la pelle.
È questa la verità vera; tutte le altre sono fandonie, messe in campo per scusare la poca accortezza di quattro carabinieri imprudenti, i quali si lasciarono sfuggire un bandito, dopo averlo bloccato in una capanna isolata[23].
***
Sfuggito per miracolo alle fucilate di due carabinieri, continuai a correre per una mezz’ora in campagna aperta, fino a che mi cacciai in un macchione, dove rimasi quasi tre giorni senza [161] prender cibo. Avevo la febbre, perchè il foruncolo all’anca mi si era alterato, e non potevo muovermi.
Vivamente impressionato della morte dei due disgraziati, non ringraziai neppure il Cielo di essere uscito illeso dalle palle dei carabinieri.
Ciò non deve recar meraviglia: era l’effetto d’una mia fissazione. Sentivo dentro di me una forza superiore, che non sapevo spiegarmi. Più cresceva il pericolo, e più diventavo audace. Se mi avessero detto: «là vi sono tre uomini appiattati che bisogna affrontare!» non avrei esitato un momento a scagliarmi contro di essi. [162] Nessuno de’ miei compagni vantava quest’impeto temerario. Lo stesso Cambilargiu invocava spesso la mia compagnia, confessando che meco sentiva più coraggio. Se però ero audace in campo aperto, diventavo all’incontro un pusillanime all’imbocco d’una viottola stretta, o dinanzi ad un nero macchione. Ero capace di fare un lunghissimo giro, pur di non avventurarmi in una viottola sospetta. Dicevo a me stesso:
— Quando l’uomo ha la fede in Dio, o la coscienza della propria ragione, egli deve affrontare qualsiasi pericolo. Se la nostra causa è ingiusta, soccomberemo; ma se è giusta, riusciremo a sfuggire alle palle di cento fucili.
Molti credettero che io possedessi un talismano, che mi rendesse invulnerabile. Dicerie ridicole! Il mio talismano era la cieca fede nel volere del destino.
***
Dopo essere stato tre notti e due giorni dentro ad un cespuglio, mi diressi ad una capanna, dove mi sfamai con pane fresco. Di là passai nell’ovile di un amico, col quale pochi giorni prima avevo scambiato il fucile. Come mi vide, mi disse sorridendo:
— Vedo che il mio fucile ti va bene!
— Benissimo — risposi — In mia mano stanno bene tutti i fucili. Quando la canna è [163] diritta, l’occhio non può trovarsi a disagio nel prendere di mira un bersaglio.
Dopo lo scontro di Monte Rasu, molte squadriglie di carabinieri si aggirarono nella Nurra per darmi la caccia. Vennero anche disposti alcuni appiattamene nella speranza di cogliermi; ma io seppi deludere gli agguati.
Dirò anzi, che appunto in quel tempo ebbi a tiro diverse volte i carabinieri. Una mattina, fra le altre, tre di essi vennero a mangiare e a chiacchierare sotto il crepaccio d’una roccia, nel quale mi ero cacciato un’ora prima. Se io lo avessi voluto, avrei potuto ucciderli facilmente; ma a quale scopo? Ho sempre risparmiato i carabinieri, poichè per essi non avevo mai nudrito odio — come mai ne hanno nudrito i miei compagni. Non conobbi mai bandito, anche fra i più efferati, che siasi vantato di aver fatto fuoco contro un carabiniere, quando da questi non era stato molestato.
L’autorità giudiziaria si preoccupa molto dello sparar prima o dello sparar dopo in uno scontro coi carabinieri. Ma, santo Iddio! vorrei vederli i signori giudici nei panni di un bandito, in simili frangenti! Il problema parmi facile a risolvere. Non già chi spara prima, ma chi spara dopo corre il pericolo della vita. Ognuno può riuscire a sparar primo, ma nessuno riuscirà a sparar secondo, se il primo ha l’occhio buono. Una sola cosa bisogna notare: che tutti i carabinieri io li ho colpiti al petto!
[164]
Confesso che mi spiacque l’incidente di Monte Rasu, e compiansi sinceramente i due poveretti, che caddero vittima della propria imprudenza, più che del proprio dovere. Da tre anni non perseguitavo nessuno. Non solo andavo in cerca di miei nemici, ma pregavo il destino che non li mettesse sui miei passi nei giorni dell’ira. Dopo l’incontro colla mia bambina erano altri i miei intendimenti!
Non devo però qui tacere, che la vista dei carabinieri a Monte Rasu mi gelò il sangue. In quel momento non pensai che a Maria Antonia — alla mia figliuola, la quale, se fossi stato là ucciso, sarebbe rimasta orfana e sola sulla terra. Divenni feroce, perchè mi sentivo più attaccato alla vita.
Non da me, ma dal destino vennero uccisi i due carabinieri di Monte Rasu. E fu questo l’ultimo sangue umano sparso dal bandito Giovanni Tolu!
[165]
Fu intorno a quel tempo, che, senza volerlo, cominciarono a pervenirmi le notizie sulla condotta di mia moglie a Florinas. Dico senza volerlo, poichè non mi ero mai occupato di lei, nè di lei volevo mi si parlasse mai. Mi contentavo di lasciare quella disgraziata in preda al suo destino. Vivente nell’abbandono e nella miseria, ella trascinava l’anima nel rimorso e il corpo nel digiuno, in espiazione d’una colpa a entrambi fatale.
Per diversi anni il paese aveva ritenuto Maria Francesca come una donna savia, rassegnata a subire cristianamente la sua cattiva sorte. Io, invece, da qualche tempo ero informato, che il contegno di lei non era così onesto ed esemplare, come si dava ad intendere ai credenzoni. Il sospetto d’una tresca, che prima vagamente e poi con più insistenza si metteva in giro, era diventato realtà.
Una donna che abitava nella casa vicina, affacciandosi per più notti ad una finestra che [166] dava sul tetto della casupola di Maria Francesca, aveva udito distintamente la voce di un uomo. Sorpresa dalla strana conversazione in casa della sarta ad ora sì tarda, ne aveva dato avviso ad alcuni amici; i quali, volendo conoscere il misterioso visitatore notturno, avevano deciso di fargli la posta per darsi spasso[24].
Nei villaggi — dove i passatempi son pochi, e molti gli oziosi — gli scandali servono di pascolo ad ogni ceto di persone, buone e cattive. Quei curiosi rimasero in vedetta lungo la notte; finchè al mattino, un’ora prima dell’alba, videro aprirsi la porta della casupola di Maria Francesca, ed uscirne un uomo incappucciato. Pedinatolo per diverse mattine, riuscirono a ravvisarlo. Era Baingio Maronzu, modesto macellaio, piccolo commerciante di bestiame, e amante di mia moglie.
La notizia si divulgò, fece chiasso, divenne pubblica. Le comari del paese, la cui lingua non riposa neppur nel sonno, si diedero a commentarla, ora accusando, ed ora scusando Maria Francesca, a seconda i rapporti di amicizia o di parentela coll’adultera. Alla piccante avventura (per sè stessa poco singolare) si volle dare una grave importanza per i personaggi che vi erano implicati. Trattavasi della moglie di un [167] famoso bandito vivente, e di un ganzo ammogliato, padre di cinque figli. Si diceva da tutti con raccapriccio:
— Che farà Giovanni Tolu dei due colpevoli?!
Ma Giovanni Tolu era tranquillo nella Nurra, nè pensava a consumare una carica di polvere e due palle contro una donna che più non gli era moglie, ed alla quale, da qualche anno, aveva strappato la figliuola, prevedendo quanto sarebbe avvenuto.
Dopo la nostra separazione — come ho detto ultra volta — i genitori di Maria Francesca non si erano più recati a far visita alla figliuola, nè avevano ad essa permesso di visitarli con troppa frequenza. Essi davano ad intendere, che ciò si voleva per non inasprirmi; ma il vero scopo era quello di non volersi sagrificare a soccorrere la poveretta, da essi traviata.
Eppure io sapeva, che Salvatore Meloni e sua moglie, tanto schizzinosi nell’avvicinare la figliuola, non sentivano scrupolo a ricevere in casa Baingio Maronzu; il quale faceva loro parte delle carni che macellava. La studiata generosità era servita di mezzo al buon amico per la sua relazione illecita con Maria Francesca; la quale, in quel tempo, aveva forse più bisogno di pane, che delle carezze di un padre di cinque figli!
Quando la notizia della tresca pervenne alla Nurra, già da una settimana ero informato di uno [168] scandalo maggiore. I miei parenti, che vigilavano ad occhi aperti, erano venuti a dirmi:
— Bada, Giovanni! Tua moglie trovasi in istato d’inoltrata gravidanza!
L’ambasciata non mi giunse amara, nè mi fece montare sulle furie; pensai invece a premunirmi contro lo scandalo, rendendo pubblico il fallo di mia moglie.
Feci subito scrivere due lettere a Florinas: una al sindaco dottor Serra, e l’altra al rettore Dettori, annunziando loro la gravidanza illegittima di mia moglie, ed avvertendoli di farla sorvegliare, perchè allevasse la creatura che da lei sarebbe nata.
Ammonita da entrambi sollecitamente, Maria Francesca protestò contro la diceria calunniosa; ma il dottor Serra le fece conoscere la pena che il Codice Penale infliggeva, a chi avesse tentato di far sparire il frutto della propria colpa.
— Il fatto è ormai noto al paese — conchiuse il sindaco — ed io più di ogni altro sono in grado di affermare il vero!
I miei parenti, dietro gli ordini da me ricevuti, raddoppiarono la vigilanza, benchè inutilmente. La scaltra donna, assistita da alcune comari compiacenti, riuscì a mandar fuori di casa il neonato, senza che alcuno se ne avvedesse. Il bambino fii esposto e raccolto nel paese di Bonnanaro, e i due funzionari non poterono far nulla.
[169]
Sparsasi la voce dell’interessamento da me preso per la gravidanza di mia moglie, i due adulteri si sgomentarono, credendo scioccamente ch’io non avrei frapposto indugio a massacrarli. Da soli tre giorni era avvenuto il parto, quando i due colombi lasciarono Florinas per fuggirsene a San Gavino Monreale, al di là di Oristano. Mia moglie riuscì a collocarsi come balia a Cagliari; e Maronzu, non ritenendosi abbastanza sicuro nell’isola, si recò a Portotorres, e di là prese imbarco per Marsiglia, abbandonando la druda, la moglie, e tutti i suoi figliuoli.
Morta la bambina affidatale come balia, Maria Francesca lasciò Cagliari per ritirarsi nel villaggio di San Gavino Monreale, dove non tardò a raggiungerla il suo drudo, stanco della vita miserabile che menava in Francia.
Dopo circa due anni di assenza, l’uno e l’altra vollero far ritorno a Florinas; ma vivendo in continue angustie per paura della mia vendetta, spiccarono di nuovo il volo per San Gavino. Ivi Baingio acquistò una casetta in nome di mia moglie, coi risparmi fatti nella miniera di Monteponi, dove venne accettato come manovale.
Non sono molti anni che quella donna leggera, benchè inoltrata negli anni, si separò dal drudo per unirsi ad un vecchio militare in ritiro.
Così appresi per caso dalle chiacchiere degli amici — poichè, lo ripeto, non volli mai occuparmi di una donna, che non ho riveduto da [170] oltre quarant’anni, e che spero di mai più rivedere in questo mondo, nè nell’altro.
La voce pubblica (che viene chiamata voce di Dio, sebbene non ne azzecchi mai una!) andava dicendo, che io avessi più volte tentato di uccidere i due adulteri, tendendo loro un agguato. Nulla di più falso! — Dirò, anzi, che più d’una volta ebbi a tiro di fucile Baingio Maronzu, ma mi guardai di spararlo, per non perdere una carica di polvere e due palle. Così pure dirò, che facilmente avrei potuto uccidere Maria Francesca; poichè se da lei mi fossi creduto offeso, sarei stato capace di pugnalarla nella propria casa, dentro Florinas. Ho già detto, come per togliere la vita a Francesco Rassu (da me ferito in campagna) io mi fossi spinto fin sulla soglia della sua abitazione, poc’ora dopo che n’erano usciti il medico ed il pretore.
Perchè, d’altronde, uccidere Maria Francesca? La pagavo col disprezzo, ma non l’odiavo. Giovane inesperta, mal consigliata, abbandonata da’ suoi genitori, vivente nella miseria, era caduta nel fango per colpa d’altri: di quel sordido prete, a cui Dio avrà chiesto conto dell’anima buona da lui traviata. Chi lo sa? forse io devo alla piccola Maria Antonia, se non divenni allora un ussoricida. Non avrei certo esitato ad uccidere mia moglie; ma non potevo uccidere la madre della mia figliuola!
Erano dunque abbastanza puniti i due adulteri, [171] ed io per essi non dovevo compromettere la mia coscienza. Baingio Maronzu, d’altra parte, non si era unito a mia moglie, ma ad una donna da me ripudiata, e che più non mi apparteneva. Anch’io era stato reo dello stesso peccato, nè avrei saputo in altri punirlo[25].
Per Maria Francesca si era avverata la mia profezia. Dopo la nostra separazione avevo detto a’ suoi parenti: — voi ne farete una sgualdrina!
Destino di questo mondo! Io, abile lavoratore; lei, buona massaia, eravamo nati per vivere felici nella nostra casetta di Florinas. E invece, che fu di noi? Battemmo disgiunti una falsa strada: quella dell’infamia. Chi eravamo noi? Io, il bandito della foresta — lei la druda di un ammogliato. Fuggiaschi entrambi da un punto all’altro dell’isola, avevamo bisogno di nasconderci: lei per dar la vita a figliuoli bastardi — io per toglierla a’ miei persecutori!
Un solo cruccio ho risentito per l’abbiezione di Maria Francesca: — la mia figliuola meritava una madre migliore!
Oh quante volte, quando mi sedevo la bambina sulle ginocchia, io le diceva, senza che mi comprendesse:
— Povera creatura! tu sei alta poco più del mio coltello omicida; nessuno ti conosce, nessuno [172] ti cura, nessuno sa quanto vali! Eppure dovrebbero adorarti in ginocchio come una Madonnina! Eppure molti contadini e signori di Florinas dovrebbero caderti ai piedi, per ringraziarti delle vite che hai risparmiato al nostro paese! Molto sangue avrei sparso ancora, se io non ti avessi incontrato sul mio cammino! Non ti manca che una sola virtù, figliuola mia: — quella di non aver saputo spegnere nel mio cuore l’odio verso il prete Pittui — verso l’uomo fatale, che a me tolse la pace... e a te la madre!
[173]
La mia figliuola aveva continuato per lungo tempo a frequentare la scuola di Portotorres, cattivandosi la benevolenza della maestra e delle sue compagne. L’allontanamento dal paese della strega, che batteva le scolare, aveva in lei ridestato l’amore allo studio ed ai lavori di cucito.
Appena raggiunta l’età di 16 anni, Maria Antonia dichiarò di non voler più sapere di lezioni. Si sapeva grandicella, e voleva ritirarsi in casa.
Non aveva torto. Per la povera gente l’istruzione deve avere un limite. Lo studio è buono per i soli signori, e noi abbiamo bisogno del lavoro per tirare innanzi la vita.
Uscita per sempre dalla scuola, Maria Antonia andò a convivere con mia sorella Andriana, maritata a Ignazio Piana.
La mia figliuola era una ragazza assennata, piena di spirito, e si era data volontariamente al lavoro, per accudire alle faccende domestiche. [174] Le due mie sorelle le tenevano buona compagnia e l’educavano bene, poichè nostro padre ci aveva tutti allevati rigidamente, all’antica, senza grilli per la testa, e senza quelle sciocche tenerezze, assai spesso nocive alle tenere piante.
La famiglia d’Ignazio Piana si componeva di marito e moglie, di tre figli e di una nipote, che si era voluto addossare. Ignazio aveva casa propria a Portotorres, che abitava durante il tempo della manipolazione dei formaggi; negli altri mesi si ritirava colla famiglia negli ovili della Nurra di Portotorres — cioè a Monte erva (lontano un due ore dal paese), o alle tanche di S. Lucia e di Campo cervo, distante un’oretta.
Come la mia figliuola entrò in casa d’Ignazio ad accrescere il numero dei componenti la famiglia, si era data a cucire, a far pane, ed anche a lavare; poichè da noi si fa di tutto, ed il saper leggere e scrivere non doveva darle diritto a starsene colle mani in mano.
Andavo ogni tanto a trovar Maria Antonia, oppure le scrivevo, se avevo bisogno di dirle qualche cosa.
Oltre all’ingrato mestiere di bandito, da una diecina d’anni mi ero assunta l’incarico di far da mamma alla mia creatura; epperciò lavoravo con più ardore, dovendo pensare al suo avvenire. Seminavo grano proprio, possedevo una mezza dozzina di buoi, ed anche qualche gregge; il tutto affidato alla custodia ed alle cure de’ miei [175] cognati; poichè la mia vita di girovago, di fuggiasco, e di perseguitato, non poteva permettermi di aver campi, pecore e mandrie di mia proprietà. Col lavoro assiduo e coi risparmi avevo accumulato il poco che possedevo; ed ero orgoglioso di vantarmene, colla coscienza di non potermi rimproverare il minimo furto. Dovevo tutto a me stesso, e niente agli altri!
Sentendomi più tranquillo dopo il ritiro di mia figlia dalla scuola, continuai a gironzare di qua e di là, considerando ch’era imprudenza fermarmi a lungo in un punto fisso.
In quel tempo si era a me unito Giovanni Maria Ibba — che fu l’ultimo bandito ch’ebbi a compagno di ventura. Come ho fatto per gli altri, dirò poche parole sulla vita di costui.
***
Giomaria Ibba era un mugnaio; il quale un bel giorno, per presunti danni cagionati al suo orto, aveva preso a bisticciarsi con Luigi Marceddu — l’uccisore a tradimento di Pietro Cambilargiu.
Persistendo Marceddu a darsi ragione colle minacele, il mugnaio gli disse:
— Senti: è meglio finirla qui, perchè saresti capace di darmi una fucilata alle spalle, come hai fatto col bandito osilese.
E impegnata una lotta corpo a corpo con lui, Ibba riuscì ad atterrarlo, e a spaccargli il [176] cranio con una grossa pietra. Sotterrato quindi il cadavere nell’orto, vi piantò i pomidoro, che inaffiò accuratamente.
Scoperto il cadavere, Giomaria Ibba si salvò colla fuga, e fece il bandito. Accortosi poco dopo che un altro mugnaio cercava di fargli la spia, riparò nella Nurra, e venne a trovarmi, pregandomi di prestargli mano per uccidere il collega delatore.
— Io non ho più nemici, nè voglio più averne! — risposi — Ti avverto solo di non avvicinarti a Sassari, perchè colà la giustizia ha cent’occhi!
— Che importa? So bene che finiranno per uccidermi; ma è meglio che io mi vendichi!
Così egli mi rispose, e continuò a rimanere con me nella Nurra, finchè si decise a far ritorno a Sassari. Quivi riuscì ad uccidere, prima il mugnaio spia, e poco dopo il maresciallo Piras sullo stradone di Sorso.
Affidatosi in Sassari ad un amico suo, comprato dalla Polizia, questo denunziò il rifugio del bandito. Assalito dai carabinieri, Giomaria Ibba cadde colpito dalle loro palle[26].
Ed ora riprendo il filo della mia storia.
[177]
***
In compagnia del bandito Ibba, passai un giorno dinanzi all’ovile d’Ignazio Piana, il marito di mia sorella Andriana.
Come mio cognato mi vide; esclamò:
— Guarda combinazione! Poc’ora fa erano qui a cercarti due amici di Banari.
— Chi erano dessi?
— I fratelli Antonio Maria e Salvatore Pes.
— Che volevano?
— Volevano incaricarti della ricerca di tre paia di buoi, che furono loro rubati. I buoi, però, sono qui nella Nurra!
— E chi può saperlo?
— Lo so io, che li ho veduti, e lo sa Giovanni Lepuzza, che si trovava con me[27].
[178]
— E come li avete veduti?
— I ladri hanno aperto una breccia nel muro di Lècheri, hanno passato i buoi in Badde arcu, portandoli alla tanca di Pedra carpida, dopo aver loro legato le zampe anteriori (trobidos).
— Chi accompagnava i buoi?
— Il ploaghese Tiringone, domiciliato a Portotorres, e altri due che non abbiamo potuto ravvisare per l’ora tarda.
— E i due fratelli Pes donde venivano?
— Da Portotorres, dove si erano recati per raccomandarsi a Giovanni Lepuzza.
— E perchè si rivolsero a costui?
— Perchè a un suo fratello, carabiniere, era un giorno scappato il cavallo, che fu rintracciato dai Pes. Grato del servizio resogli, il carabiniere li esortò a comandarlo, ove avessero avuto bisogno di lui.
— Che rispose Lepuzza ai fratelli Pes?
— Lasciò scapparsi sbadatamente: — Perdio! gli stessi buoi! — Recatosi quindi da Tiringone aveva detto:
«— Ho in casa due amici banaresi in cerca dei buoi, che l’altra sera avete portato alla tanca di Pedra carpida.
«— E che? hai forse tu detto dov’erano?
«— No... non ho detto niente!
«— Ebbene, ascolta: tu avrai la parte dei buoi da noi presi, se ci metteremo d’accordo per dire ai banaresi che i buoi non ci sono. Condurremo [179] i due amici altrove, per far loro perdere le traccie.
«L’indomani, infatti, Lepuzza e Tiringone condussero i fratelli Pes a cercare i buoi... dove non c’erano. Fattasi tarda l’ora, dissero ai banaresi: — Potete tornarvene al paese. Faremo noi la ricerca dei buoi.
«I Pes presero commiato, dicendo: — Noi siamo amici di Giovanni Tolu. Fategli i nostri saluti!
«Prima di partirsene (conchiuse mio cognato Piana) i fratelli Pes vennero in cerca di me per narrarmi il caso; ed io sorrisi dicendo loro: — Andate pure, chè quando troveremo i buoi sarete avvisati.»
Come mio cognato terminò il racconto, si andò tutti a cena, compreso Ibba, e si continuò a parlare dell’incidente.
— Dunque i buoi furono veduti da te e da Giovanni Lepuzza?
— Altro che! — rispose.
— E perchè Lepuzza non condusse addirittura i fratelli Pes alla tanca dov’erano i buoi?
— Glie lo dissi, ma mi rispose: — sai bene ch’io sono molto povero, e mi fa comodo la porzione che mi verrà data, quando si riuscirà a vendere i buoi.» — Lo rimproverai della sua poca lealtà, ma si limitò a confessarmi, che la promessa di un compenso lo aveva acciecato.
[180]
Appena finito di cenare, mi recai con Ibba a Campanedda, e chiesto al servo ove fosse Francesco Silvanu, rispose ch’era a letto.
— Digli che si alzi subito, perchè Giovanni Tolu ha bisogno di parlargli.
Quegli si vestì e venne ad aprirci. Io gli dissi a bruciapelo:
— Senti, Francesco: i buoi che tu hai nella tanca appartengono a Banari; si hanno le traccia, e non si cesserà dal cercarli, finchè si troveranno. Sono proprietà di gente ricca, che ha molti amici!
— Non so nulla di quanto mi dici! — mi rispose Silvanu.
— Non mentire: tu lo sai! Bada che compare Maurizio, il capo dei ladri di bestiame, ha già deciso di restituire i buoi al padrone, per evitare lo scoprimento dei rei!
Silvanu rimase come di sasso, non immaginando certo che le parole di compare Maurizio fossero un’invenzione mia. Pensò alquanto e rispose:
— Dimmi che cosa devo fare!
— Farai come ti dico. Per evitare pericolose testimonianze, condurrai di notte tempo i buoi nella tanca di mio cognato Piana, legati come si trovano. Non si saprà così, da nessuno, chi ve li abbia messi.
L’indomani notte, infatti, fu trasportato il bestiame, come avevo suggerito.
Quando all’alba mio cognato vide i buoi nella [181] sua tanca, ne diè subito avviso ai banaresi, perchè se li ritirassero.
I fratelli Pes, in precedenza, avevano fatto la denunzia del bestiame mancante al pretore ed ai sindaci dei paesi vicini.
Divulgatasi la notizia del fatto, il pretore di Portotorres mandò a chiamare Ignazio Piana per chiedere schiarimenti.
— Chi ha messo i buoi nella tua tanca?
— Lo ignoro. Giorni prima avevo informato mio cognato Giovanni Tolu della mancanza dei buoi, ma non so se li abbia portati lui od altri alla tanca. Io feci il mio dovere avvisando i padroni.
Il pretore volle interrogare anche mia sorella Andriana e la mia figliuola, che in quel tempo si trovava all’ovile. Quest’ultima rispose, con molto spirito, che le donne s’intendono di tela e di lino, non di buoi nè di pecore.
Io fui ben lieto di aver adempiuto al mio dovere, facendo restituire la roba d’altri, senza denunziare i ladri.
[182]
Compare Maurizio, Giovanni Lepuzza, Baingio Matagnu, i fratelli Tiringone, e molti altri componenti la compagnia dei ladri di buoi, furono risentiti contro di me, per la preda loro sfuggita. I buoi rappresentavano un valore di circa 400 scudi; e i ladri, per mia colpa, si videro costretti a rinunziare ad un lauto dividendo. Fatta congiura, stabilirono di vendicarsi.
Uno dei fratelli Tiringone (mezzo scemo) amoreggiava con una ragazza di Florinas; alla quale raccontava, per vanagloria, tutte le prodezze della compagnia dei ladri, di cui egli faceva parte. La ragazza, con ingenuità, diceva tutto al padrastro Salvatore Bazzone, il quale era fratello di un mio cognato, amicissimo mio. Questi mi avvertiva per mettermi in guardia — e così mi era noto ogni tranello ed ogni chiacchiera a mio riguardo. Gli amori della donna mi hanno sempre reso dei grandi servigi.
Un giorno Tiringone lasciò sfuggirsi:
— Giovanni Tolu si accorgerà ben presto [183] dell’errore fatto, costringendoci a restituire i buoi ai banaresi!
Questa minaccia, ed altre di simil genere, pervenivano ogni tanto al mio orecchio, e si rinnovarono con frequenza per lo spazio di un anno.
Io rideva, perchè di questa gente non avevo paura. Guai a loro se avessero osato molestarmi!
Una notte Giovanni Lepuzza, membro della famosa compagnia organizzata nella Nurra, aveva tentato di far uscire dalla tanca di mio cognato Piana una ventina di buoi, fra i quali ve n’erano miei, di Giovanni Puzzone, e di altri che pagavano il pascolo al proprietario delle terre. Sebbene i cani non avessero abbaiato (perchè conoscevano Lepuzza, un tempo consocio di Pinna) i buoi quella notte non si poterono portar via, per la troppa loro grossezza.
Trascorso un mese, Lepuzza ritentò il colpo, e questa volta gli riuscì di portar via una ventina di buoi, che condusse fino a Montixiu Àinu, dove era riunita la combricola dei ladri compagni.
Le bestie furono messe dentro una tanca chiusa, lontana una mezz’ora dall’ovile di mio cognato. Temendo che la detonazione dei fucili non li tradisse, i ladri pensarono di uccidere col ferro, anzichè col piombo, i buoi designati. Gettato il laccio a quattro bestie, che lor piacque scegliere, le scannarono.
[184]
Tre di questi buoi erano i miei — il quarto di Giovanni Puzzone. È certo, però, che il bue di quest’ultimo fu creduto pur mio, poichè ne avevo uno simile nella tanca di mio cognato.
Ignazio Piana e il Puzzone, accortisi verso l’alba della mancanza dei buoi, si diedero attorno per rintracciarli. Essi rinvennero qua e là, vaganti, tutti i vivi, ma invano cercarono gli altri quattro.
Arrivato la sera da Portotorres, Giovanni Lepuzza si presentò all’ovile di mio cognato Piana, il quale lo informò dei quattro buoi mancanti.
— Andiamo a cercarli! — disse con affettata premura; e si mossero.
Lepuzza, con sorpresa di Piana, si diresse verso Montixiu Àinu, dove trovarono i quattro buoi scannati, e già scorticati. I ladri avevano portato seco i cuoi, che depositarono più tardi nell’ovile di un loro amico, e parente.
***
Due giorni dopo — ignaro di quanto era accaduto — capitai con un compagno nell’ovile di mio cognato (ch’era assente) e dissi a mia sorella Andriana:
— Dacci pane e vino, se ce ne hai. Abbiamo bisogno di mangiare un boccone, per continuare la nostra strada.
Mia sorella, molto seria, accentuando le parole, mi rispose con doppio senso:
[185]
— Oggi non ti mancherà carne, Giovanni! Ne abbiamo cotta, ed anche cruda!
— Che vuoi dire? Spiegati!
— Voglio dire, che ti hanno ucciso quattro buoi!
Il sangue mi montò alla testa; ed ascoltai muto, come intontito, la storia dell’uccisione, che Andriana mi andava esponendo.
Mio primo pensiero fu quello di correr subito in cerca di Lepuzza per dargli una fucilata. Si trattava del mio peculio assottigliato, del mio risparmio guadagnato col sudore della fronte. Venne in seguito la riflessione, e considerai che la morte di Lepuzza non avrebbe potuto indennizzarmi del bestiame perduto.
Sedetti a tavola, sorrisi sinistramente, e dissi rivolto a mia sorella con finta gaiezza:
— Andriana; portaci pane e vino, e non pensiamo ad altro. Quei furfanti l’hanno sbagliata. Dovevano prima uccider me... poi le mie bestie!
Appena terminato il pasto, dissi alla mia figliuola, ch’era venuta a carezzarmi:
— Maria Antonia; recati subito a Portotorres, e va in cerca del canonico. Portagli dieci scudi; e digli a mio nome, che celebri una messa alle Anime del Purgatorio, col cavallo dei morti in mezzo alla chiesa.[28]
[186]
Tornato all’ovile dopo due giorni, Maria Antonia venne a riferirmi, che il prete Giomaria Sanna (a cui si era rivolta) aveva ricusato il danaro, dicendo che non poteva prestarsi a lanciar scomuniche in nome di un bandito.
Rimandai la figliuola al curato della basilica, pregandolo che dicesse una messa di due scudi a Sant’Antonio del fuoco. Questa volta venni esaudito.
Non devo tacere, che il prete Sanna ha mancato al suo dovere. Io so, per essere stato sagrestano, che un devoto (purchè paghi!) ha diritto a qualunque funzione in chiesa.
Recatomi l’indomani nell’ovile di un pastore (parente dei ladri) mi si domandò se era vero che mi avessero ucciso tre buoi.
— È verissimo! — risposi — ma vi assicuro che sarò indennizzato, anche se ai ladri si screpolasse la pianta dei piedi![29]
Il pastore ammutolì inorridito.
***
Era intanto venuta la bella stagione, in cui diversi avvocati di Sassari solevano recarsi alla Nurra, per passare un mesetto in divertimento.
Gli avvocati — esterno una mia opinione — sono [187] gente che hanno l’abilità di barcamenarsi fra amici e nemici, per trarne all’occasione qualche cliente.
Come seppi dell’arrivo dei villeggianti, mi presentai ad uno degli avvocati, ch’era informato del caso accadutomi, perchè contava molti amici nella Nurra.
— Ma perchè te li hanno uccisi, questi buoi? — mi domandò egli.
— Perchè ho fatto restituire ai banaresi quelli rubati dalla combricola dei ladri, capitanati da compare Maurizio!
— E sei proprio sicuro di quanto dici?
— Ne domandi agli amici della Nurra, e sentirà la risposta. I ladri avrebbero dovuto ringraziarmi, perchè non li ho compromessi colla giustizia. Mi hanno invece pagato col più nero dispetto!
— Non dubitare; parlerò io con compare Maurizio. Lo conosco per un buon uomo, e mi dispiace che egli abbia male, perchè è un mio compare di battesimo. Non appena avrò conferito con lui, ti avviserò con un biglietto, che tu brucierai.
Quando presi commiato, egli mi regalò tre scudi per farmi un paio di pantaloni.
Dopo qualche tempo ricevetti una sua lettera, nella quale mi diceva di aver imposto a compare Maurizio di riunire i suoi amici per aggiustare l’affare dei buoi, il cui prezzo mi verrebbe pagato in rate, o nel modo più conveniente.
[188]
Trovandomi un giorno nell’ovile di mio cognato Piana (in Campu Cervu) capitarono là, provenienti da Portotorres, compare Maurizio, Giovanni Lepuzza, i tre fratelli Tiringone, ed altri compagni della famosa comitiva.
Li vidi da lontano e mi nascosi nelle vicinanze, senza che mi vedessero.
Chiesto di me, mio cognato rispose:
— Giovanni non si è veduto in questi giorni; ma se avete qualche cosa a dirgli, parlate pure, chè io troverò mezzo di riferirglielo.
Allora compare Maurizio e i Tiringone, con un’audacia senza pari, si scagliarono addirittura contro Giovanni Lepuzza, accusandolo dell’uccisione dei buoi — forse coll’intento di mettere lui solo in causa, ed a tiro del mio fucile. Lepuzza tentò difendersi; ma i compagni alzarono tanto la voce, che quegli fu costretto ad ammutolire.
La combricola si fermò nell’ovile tutta la giornata, sollevando questioni sul fatto de’ buoi, ma senza nulla conchiudere.
Quando mio cognato mi riferì quanto si era discusso, gli feci notare che si trattava di uno strattagemma. Essendo Lepuzza un intruso nella società dei ladri, poco ad essi importava se lo avessero ucciso, o chiamato in causa.
Volendo metterli alla prova, dissi a mio cognato:
— Fammi il piacere di recarti a Portotorres. Dirai a compare Maurizio ed ai suoi compagni, [189] che sabato li aspetto qui. Quando verranno, tu li tratterrai nell’ovile per un’oretta; in seguito li condurrai alla Tribuna.
Disposi nel frattempo, che nel giorno indicato si recassero alla Tribuna alcuni miei parenti ed amici, tutti armati.
In quei giorni mio fratello Giomaria si trovava all’ovile, perchè consocio di mio cognato nell’agricoltura.
Il sabato, fedeli all’appuntamento, i capi-ladri si presentarono all’ovile; e di là, dopo un’ora, furono condotti da Piana alla Tribuna, dove già si trovavano i miei, cioè: Giomaria, l’altro mio cognato Martino Fiori, ed i fratelli Giovanni e Ignazio Puzzone.
Compare Maurizio era venuto coi tre fratelli Tiringone, cioè Ciccio, Antonio Giovanni e Billia. Mancava Lepuzza, perchè si era rifiutato a tener loro compagnia.
Io intanto mi ero fermato nell’ovile di Antonio Maria Sassu, volendo presentarmi alla comitiva quando tutti erano a posto. Pregai l’amico pastore che lasciasse venir meco il suo figliuolo quindicenne, al quale fu dato un fucile, che io caricai a palla.
Mossi finalmente verso la Tribuna, raccomandando al giovinotto di starmi sempre vicino, perchè all’occasione potessi servirmi dell’arma sua. Fu sempre mio sistema di premunirmi contro qualunque possibile evento.
[190]
Come giunsi al sito designato, vidi i componenti la comitiva sdraiati qua e là sull’erba.
Mi avvicinai sorridente; e alludendo ad una caccia finita dissi loro:
— Non avete abbrustolito i cinghiali?
— Non ancora! — rispose mio fratello. Gli altri tacquero.
Diedi un’occhiata in giro:
— Ma qui non vedo Giovanni Lepuzza!
— Non è voluto venire.
— Bisognava condurlo!
— Dovevamo forse trascinarlo per i piedi?
— Sicuro: anche a viva forza, dandogli parola che nessuno lo avrebbe qui offeso. Temevate forse che io lo uccidessi? Colui che voglio uccidere non ha bisogno di disturbarsi per venirmi a trovare: — so andare io da lui; e se lo cerco lo trovo!
Nessuno rispose. Compare Maurizio disse:
— Noi siamo qui, pronti a fare quello che vuoi!
Mi rivolsi a lui:
— Ma io non sono un bambino da menar per il naso. Tu sei il capo dei ladri! e come capo devi radunare i tuoi amici perchè mi venga rimborsato il prezzo dei tre buoi che mi avete ucciso. Chiacchiere non ne voglio da nessuno. Ne ho già udito abbastanza!
E così dicendo, voltai loro le spalle, e me ne andai.
[191]
— Ma quest’uomo è sulle furie e non vuole ragionare! — aveva esclamato compare Maurizio, rivolto a Giomaria. — Che venga qui, e ce l’intenderemo con calma!
Mio fratello montò a cavallo e mi raggiunse, per riferirmi le parole del capo ladro.
— Rispondi loro, che io voglio soldi e non ciancie!
E continuai la mia strada.
[192]
Il caso dell’uccisione dei buoi divenne popolare nella Nurra, e la giustizia se n’era immischiata.
Trascorse due settimane, venni chiamato a Sassari in salvacondotto, e mi presentai al giudice Pirari.
Invitato da lui a dar ragguagli, ed a deporre in causa contro gli uccisori de’ miei buoi, risposi:
— Se il Governo è disposto a risarcirmi del danno, svelerò il nome dei ladri... e dirò altro ancora!
— Il Governo ha il dovere di far giustizia, ma non può rimborsare danno alcuno.
— Ed io non dirò una parola!
— Ecco il vostro contegno! — fece il giudice Pirari con aria di malcontento — Prima vi dolete del danno sofferto, e poi vi rifiutate a denunziare i rei. Che volete che faccia la giustizia?
— Ma ella dunque ignora, che non ho altre entrate per vivere? Io conto sul mio lavoro, nè voglio andare a rubare. Se il Governo rifiuta [193] di pagarmi, troverò io il mezzo di farmi pagare dai ladri.
— I ladri non ti pagheranno, poichè sono in molti... e tu sei solo.
— Ella è in errore. Appunto perchè in molti mi riuscirà facile ucciderne qualcuno; mentre sarà loro difficile venirmi a trovare. Creda pure, d’altra parte, che se mi cercano mi trovano!
— Ripeto che da nessuno verrai pagato: nè dai ladri, nè dal Governo.
— I ladri mi pagheranno; e se non mi pagassero, è segno che morrò presto.
— Pensaci bene!
— Ci ho pensato. Faccia una cosa: ne tenga parola col prefetto, col procuratore del re, con chi vuole: mi si paghino i buoi, e in seguito si vedrà se sarò capace di mettere la giustizia sulle traccia dei malandrini!
— È una cosa impossibile!
— Se il Governo mi paga i buoi, le prometto di unirmi ai carabinieri per arrestare i ladri.
Il giudice mandò allora a chiamare il capitano Castelli, essendo assente da Sassari il maggiore.
Il capitano mi disse con compunzione fratesca:
— Bisogna essere amico dei carabinieri!
— Sicuro; ma prima il Governo rimborsi il danneggiato. Si mettano d’accordo col prefetto, ed io farò quello che vogliono.
[194]
— È inutile conferire col prefetto, perchè egli non è autorizzato a pagar buoi.
— Allora è finita. Io mi farò pagare dai ladri, e lei non strapperà una parola dalla mia bocca. Ho un salvacondotto, e posso andarmene quando voglio!
Il mio interrogatorio era terminato, ed io mi separai dal giudice Pirari e dal capitano Castelli.
***
Ero ospite dell’amico e compaesano Antonio Giuseppe Zara, la cui abitazione era sul Corso, nella casa del Cav. Chiappe (oggi di Michele Canessa). Nello stesso piano, in un quartiere separato, abitava pure il procuratore del re Cavalier Dore; il quale, quasi ogni giorno, mi faceva chiamare dalla sua cameriera, e si tratteneva un’oretta a discorrere con me — spinto un po’ dalla curiosità, e un po’ dalle esigenze della carica che copriva.
Un giorno, mentre mi disponevo ad entrare in casa del Cav. Dore, m’imbattei sul pianerottolo in uno degli avvocati da me veduti nella Nurra. Veniva a cercarmi.
— Ritorni più tardi — gli dissi — perchè or ora venni chiamato dal procuratore del re.
Non potei celare al Cav. Dore la visita dell’avvocato, venuto forse per conchiudere l’affare dei buoi.
[195]
— Bada bene — mi disse il fisco — se tu ti farai pagare i buoi, non avrò più bisogno di testimoni per far arrestare i ladri. Mi saranno noti.
— Se io li denunziassi, però!
Tornò sul tardi da me l’avvocato, in compagnia di altri tre colleghi. La camera dov’io stava era attigua ad una delle sale del procuratore del re, il quale aveva udito gran parte del nostro dialogo.
— Ebbene, che cosa hai fatto? — mi domandò l’avvocato.
— Ancora nulla.
— Non fosti chiamato dal giudice per la causa dei buoi?
— Sì; ma io non sono l’uomo da vuotare il sacco in una volta. Ho tacciuto, perchè il Governo si ostina a non volermi pagare i buoi.
— Sentiamo il prezzo che ne chiedi.
— Per i tre buoi che mi hanno ucciso, io chiedo 150 scudi.
— È troppo!
— Lo so; ma siccome i ladri si hanno preso il gusto di scannarli per farmi dispetto, così anch’io voglio gustare il piacere di farmeli pagare come voglio!
— Il tuo non è che un dispetto.
— Non lo nego; e vi dico pure, che se mancherà un centesimo alla somma, la rifiuto... e saprò che cosa fare!
— I buoi uccisi non erano quattro?
[196]
— Sì: ma i miei sono tre. Non mi occupo di quello appartenente a Giovanni Puzzone, perchè questi non mi è fratello, non mi è nipote, non mi è genero. Io penso ai miei buoi — pensi lui ai suoi!
I quattro avvocati dichiararono, che fra una quindicina di giorni mi avrebbero pagato i buoi per incarico del loro cliente ed amico.
Nel giorno indicato, mio fratello Giomaria venne a Sassari, e ritirò i 150 scudi.
Mi abboccai pochi giorni dopo coll’avvocato principale, che mi disse:
— Che sia una cosa finita, veh?
— Per me è finita. Ma badino i ladri a lasciarmi tranquillo e a non farmi la spia. Li avverta anche lei, se li vede!
— Come avvocato, sono lieto di aggiustare le cose, perchè non nascano guai.
— Le dirò francamente, che mi sarebbe riuscito facile uccidere compare Maurizio; ma sarebbe stato troppo onore per lui venir freddato da Giovanni Tolu. Non l’ucciderò mai, poichè le partite sono ormai saldate. Che si guardi, però! poichè gli pronostico, che verrà ucciso da un altro miserabile suo pari!
E qui terminò quel brutto affare dei buoi, che per circa due anni mi tenne irrequieto e mi fece montare su tutte le furie[30].
[197]
***
Invece di lasciarmi tranquillo, compare Maurizio faceva il gradasso negli ovili, e cercava di nuocermi per vendicarsi.
Un giorno si recò dal pastore Salvatore Antonio Marras, e gli consegnò due palle (una di argento ed una di piombo) dicendogli:
— Se con queste colpirai Giovanni Tolu, egli morirà inesorabilmente, anche se avesse addosso qualunque talismano. Oltre al compenso di cento scudi, mi adoprerò per farti ottenere il porto d’armi, col consenso del maresciallo dei carabinieri di Portotorres.
Il pastore Marras (che mi era amico) non esitò ad accettare le due palle; ma venne segretamente a mostrarmele, riferendomi le parole di compare Maurizio.
— E perchè, matto che sei, non hai ritirato anche i cento scudi? — dissi al pastore fra il serio e il burlesco. — Non vorrei che tu andassi a ritirarli un’altra volta!
L’amico — che mi era fedelissimo — mi rispose seriamente:
— Non scherzare, o Giovanni; ma mettiti in guardia! Quel malintenzionato potrebbe trovare altro pastore, di me meno scrupoloso.
— Sta tranquillo: la palla di compare Maurizio, fosse anche d’oro, non sarà quella che ucciderà [198] Giovanni Tolu. Non è buono che ad uccidere buoi, colui!
Aizzando or l’uno, or l’altro, compare Maurizio continuava nell’idea di sbarazzarsi di me. Non poteva darsi pace dell’affare dei buoi, per lui così disastroso. Tuttavia, in apparenza, mi si mostrava amico, e parecchie volte mandò a dirmi, che mi guardassi dai carabinieri, ch’erano usciti da Portotorres in perlustrazione. Io, certamente, non me ne fidavo, perchè mi erano noti questi strattagemmi da fiduciario. Assai spesso questa gente ha la furberia di avvisare allo stesso tempo carabinieri e banditi, per tenersi in buon accordo cogli uni e cogli altri. Era un gran filone quel compare Maurizio!
Dal mio canto non cercai di fargli male, per due ragioni: la prima, per la promessa fatta agli amici avvocati di Sassari; la seconda, perchè ero saldo nel proponimento di non spargere più sangue. Il pensiero dell’avvenire della mia figliuola — come ho già detto — frenava il mio braccio. Se l’uccisione de’ miei buoi fosse avvenuta quindici anni addietro, Dio sa la strage che avrei fatto dei ladri!
***
Ma anche per compare Maurizio doveva avverarsi la mia profezia. Egli si era associato negli affari con un pastore osilese. Costui, oltre [199] al bestiame sociale, possedeva una greggia propria di una cinquantina di pecore. Venuta essa meno per le rilevanti spese di pascolo, il pastore cercò di rifarsi, rubando al consocio molte pecore, che vendette ad un amico d’Osilo. Accortosi Maurizio della mancanza, andò alla ricerca, e trovò le sue pecore presso il pastore Ligios; il quale minacciò subito di mandare in galera chi glie le aveva vendute. Per evitare fastidi, i due pastori finirono per mettersi d’accordo, e tolsero di mezzo compare Maurizio con una fucilata.
E così morì di piombo colui, che sperava di uccidermi con una palla d’argento!
***
Non tardarono parecchi altri scannatori dei miei buoi a raggiungere nell’altro mondo il loro capo supremo.
Baingio Matagnu — il quale, dopo essersi un giorno bisticciato con me, aveva osato nell’ovile di Boturru vantarsi con Domenico Tignosu di avermene dette delle crude — colto dalle febbri si era messo a letto[31].
[200]
Trovatomi un giorno con certo Lorenzo Murineddu, che aveva tenuto a battesimo un figlio di Matagnu, gli chiesi:
— Non sei stato a visitare il tuo compare ammalato?
— Non ancora.
— Hai fatto male! Vacci pure, e digli da parte mia, che si confessi, poichè la confessione gli farà bene.
Questa ambasciata — che è sempre augurio di morte — impressionò talmente Baingio Matagnu, che ne morì poche settimane dopo.
Non passò gran tempo che anche Ciccio Tiringone ebbe la sua paga. Egli fu ucciso sul proprio carro da un nemico, che venne arrestato. Anche lui, come Matagnu, avrà dato conto a Dio, [201] fra gli altri delitti, dei buoi sgozzati a Montixiu Àinu.
Erano precisamente costoro i due che avevano impugnato il coltello per scannare i miei buoi; gli altri compagni li avevano tolti dalla tanca, presi col laccio, o tenuti fermi durante lo sgozzamento.
La scomunica, da me lanciata contro di loro colla messa a Sant’Antonio del fuoco, aveva ottenuto il suo effetto.
[202]
Ciccio Tiringone era un tristo soggetto. Lo conobbi la prima volta ad Abba meiga, per un favore fattogli, di cui non mi fu riconoscente. Narro il caso.
Il fattore dello Stabilimento della Crucca, certo Pinotto, rinvenuta una cavalla di Tiringone nelle tanche, l’aveva sequestrata per metterla in contravvenzione. Accortosene Tiringone, inseguì Pinotto, e lo raggiunse vicino al fiume. Ivi si accapigliarono, e ne avvenne una lotta corpo a corpo, durante la quale la cavalla si era data alla fuga. Un compagno di Tiringone, ivi accorso, suggeriva di uccidere Pinotto.
Venuto quest’ultimo da me per prendere consiglio, m’incaricai di aggiustare le cose. Andato in cerca di Tiringone, lo trovai piangente, dicendosi rovinato.
— Sta tranquillo — gli dissi — chè aggiusterò io le cose!
— Consigliami tu.
[203]
— Corri subito alla Crucca, e domanda scusa al Cav. Maffei. Questi è un signore generoso, e non vorrà rovinarti.
E così fece. Il Cav. Maffei rispose a Tiringone che l’offeso era Pinotto, e che se questi perdonava, egli avrebbe chiuso un occhio.
Pinotto si dichiarò soddisfatto, e l’incidente fu esaurito.
Questo fatto io deposi alle Assise di Sassari, quando vi fui chiamato in salvacondotto, come teste di difesa di certa Satta Tiringone, accusata di aver pagato un sicario per uccidere il proprio cognato.
Chiamato un’altra volta alle Assise, fui più esplicito nella mia deposizione. Chiestomi dal presidente che cosa pensassi di Ciccio Tiringone, risposi:
— Dico, ch’è un ladro ed un sicario; e sono pronto a provarlo qui stesso, con testimoni presenti a quest’udienza.
Il capo giurato (che per caso era stato il difensore di Tiringone in un precedente dibattimento) fece osservare al presidente, che il teste non diceva il vero, poichè il suo cliente, per le risultanze del processo, era stato dichiarato innocente dell’assassinio di Lorenzo Longiave.
Allora io, rivolto al capo giurato, dissi solennemente.
— Ella, come avvocato, avrà fatto il suo dovere secondo le risultanze della causa; però [204] devo dirle, che, senza volerlo, non ha fatto un’opera buona! Ha saputo strappare il cliente alla giustizia, non però a’ suoi nemici. Che Ciccio Tiringone sia stato l’assassino di Longiave è fuor di dubbio; ne sono convinti gli stessi parenti dell’ucciso, come ne erano convinti i fratelli Pintus d’Osilo. Eppure la giustizia di Sassari condannò alla galera in vita Antonio Pintus, ch’io dichiaro innocente della morte di Lorenzo Longiave.
Non so qual peso abbiano avuto le mie parole sulla bilancia della giustizia; ma so, che, poco tempo dopo, venne rimesso in libertà l’osilese Antonio Pintus, il quale aveva già scontato tre anni di galera. E dopo questi casi edificanti, mi si esortava a fidare nei tribunali!
Fu Ciccio Tiringone il vero autore dell’assassinio di Lorenzo Longiave, il facoltoso cittadino, ucciso nella propria casetta di campagna. Mentre sull’imbrunire cenava, vennero smosse alcune tegole del tetto, e lo si era freddato con una fucilata.
Da qualche tempo Tiringone introduceva abusivamente il proprio bestiame nelle tanche di Longiave, e costui lo aveva rimproverato. Sapendo Tiringone che il danneggiato proprietario era in urto coi fratelli Rocca di Sorso, aveva pensato di vendicarsi, guadagnandosi le grazie di costoro. La voce pubblica, intanto, fatta circolare ad arte, diceva che Antonio Pintus, pastore di Longiave, si era proposto di uccidere il padrone. [205] Due testimoni falsi lo avevano giurato... e la giustizia umana non volle altro per condannare un innocente!
Il giorno stesso che fu consumato l’assassinio io mi trovavo in compagnia del bandito Antonio Rocca, nella Nurra di dentro, nell’ovile di Antonio Sechi Pelicanu. Come giunse la notizia dell’uccisione, egli mi disse:
— Lorenzo Longiave mi era nemico; tuttavia mi dispiace la sua morte, poichè si dirà che ne sono io l’autore.
***
Pur narrando i fatti con scrupolosa verità, quali mi risultano, dichiaro di non essere in grado di saperli indicare con ordine cronologico. Gli avvenimenti che narro accaddero pochi anni prima, o pochi anni dopo l’uccisione de’ miei buoi.
Esisteva verso quel tempo nella Nurra un’associazione di malintenzionati, i quali andavano in giro, dilettandosi dell’uccisione del bestiame altrui, o per portarselo via, o per lasciarlo sul luogo, ma sempre con scopo di malfare, più che di vendetta. All’oziosa compagnia si univa spesso anche qualche proprietario benestante, che prendeva gusto a queste escursioni avventurose.
Visitavo spesso l’ovile di uno di questi proprietari [206] vagabondi; il quale possedeva un eccellente cavallo, e si univa con piacere agli altri scapestrati, per aiutarli ad uccidere e a scorticare i buoi. Ne taccio il nome per riguardo personale; ma dirò ch’era padre di più figli ed aveva una moglie saggissima, la quale continuamente gli rinfacciava la mala vita che menava.
Un giorno costei, alla mia presenza, prese a dirgli:
— Ma perchè non stai in casa ad accudire al tuo patrimonio? Perchè non sorvegli con maggior cura gli uomini che lavorano le nostre terre? Senti tu il bisogno di unirti ai cattivi compagni? Tu hai buoi, tu hai vacche, tu hai pecore e capre, tu hai porci — e puoi ucciderne quanti vuoi, senza ricorrere al bestiame altrui.
Il marito, piccato, le rispose canzonandola:
— Eh, capisco! mi vorresti sempre cucito alle tue gonnelle... per carezzarti!
— C’è tempo per tutto, anche per le carezze! — gli rispose la moglie seria. E lui di rimando:
— Eppure, quando porto a casa la carne, tu la mangi!
— La mangio, e ne do anche ai cani, pari tuoi!
E così la durarono un bel pezzo, finchè mi interposi per metterli in pace.
Trovatomi un giorno in campagna col marito, gli dissi affettando indifferenza:
[207]
— Guardati! Ti prevengo che venne riconosciuto il tuo cavallo, montato da uno scorticatore di buoi. È una vergogna che ricade sulla tua onesta famiglia.
— Ti spiegherò la cosa. Ho prestato il mio cavallo a Pietro V*, che me lo ha chiesto per due giorni. Forse fu imprudente, e...
— Ed è così che ti pregiudichi e ti avvilisci! — soggiunsi, interrompendolo.
— Che vuoi? Pietro V* è molto povero, ed ha bisogno di raggranellare cento scudi per liberarsi da una causa...
— E in tre anni e più di esercizio, con centinaia di cuoi strappati alle bestie, la compagnia non è ancora riuscita a mettere insieme cento scudi?! Ma via! io credo meno scrupolo farla da una buona volta finita col rubare addirittura uno o due gioghi di buoi. Questa continua carneficina è vergognosa, e non piace a nessuno.
Innumerevoli furono i danni cagionati nella Nurra da questa combriccola maledetta. Ricorderò, fra gli altri, quello della mandria di quaranta maiali, sgozzati in una sera in Baddiniedda manna, terre comunali di Sassari. Essi furono ridotti in lardo e salsiccie, che i ladri vendettero allegramente.
Posso assicurare, che fra gli sgozzatori dei porci era pur compreso il proprietario benestante, a cui la moglie faceva le prediche morali.
[208]
***
Oltre a questa combriccola di sgozzatori di bestiame, la Nurra era infestata in quel tempo da un’infinità di oziosi; i quali, sdegnando il lavoro onesto e faticoso, si erano dati a fare i cacciatori di professione, pretendendo sostentare le numerose famiglie coi proventi del solo fucile. Se capitavano a tiro lepri o pernici, cinghiali o caprioli, essi tornavano a casa cogli animali selvatici; se la fortuna li avversava, rubavano qua e là qualche agnello, qualche pecora, o qualche maiale, e portavano alla famiglia animali domestici. La carne, però, non doveva mancar mai!
Per questi furti era generale la lagnanza dei proprietari nurresi; i quali ogni anno dovevano rassegnarsi a perdere una somma rilevante, che andava a profitto degli oziosi ladruncoli.
A me, che lavoravo continuamente, o coltivando terre, od allevando un po’ di bestiame col concorso de’ miei cognati, dava molto ai nervi questa rapina vergognosa. Vedevo con dispiacere tante braccia inerti, le quali avrebbero potuto rendere produttive un’infinità di terre abbandonate.
Un giorno Lorenzo Muzzu (forse il primo dei proprietari della Nurra) si lamentava meco del danno ch’ei subiva per il continuo furto del bestiame. Io gli dissi seriamente:
[209]
— Eppure, voi proprietari, siete in grado di scongiurare il flagello!
— Noi...?
— Sì. A voi rubano, in media, non meno di 500 lire di bestiame all’anno: non è così? Orbene: voi ricchi dovreste unirvi, e somministrare ai poveri il mezzo di lavorare.
— Sono pigri e non lavorano.
— Lavoreranno!
— E come?
— Prestate loro i buoi da lavoro.
— E questo basta?
— Voi ricchi unitevi: io m’incaricherò di far lavorare i poveri.
— Che dovrò fare?
— Ecco. Quando i poveretti verranno a chiederti in prestito i buoi, non scacciarli, ma prometti loro di contentarli.
— Lo farò, se si presenteranno da me.
— M’incaricherò io di farli venire. Siamo intesi?
— Te lo prometto.
Preso commiato da Lorenzo Muzzu, mi posi subito d’impegno per raggiungere lo scopo, sicuro di fare un’opera buona.
Cominciai poco per volta a fare il giro della Nurra. Come m’imbattevo in uno dei ladruncoli (li conoscevo tutti) lo fermavo e gli dicevo:
— Non vedi, che hai la Nurra tutt’addosso?
— Perchè?
[210]
— Perchè sei ritenuto come un ozioso, e dicono che tu campi col furto del bestiame. E non sei il solo! Attenti, chè un giorno non abbiate a far conti colla giustizia, rovinando voi e le vostre famiglie. Io so quello che mi dico.
L’individuo sbarrava tanto d’occhi alle mie parole misteriose, e diceva:
— Ma che dovrei fare?
— Lavorare. So che tu hai un pezzo di terra: coltivala.
— Io non vado a zappare.
— Ma la terra ce l’hai.
— Mi mancano i buoi.
— I buoi te li farò dare io; ma lavora.
— Chi me li dà?
— Va da Lorenzo Muzzu. Se te li negasse, digli che pagherò io l’affitto.
— Scherzi?
— Non scherzo.
Il ladruncolo si presentava al Muzzu per far la domanda; e questi gli rispondeva:
— I buoi te li darò; ma siccome non ne ho disponibili (poichè li ho tutti impiegati negli aratri e nei carri) ne comprerò degli altri. Se tu conosci chi ne vende, mandalo da me; ed io li acquisterò per prestarteli.
E in questo modo riuscì a contentare non pochi sfaccendati ladri, i quali cominciarono seriamente a lavorare. Potrei citare molti nomi.
I proprietari prestavano i buoi ai richiedenti [211] quando ne avevano bisogno, e se li ritiravano di tanto in tanto, per impiegarli nei propri lavori.
Venuta la raccolta, qualcuno chiedeva al Muzzu il prezzo dell’affitto, ed egli rispondeva:
— Non voglio nulla. Mandate a me tutti quelli che vendono buoi, ed io ne acquisterò anche venti paia.
L’esempio di Lorenzo Muzzu fu seguito ben presto da molti altri benestanti, fra i quali mi piace citare Francesco Piras, la vedova Lucia Zanfarino, Proto Salis e Antonio Masala — tutti da me consigliati e incoraggiati, colla promessa che sarebbero stati compensati dal minor numero dei furti di bestiame.
Dal mio canto continuavo a correre di qua e di là per far la predica ai ladri, i quali, un po’ per amore, e un po’ per forza, si adattavano a lavorare.
Col concorso dei generosi proprietari, ero riuscito a persuadere quella trista gente, che il lavoro onesto è assai più rimuneratore del furto. La coscienza mi diceva di aver reso un buon servizio alla Nurra; e confesso che fu questa una delle azioni, di cui più mi compiacqui durante la mia vita di bandito.
Avrò il rimorso di aver dato qualche fucilata ai nemici, ma non ho quello di aver rubato un centesimo al mio simile. Questo mio merito fu riconosciuto da tutta la Nurra, e mi fu confermato anche nelle Assise di Frosinone [212] dalla bocca del Presidente e del Pubblico Ministero.
Eppure, chi lo crederebbe? La persecuzione verso i ladri fu quella che mi procurò qualche nemico nella Nurra, ad anche in Sassari. Una persona rispettabile un bel giorno mi disse:
— Chi vuol vivere tranquillo non deve occuparsi che del fatto suo.
Gli risposi piccato:
— Non sempre. Dobbiamo anche occuparci dei fatti altrui, quando possiamo risparmiare un danno al nostro simile.
[213]
La mia buona condotta, le simpatie che godevo per la persecuzione ai ladri e per la mia sincerità, avevano fatto sì, che la Giustizia a me ricorresse, quando desiderava qualche schiarimento a favore, o contro ai complicati in un processo. Ond’è, che fui chiamato cinque o sei volte (con salvacondotto) a deporre presso giudici istruttori, procuratori del re e presidenti delle Assise.
Ho già parlato delle mie deposizioni a proposito degli assassinî di Dionisio e di Longiave, e degli sgozzatori de’ miei buoi. Accennerò ora a parecchi altri schiarimenti da me dati, dietro invito dell’autorità giudiziaria.
Venni chiamato la quinta volta a Sassari come testimonio nella causa contro Don Peppe Lado di Siligo, accusato dell’uccisione del bandito, pur silighese, Gianuario Murgia. Il fatto era accaduto da una diecina d’anni, e lo avevo già riferito al Cav. Ferrè, maggiore dei carabinieri.
[214]
Riassumo le deposizioni, da me riconfermate dinanzi al giudice istruttore.
Antonio Canu, capitano dei barracelli di Siligo, aveva ammonito il bandito Gianuario Murgia; e questi, per vendicarsi, lo ferì con una fucilata.
Salvatore Contene (cognato del capitano) mi mandò a chiamare, dicendo che Don Peppe aveva bisogno di parlarmi.
Presentatomi la stessa notte ad entrambi, si parlò di Murgia. L’opinione di Contene era quella di dover uccidere il bandito; don Peppe invece era d’avviso, che bisognava farlo arrestare per strappargli qualche nuova confessione. Io, come Pilato, me ne lavai le mani.
Quindici giorni dopo, Murgia veniva ucciso da Contene e da certi Foi, padre e figlio, di Bessude.
Chiamato in quel tempo a Sassari con salvacondotto, fui avvicinato da Contene; il quale mi disse in confidenza, alludendo all’uccisione di Murgia:
— Quel birbante credeva di sfuggire a noi! Dopo morto lo abbiamo affidato al brigadiere, il quale volle trarci fuori causa.
— Gran prova avete fatto! — esclamai — Lo uccideste dentro la casa di Foi, ed eravate in tre. Come ve la siete cavata?
— Appena morto lo abbiamo trasportato in piazza, per lasciare tutto il merito al brigadiere, che in seguito simulò un assalto.
[215]
L’inganno era manifesto. Il bandito Murgia soleva portar seco una bisaccia, assicurata alle spalle a mo’ di zaino, per riporvi la lingeria e le provviste da bocca. Con tal bisaccia fu trovato il cadavere; ma la ferita mortale, rinvenutagli al di sopra della schiena, diceva chiaro che lo zaino gli era stato rimesso dopo l’uccisione.
Riferendo il fatto al Cav. Ferrè, conchiusi:
— Ella ha i mezzi per accertarsi di quanto asserisco. La prevengo intanto, che se lei darà un premio, o la medaglia, al brigadiere, saremo in molti a ridere!
Appurati i fatti, il maggiore Ferrè rimproverò accerbamente il brigadiere; il quale, o per le minaccie d’una punizione, o per la vergogna del valore simulato, o perchè realmente fosse affetto da qualche malore, ne morì dopo quindici giorni.
Arrestato don Peppe, sul quale cadevano più gravi i sospetti, venne assolto, dietro le prove di aver egli voluto la cattura, non la morte di Gianuario Murgia.
***
Parlerò ora della causa, che provocò il rilascio del mio sesto salvacondotto.
Un giorno, nella Murra, venne a trovarmi un tale; il quale m’invitò a prestargli mano in un colpo, che ci avrebbe procurato molto danaro.
[216]
— Sentiamo di che si tratta.
— Ho proposto, in unione ad altri, di uccidere il signor B..., messo esattoriale del signor Baloco, quando verrà a fare il solito giro per la esazione delle imposte. Vendicheremo in pari tempo i nurresi, per le angherie di quel tiranno, che strappa persino gli orecchini alle nostre donne.
— Dio vi liberi dal toccare il danaro del Governo! Non avrete più pace nella Nurra, e vi coglieranno. Io non mi sono mai prestato, nè mi presto a simili azioni.
Non si parlò d’altro; ed io credetti una sfuriata dispettosa la proposta di quel tristo.
Trascorso un mezz’anno, fu tradotto in atto il malvagio disegno. Una combriccola di otto o dieci individui prepararono due agguati in diversi punti della strada, che il messo doveva percorrere. Quando il messo comparve fra due carabinieri e due uomini di guida, tutti a cavallo, gli appostati fecero loro fuoco addosso. Venne ucciso il messo, e ferito una delle guide. I due carabinieri, rimasti illesi, si erano dati alla fuga.
I malandrini si fecero intorno al cadavere del messo, e gli tolsero la somma di 17 mila lire, che aveva indosso. Prima di dividere il bottino, i ladri mandarono a chiamare certo Proto, padrone dell’ovile, in cui il messo esattoriale prendeva alloggio, quando si recava alla Nurra.
— Vuoi tu la tua parte? — gli chiesero i malandrini.
[217]
Accortosi che lo si voleva complice. Proto rispose:
— Non voglio nulla di ciò che vi appartiene. Desidero solamente i cento scudi, che il messo mi ha chiesto in prestito, in anticipazione d’imposte.
Non passò gran tempo, che fui chiamato con salvacondotto nel gabinetto particolare del giudice Pirari:
— Ti chiamo in consulto senza testimoni — disse — per l’oltraggio fatto al Governo con l’assassinio del suo messo esattoriale. Dammi qualche schiarimento.
Dopo aver riflettuto, gli risposi con una domanda:
— Mi dica prima: piacciono i porcetti ai signori di Sassari?
— Dammi schiarimenti sugli assassini del messo esattoriale! — continuò il giudice, fingendo non aver inteso. Ed io di nuovo:
— Piacciono ai signori di Sassari i porcetti?
Il giudice istruttore fece ancora il sordo, e continuò a parlarmi di oltraggi al Governo e di schiarimenti che da me si volevano.
— Ma lei non vuol rispondere alla mia domanda! — soggiunsi con impazienza — Piacciono i porcetti ai signori?
Stretto in tal modo, Pirari mi rispose:
— I porcetti piacciono a tutti!
— Si rassegni, allora, a non veder mai condannato [218] un nurrese dalla Corte d’Assise di Sassari! — esclamai risoluto — Ho tutto detto.
— Tu fai allusioni maligne!
— Sono padrone di dire la mia opinione. Sono venuto con salvacondotto, e col salvacondotto me ne vado.
Così dicendo piantai il giudice Pirari, senza far nomi, nè dare alcun indizio sugli assassini.
Dopo qualche mese fu iniziato il processo e fatto il dibattimento; ma i pochi arrestati vennero assolti. Nessuno nella Nurra aveva ucciso il messo esattoriale!
***
Passato un po’ di tempo, il mio amico e compaesano Antonio Giuseppe Zara venne a me per dirmi, che l’esattore Baloco voleva conoscermi. Io sapevo che l’amico (i cui affari erano andati male) avrebbe volentieri accettato un impiego nell’Esattoria.
Ebbi più tardi, nella casetta di Lèccari, la visita di Baloco, che venne accompagnato dallo stesso Zara. Vivamente impressionato del caso del suo messo, egli mi chiese consiglio sul miglior modo di effettuare l’esazione delle imposte nella Nurra. Mi esternò la sua intenzione, di nominare a messo certo Punzu, che dicevasi mio nipote. Io risposi:
— Non mi è nipote; ma se tale pur mi fosse, [219] devo dichiarare che non lo credo adatto alla gelosa carica, poichè è un ladro. L’uomo che dovete scegliere è il mio amico Antonio Giuseppe Zara, qui presente. Egli è abile, sobrio, modesto nelle pretese; ed io mi adoprerò presso tutti i contribuenti della Nurra, perchè venga riconosciuto e rispettato.
L’esattore Baloco seguì il mio consiglio, ed accettò lo Zara, che mantenne al suo servizio per oltre due anni. Prestavo all’amico la mia cavalla per fare il giro degli ovili, nè ebbe mai a lamentare sinistri, nè inconvenienti di sorta. Non feci al nuovo messo che questa sola raccomandazione:
— Siccome i pastori nurresi sono molto diffidenti, tu indicherai a ciascuno di essi la quota delle rispettive imposte, invitandoli a fare il versamento diretto nell’ufficio di Sassari. Si eviteranno così le dicerie, e il messo non potrà attirarsi gli odî e le ire del contribuente sospettoso. Dippiù, sapendo che non hai danari addosso, a nessuno verrà il ticchio di frugarti nelle tasche.
***
Postochè sono tra i salvacondotti, parlerò del mio abboccamento col maggiore dei carabinieri Cav. Leopoldo Ferrè, funzionario scrupoloso, quanto leale e cortese[32].
[220]
Dopo il nostro primo colloquio in campagna, al momento di separarci, egli mi porse due sue carte da visita, pregandomi di apporre ad entrambi la mia firma, od una parola convenzionale.
Tolsi il calamaio e la penna dalla mia piccola bisaccia, e scrissi il mio nome e cognome, spezzandoli per metà e invertendo le due parti, così: Vannigio Luto.
— Bravo! — mi disse. — Ammiro la tua ingegnosa trovata.
Ripresi i due biglietti, il Maggiore ne chiuse uno nel suo portafoglio e mi restituì l’altro dicendo:
— Sempre quando avrai bisogno di conferire con me, mandami questo biglietto per la posta, o per mezzo di persona di tua fiducia, ed io verrò all’appuntamento. Se invece sarò io che avrò bisogno di parlarti, farò in modo di farti recapitare l’altro simile biglietto. Puoi contare sul segreto e sulla mia parola.
— È inutile la sua dichiarazione — risposi — Io so che la violazione di simili accordi potrebbe tornare di pregiudizio anche a lei; poichè nessun latitante più si presterebbe a fornire schiarimenti alla giustizia, in favore degli innocenti e in odio ai malandrini.
Il Maggiore Ferrè riflettè alquanto, poi mi disse con tono serio:
— Intendiamoci, però. Allo infuori dello scambio dei due biglietti, che paralizzeranno ogni [221] azione iniziata, io non mancherò di mandare i miei carabinieri per darti la caccia in campagna, o dovunque mi s’indicherà il tuo rifugio.
Risposi con pari gravità:
— Lei è Maggiore dei carabinieri, e deve fare il suo dovere. Io farò il mio. Sono da oltre vent’anni bandito, ed ho assai cara la mia libertà. Non ho mai attaccato per il primo i carabinieri; ma se mi attaccano, saprò difendermi: lei lo sa bene!
— Siamo intesi.
E ci separammo.
Ebbi in seguito diversi incontri coi carabinieri da lui mandati alla mia ricerca; ma seppi sempre deludere gli appiattamenti colla freddezza della testa e coll’agilità delle gambe, senza ricorrere al mio fucile. Tanto meglio per me.... ed anche per loro.
[222]
L’ho detto: raggiunto il sedicesimo anno, Maria Antonia si era allontanata dalla scuola per ritirarsi in casa dello zio Ignazio, sotto la sorveglianza di mia sorella Andriana e di mia madre. Quest’ultima si recava ogni tanto a Florinas per visitarvi gli altri parenti, ma non abbandonava la sua prediletta nipotina, che più delle altre aveva bisogno di cure. Io era bandito, e mia moglie non esisteva che per il ganzo.
Vedevo assai spesso la mia figliuola (massime nei mesi che la famiglia di mio cognato si ritirava nel suo ovile della Nurra) e le mandavo ogni tanto qualche lettera per esercitarmi nello scrivere, o per darle qualche commissione. Quando, per esempio, avevo bisogno di un paio di pantaloni, d’una giacca, od altro, le ordinavo di vendere qualche rasiere del mio grano, che tenevo in deposito presso mio cognato. Scrivevo allora al negoziante Nicolò Costa di Sassari (mio amico) il quale mi faceva eseguire gli abiti su misura di un suo giovine di negozio, che aveva la mia [223] stessa corporatura. D’ordinario preferivo il panno che si tesseva nel Convento di San Pietro, perchè di lunga durata. Aspettavo che i frati venissero alla questua nella Nurra, davo loro la commissione, e il guardiano mi serviva puntualmente. Benchè bandito, ero ritenuto un uomo onesto dalla piazza di Sassari, e mi si dava credito.
Il tempo intanto volava, e la mia figliuola, che cresceva a vista d’occhio, si era fatta belloccia. Non era più l’allegra e spensierata scolara ch’io mi sedeva sulle ginocchia pochi anni addietro; la bambina diventava donna, ed io vedeva di giorno in giorno svilupparsi le sue forme ed aumentare la sua gravità contegnosa. Con l’occhio grande e nero, le guancie rosee e paffuttelle, la taglia svelta ed aggraziata, Maria Antonia veniva su come un fiore di primavera. Mi ero già accorto che qualche farfallone le ronzava intorno, e me ne dispiacque. Cominciavo a guardarla con una certa compiacenza gelosa; e ogni volta che mi separavo da lei, dicevo a me stesso con un sospiro:
— Non c’è verso: bisogna ch’io mi rassegni a cederla ad altri; bisogna proprio darle marito.
Non aveva ancora raggiunto i diciasett’anni quando mi venne chiesta in moglie da parecchi giovani della Nurra e di Portotorres; ma io rispondevo a tutti con un rifiuto, dicendo ch’erano altre le mie intenzioni.
La scelta dello sposo è uno dei problemi più [224] ardui per le nostre famiglie. Bisogna andar cauti, dappoichè ben sovente, col genero, attiriamo in casa un nemico — un apportatore di scompigli e di discordie fra padre e figli, tra sorelle e fratelli. Avevo conosciuto più di un suocero ch’era stato tradito dal genero, e più di un genero ch’era stato ucciso dal suocero.
Il marito è sempre uno straniero che entra nella nostra casa; un intruso, di cui non conosciamo gli umori, nè le stravaganze. Non mi bastava attenermi al proverbio: moglie e buoi de’ paesi tuoi — volevo qualche cosa di più!
Debbo tuttavia confessare, che la scelta dello sposo non mi tenne a lungo sulle spine. Già da tempo avevo in segreto vagheggiato il mio ideale: volevo dare a Maria Antonia un marito di famiglia — un giovane savio, che mi risparmiasse il fastidio delle informazioni, e allontanasse il dubbio di una cattiva riuscita. Pensai subito a mio nipote: a Giovanni Agostino, il figlio della buon’anima di Felice, il nostro fratello maggiore. Era un bravo ragazzo che amavo come figlio, e che in quel tempo si trovava in continente facendo il soldato.
Un bel giorno dissi alla mia vecchia:
— Dirai alla madre di Agostino, che suo figlio deve unirsi alla mia figliuola. Appena terminato il servizio militare, lo prenderò con me. Egli lavorerà per conto mio, e troverà tutto pronto: terra, buoi, grano e danaro. Non avrà [225] così bisogno di poltrire in Florinas, a servizio d’altri. Se io più non fossi al mondo... se i nemici o i carabinieri mi uccidessero... ricordati, mamma, che questa è la mia volontà, e voglio che sia eseguita!
Agostino non aveva padre, ma padrastro; poichè, morto Felice, la vedova si era rimaritata.
Il padrastro diceva a tutti, perchè me lo riferissero:
— Se Agostino, quando ritornerà da fare il soldato, non mi servirà per due anni, non avrà da me dote.
Ed io rispondevo:
— Ne faremo anche senza!
Venuto Agostino a Florinas, in permesso, gli mandai subito a dire, che desideravo conferire con lui. Egli venne alla Nurra, in compagnia di mio cognato Ignazio Piana.
Pregai quest’ultimo, che s’incamminasse all’ovile, per lasciarmi solo con mio nipote.
— Agostino — gli dissi — tu ti devi maritare colla mia figliuola. Avrai una buona moglie, buoni buoi, grano da seminare e da far pane, e soldi da spendere. Se avrai giudizio potrai diventare un uomo ammodo, poichè son nemico degli oziosi e dei malandrini!
Mio nipote mi rispose con poche parole:
— Farò quanto lo zio vuole!
Passeggiammo alquanto per la campagna, finchè sull’imbrunire movemmo insieme all’ovile.
[226]
Dinanzi a’ miei parenti, ivi raccolti, presi per mano Agostino e la mia figliuola, li avvicinai l’uno all’altra, e feci loro scambiare i baci della promessa. Seguì l’abbraccio e il bacio reciproco degli altri presenti.
La mia figliuola si dichiarò felice della scelta.
Prima di separarci chiamai a parte Maria Antonia:
— Bada: ora che Agostino se ne va, procura di dargli qualche soldo. È stato promosso a caporale, e i danari gli fanno bisogno.
Agostino tornò al suo Reggimento per continuare il servizio militare.
I due fidanzati si scrivevano con frequenza, e Maria Antonia smaniava, ogni qualvolta riceveva una lettera dal continente.
Avevo ordinato alla mia figliuola di mandarmi sempre le brutte copie delle lettere che scriveva al fidanzato; ma ella non mi mandava che quelle di Agostino, certo per non farmi sapere che gli spediva ogni tanto danaro. Aveva forse scrupolo di dirmi una bugia. Notai che mio nipote chiudeva ogni sua lettera con un’ottava sarda, in lode della grazia e dell’avvenenza di mia figlia.
***
Terminato il servizio militare, Agostino fece ritorno a Florinas, dove si fermò quattro giorni. Si recò quindi a Portotorres per farsi tingere un [227] po’ di orbace. Abboccatosi con me nella Nurra, gli dissi:
— Tua madre ha altri figli cui pensare. Non voglio, dunque, ch’ella spenda per farti una veste di orbace. Ti vestirò io!
Gli diedi il danaro necessario e gli ordinai che si recasse a Sassari presso l’amico Zara, a cui avevo dato incarico di fargli prendere la misura degli abiti.
— Appena t’avranno vestito — gli dissi — torna da me, perchè penso di affidarti la sorveglianza della mia piccola azienda, come a futuro padrone.
Non appena fu di ritorno, diedi a mio nipote due paia di buoi, e me lo associai nell’agricoltura.
In compenso del mantenimento di mia figlia, avevo ceduto a mio cognato Piana due paia di buoi, oltre un’ottantina di pecore, ch’egli sfruttava a proprio beneficio. Un terzo paio di buoi ed una buona cavalla favorivo pure a mio fratello Giomaria, allora disoccupato e con qualche debito. Come vedete, il povero bandito non ha mai lasciato di soccorrere i parenti, quando era in condizione di farlo!
Dopo il fidanzamento di mia figlia, e due anni prima dello sposalizio, mi ero dato attorno alla ricerca di un luogo adatto, che presentasse tutte le comodità possibili, tanto per me, quanto per gli sposi. Fermai la mia attenzione sulle [228] terre e sulla cascina di Lèccari, che rispondevano alle mie vedute. La cascina era vasta, le terre buone, e breve la distanza che le divideva da Portotorres, dov’erano i nostri parenti.
Il tenimento di Lèccari — buonissimo per i miei figliuoli — era per me un luogo sicuro, specialmente per la vicina palude, tutta coperta da folti canneti, nella sua estensione di oltre 50 ettari. Nell’estate, quando le acque evaporano o si ritirano, un uomo può percorrerla quasi tutta a piedi, senz’essere avvertito da nessuno, per l’altezza delle canne palustri. I cinghiali vi si rifugiano nella stagione calda — e di rifugio poteva servire anche a me, uomo-cinghiale, cui si dava la caccia.
Ottenuta Lèccari in affitto, volli unire a me, come soci, mio fratello Giomaria, mio cognato Piana e Giovanni Puzzone, ai quali somministravo terra e semente, concedendo loro di poter occupare la cascina. Agostino, da me provveduto di buoi, di semente e di danaro, si era dedicato con ardore all’agricoltura, e lavorava insieme ai parenti, tanto per proprio conto, quanto per la mia casa.
***
Ero contento di quanto avevo fatto.
Fantasticando sull’avvenire de’ miei figliuoli, una sera io trottava a larghi passi verso Lèccari, quando m’imbattei in un pastore nurrese, che [229] tornava a cavallo da Portotorres, dopo essere stato parecchi giorni a Sassari, per sbrigarvi alcuni suoi affari.
Ero più di buon umore del solito, perchè tutto mi era andato a gonfie vele.
— Hai buone notizie a darmi? — gli chiesi sorridendo.
L’amico pastore si fece serio, si mostrò alquanto impacciato, e alfine mi disse:
— Per te ho una brutta notizia...
Il sangue mi affluì al cuore, e pensai subito a qualche sinistro capitato alla mia figliuola, che trovavasi quel giorno a Portotorres presso lo zio.
— Hai veduto Maria Antonia?! — gridai spaventato.
— È poco più d’un’ora, che l’ho lasciata sana ed allegra.
Respirai liberamente, e riprendendo l’umor gaio gli chiesi con indifferenza:
— Puoi darmi la brutta nuova.
— La Corte d’Assise di Sassari ti ha condannato in contumacia alla pena di morte[33].
— Non è che questo? Pazienza! Vuol dire che d’ora innanzi dovrò meglio curare la mia pelle, perchè aumentata di valore.
— Come quella di Francia? — soggiunse il pastore, ammiccando l’occhio, con allusione [230] al drudo di mia moglie, già ritornato da Marsiglia.
— Quella non ha prezzo, perchè non serve.
— E non pensi di conciarla?
— Mai. Rimarrà sempre una pelle di montone.
***
Si avvicinava intanto il giorno designato per le nozze.
Agostino aveva 25 anni, e la mia figliuola 19. Essendo quest’ultima minorenne, non poteva contrarre il matrimonio dinanzi al sindaco, senza il consenso d’entrambi i genitori — nè io era l’uomo da umiliarmi a chiederlo ad una madre adultera. Decisi dunque di lasciare a miglior tempo il matrimonio civile, e di celebrare quello religioso.
Il primo gennaio del 1870, Agostino e Maria Antonia, accompagnati dai parenti, tutti a cavallo, si recarono per la cerimonia alla basilica di San Gavino di Portotorres.
Appena compiuto il rito, si andò tutti a casa di Piana e di mia sorella Andriana, dove fu imbandita la mensa per il pranzo di nozze. Da Florinas erano pur venuti molti altri parenti, e la baldoria si fece tutta a mie spese.
Quel giorno io mi trovava alla montagna, colla mente e col cuore rivolti ai due lontani [231] figliuoli, che avevo unito per sempre. Nessuno mancava a questa festa solenne, tranne il padre e la madre. Ma l’adultera e il bandito non potevano quel giorno assistere alla felicità della propria figliuola!
Dopo essersi fermati quattro giorni a Portotorres, gli sposi fecero ritorno alla Nurra, ed andarono ad abitare nella cascina di Lèccari. Ivi rimasero insieme a mio fratello Giomaria, che vi aveva la moglie, i figli ed i servi. Le due famiglie si facevano buona compagnia, ed io n’era contento.
Col cuore trepidante, dimenticando la mia condanna a morte, io corsi al nido per baciare i miei colombi; e quindi continuai la mia vita di fuggiasco e di solitario.
[232]
Pur fuggiasco di balza in balza, riparavo ogni tanto a Lèccari per visitarvi i miei figliuoli, o indicavo loro un posto sicuro, per poterli parlare con animo più tranquillo. Avevo sempre qualche consiglio da dare per il buon andamento dell’azienda, o per la conservazione della pace domestica.
Verso quel tempo m’imbattei in un povero carbonaio di Alghero, venuto alla Nurra in cerca di un compare per tenergli a battesimo un bambino. Si era rivolto a molti amici nurresi, presso i quali aveva lavorato, ma tutti si erano rifiutati ad appagarlo, dichiarandosi sprovvisti di abiti decenti per poter assistere in città ad una simile cerimonia.
Mosso a pietà di quel poveretto gli dissi:
— Domanda al parroco di Alghero se la chiesa permette ad un bandito di fare un battesimo in procura. Se ti dice di sì, io sarò il tuo compare.
Tornato a me colla risposta affermativa, feci di buon grado le spese necessarie: uno scudo per [233] la procura, tre scudi e mezzo per dolci e vini, e sette reali e mezzo per la candela. Per mio procuratore era stato scelto il fratello dello stesso carbonaio, un soldato venuto di recente in congedo.
Riconoscente per il servizio resogli, il carbonaio mi fece dono di una baionetta, regalatagli dal fratello. Non sapendo che farmi di quell’arma bianca, la cedetti a certo Giomaria Bacchile, il quale l’adattò ad un bastone, per servirsene ad uccidere i porci.
Ora avvenne, che questo Bacchile, imbattutosi un bel giorno nella mandria di porci del suo nemico Paolo Agus, glie ne uccise otto per dispetto.
Dalle ferite triangolari prodotte dalla baionetta, non tardò Agus a scoprire il reo; ed unitosi a Chiccu Mulas, un bel giorno l’uccisero.
Chiccu Mulas venne subito arrestato, ma Paolo Agus prese la macchia e si fece bandito. Quest’ultimo morì d’indigestione tre mesi dopo, per aver mangiato la carne d’una cinghialotta magra, forse affetta da malattia.
Come vedete, il regalo del mio compare algherese era stato fatale a tre persone!
I fratelli Paolo e Baingio Agus, nurresi, mandavano molti regali agli avvocati di Sassari, loro compari di battesimo. Debbo però confessare, che erano gente di buon conto ed onesta. Diverse volte si erano a me rivolti per denunziare i porci d’altri, entrati nelle loro mandre.
[234]
Ero diventato una specie di mediatore; ed a me si ricorreva sempre, tanto da chi smarriva, quanto da chi trovava un capo di bestiame. Quasi sempre riuscivo a rintracciare il padrone, che mi era grato e mi regalava qualche cosa.
Conoscevo pure Giomaria Bacchile. Poco tempo innanzi era venuto da me, pregandomi di aiutarlo a sbarazzarsi di Chiccu Mulas, da cui più tardi fu ucciso.
— Caro mio! — gli risposi — se ci hai rischio della vita, devi pensare ad aggiustarti da solo. Io non estraggo il dente che non mi duole.
Giomaria Bacchile mi tenne il broncio. Egli intanto cominciò coll’uccidere i porci del suo nemico... ma fu tradito dalla mia baionetta. Tristo colui, che cerca il braccio d’altri per strappare il dente che gli dà fastidio!
***
Ho già detto che l’accorto bandito, a piedi od a cavallo, viaggia sempre la notte. Per scorciatoie o per la via maestra, attraversando poderi o saltando muri, egli percorre cinque o dieci ore di strada per recarsi da un punto all’altro.
Quantunque da molti anni non facessi male a nessuno, e menassi una vita quieta, senz’altro pensiero che quello de’ miei figliuoli e dei ladri che perseguitavo, pure non potevo liberarmi dall’incubo dei carabinieri. Debbo però confessare, [235] che invece di essere loro a darmi la caccia, d’ordinario ero io che andavo a cacciarmi fra i loro piedi, senza volerlo; e l’ho già dimostrato con alcuni casi narrati.
Moltissime volte, sullo stradone di Florinas e di Portotorres, trottando a cavallo col cappuccio sugli occhi, mi ero imbattuto in carabinieri mandati per espresso dall’una all’altra stazione. Non ebbi però mai a lamentare il minimo disturbo; poichè i carabinieri, di notte, ben di rado recano molestia a chi va diritto per la sua strada... e fanno benissimo!
Mi ero recato io quel tempo nelle vicinanze di Banari per salutare alcune vecchie conoscenze. Venuto a me un proprietario del paese, si lamentò della mancanza di un bellissimo bue nero, rubato in quei giorni ad un amico di Don Ignazio Corda. Promisi di occuparmene al mio ritorno nella Nurra.
Passando, infatti, dinanzi all’ovile di un mio nipote, in Santa Barbara, lo resi avvertito che mi era stata denunziata la mancanza... di una cavalla, appartenente ad un amico di Sassari.
Mio nipote esclamò ingenuamente:
— Una cavalla, no; ma fu trovato un bellissimo bue nero, del peso di sette od otto cantari. So che fii ritirato da Giuseppe Fraizzu di Ossi.
— Non cerco buoi: cerco una cavalla — risposi affettando noncuranza, ma lieto di essere sulle traccie del fatto mio.
[236]
Ritornato la stessa notte a Banari (non frapponevo indugio in simili affari!) diedi relazione del rintracciamento, soggiungendo:
— Indicherò il ladro, ma a condizione che egli venga arrestato insieme al bue. Se non si farà così, mi chiuderò nel silenzio.
Ero inesorabile, poichè avevo deciso di far dare una seria lezione ai ladri di bestiame.
Siccome in Banari comandavano allora i fratelli Don Ignazio e Don Pietro Corda, stretti in parentela a persone dell’alto clero e dell’alta magistratura di Sassari, fu fatto rilasciare un porto d’armi, valevole per una settimana, ai quattro incaricati di ritirare il bue nero dalla Nurra.
Io mossi con essi da Banari, per indicar loro il luogo dove il bue era stato condotto.
Giunti però a una certa distanza, non volendo mostrarmi, ordinai ad un uomo di mia confidenza (certo Antonio Tontu) di accompagnare i banaresi fino al muro della tanca di Fraizzu, senza però farsi vedere.
Quello stupido però, credendo forse di farmi piacere, guidò gli uomini fin dentro alla tanca, e la sua presenza fu subito avvertita dal servo, che ne informò il padrone.
Giuseppe Fraizzu, per sua fortuna, era assente da più giorni, e perciò non venne arrestato.
Mentre i banaresi riconducevano in paese il bue nero, s’imbatterono a Scala di Ciogga nel [237] pretore, che si restituiva ad Ossi. Come vide la bestia nera, egli rammentò la denunzia fattagli, chiese schiarimenti, ed ordinò ai conduttori del bue di recarsi la stessa sera nella pretura. Ivi i banaresi dichiararono, di aver rinvenuto il bue rubato nella tanca di Giuseppe Fraizzu.
Chiamato costui dal pretore, fu sottoposto ad un rigoroso interrogatorio; e finì per sborsare oltre cento scudi, riuscendo con impegni a liberarsi dalla prigione.
Non gli fu difficile accertarsi, che il brutto tiro gli veniva da me. Inasprito per la restituzione del bue nero; dolente per il danaro sborsato; punto sul vivo per la vergogna subìta, Giuseppe Fraizzu giurò di vendicarsi; ed ho ragione per credere, che realmente egli si sia vendicato — come diremo a suo luogo.
[238]
Un certo prete Pinna, abitante in Sassari verso il Molino a vento, amministrava come procuratore l’ovile di Filigheddu. Lo aveva dato in affitto a quel tale Migheli, già occupante la cascina di Monte Fenosu, quando vi avvenne lo scontro dei carabinieri con me e con Cambilargiu.
Dopo tre anni di esercizio, Migheli morì; e il prete tormentava la vedova ed i figliuoli per il pagamento di oltre 400 scudi, asserendo di non aver mai ricevuto somma alcuna dal defunto.
La vedova, intanto, aveva lasciato Filigheddu per ristabilirsi a Monte Fenosu, dove spesso capitavo, nel breve tempo che mi ero unito al bandito Ibba, già compare di battesimo del Migheli.
Un giorno la povera donna, dinanzi a me e ad Ibba, si era scagliata contro l’ingordigia di prete Pinna, il quale pretendeva di essere pagato d’una somma, che lei protestava di non dovere.
— Prendo impegno di occuparmene io! — esclamai vivamente.
[239]
E infatti scrissi alla bella meglio una lettera insolente al prete, invitandolo a rifare i conti. Gli scrivevo fra le altre cose: «— questa volta non potrà certo valersi delle fatucchierie, a cui ella ricorre per acciecare la mente dei gonzi.»
Non avendo ricevuto risposta alla mia lettera, glie ne scrissi una seconda più pepata, che feci pur firmare dal mio compagno Ibba.
Il prete consegnò le due lettere al procuratore del re Cav. Dore; il quale mi chiese spiegazioni per mezzo dell’amico Antonio Giuseppe Zara, suo vicino di casa.
Capitato un giorno a Sassari con salvacondotto, mi presentai al Dore, e gli esposi i fatti. Egli chiamò subito la serva del prete, la quale era a conoscenza delle somme versate dal Migheli in acconto del suo debito.
Le donne — a quanto io so per lunga esperienza — sono capaci di un giuramento falso per nascondere il proprio peccato — ma quando trattasi dei peccati degli altri dicono sempre la verità.
— Se il mio padrone ha ragione — ella mi disse — saprà farla valere; se poi avrà torto, dovrà rassegnarsi a soddisfare la vedova Migheli!
Il Cav. Dore, che mi aveva promesso di aggiustare lui la facenda, si fece dar nota (con testimonianza della serva) di quanto il prete Pinna aveva ricevuto dai Migheli in danaro, in latte, ed in montoni. Rifatti i conti, risultò che [240] la famiglia del pastore era debitrice, a saldo, di soli 30 scudi, non di 400 come si pretendeva.
La lite per questo credito pendeva da parecchi anni presso il tribunale; ma fu per il mio mezzo che i Migheli la videro risolta, ricuperando un credito che ormai credevano perduto.
Questo fatto mi procurò nuovi rancori, per parte dei partigiani di prete Pinna, e nuove simpatie per parte delle persone oneste e di buon cuore.
***
Tralascio di enunciare altre simili pratiche, da me fatte in favore dei deboli e degli ignoranti, eterne vittime della prepotenza e della furberia. Dirò solamente di un caso avvenutomi, reso popolare per opera dei beneficati, non mia, chè anzi avevo interesse a tenerlo celato.
Un giorno mi trovavo in un punto alto, sopra una collina posta nella Gianna de su ferru, in vicinanza della strada maestra, che dalla miniera dell’Argentiera conduce a Portotorres.
Siccome quel punto è battuto dai carabinieri, esploravo dall’alto la campagna circostante, per evitare le solite sgradite sorprese.
A un tratto, sulla strada, scorsi due operai continentali, che venivano dall’Argentiera, dove pur lavorava mio fratello Peppe, in qualità di operaio caporale. Volendo chiedere notizie di [241] lui, scesi dalla collina per interrogare i due viaggiatori.
— Buona sera! — dissi, movendo loro incontro.
— Buona sera! — risposero quelli, senza quasi guardarmi, e con un accento di profonda mestizia.
— Che cosa avete? — chiesi loro.
— Ci hanno rubato i pochi soldi che avevamo addosso.
— Chi ve li ha presi?
— Il bandito Giovanni Tolu, ch’era in compagnia di altri due.
Fui sorpreso della strana risposta, che in sulle prime credetti una canzonatura.
— Che uomini erano?
— L’uno aveva un fucile a due colpi; l’altro, giovanotto, era pure armato; il terzo, uomo maturo, conduceva a mano un cane, legato con una corda. Dopo averci tolto il danaro, il più robusto ci disse: — Se voi svelerete l’accaduto, vi ricorderete del bandito Giovanni Tolu!
I birbaccioni si erano serviti del mio nome per atterrire i viandanti, ed io non doveva lasciare impunita una simile audacia.
— Fatemi il piacere di condurmi sul punto, dove vi hanno preso i soldi.
— Siamo in viaggio per Portotorres, poichè dobbiamo prendere imbarco.
— V’imbarcherete un altro giorno. Oggi vi [242] porterò nel mio ovile, dove troverete da mangiare e da bere; prima, però, ho bisogno di vedere il posto in cui foste derubati.
I due operai continentali, forse per paura, non volevano tornare indietro; ma io imposi loro di appagare la mia curiosità.
Si rifece insieme un po’ di strada, fino al punto detto Sa punta de su ferru, che m’indicarono come il luogo della grassazione.
Non era quello un sito di ladri, perchè in vicinanza abitavano alcuni pastori.
Pregai i due operai che mi aspettassero là per alcuni minuti.
Io conosceva l’uomo anziano che conduceva a mano il cane, e m’internai nel boschetto, fino ad una punta, in cui i pastori solevano radunarsi.
Il cane non avvertì il mio passo, e non prese ad abbaiare, poichè aveva il vento cattivo[34].
Come arrivai alla distanza di una ventina di passi dalla punta, tesi l’orecchio, e m’accorsi che i pastori si bisticciavano per la divisione del bottino.
Mi diedi allora a tossir forte, e m’avvicinai indifferentemente.
— Buona sera!
— Buona sera, zio Giovanni. Che buon vento vi conduce a queste parti?
[243]
— Fatemi un piacere. Ho scovato testè un cinghiale in una macchia, ma non c’è verso di farlo venir fuori. Ho bisogno di prenderlo oggi, perchè devo farne un presente. Aiutatemi.
— Ben volentieri!
Mi vennero tutti e tre dietro.
— State attenti, veh? chè il cinghiale non scappi, deviando dal mio filo!
Camminai così avanti, sempre col fucile spianato, fino a che portai i tre compagni vicino alla strada, dove mi aspettavano i due forestieri.
Fingendo girare di qua e di là, come per non lasciarmi sfuggire il cinghiale, mi avvicinai agli operai, dicendo loro piano:
— Fissateli bene: sono questi gli uomini che vi hanno preso il danaro?
— Sì, signore: proprio questi!
— Qual somma vi hanno rubato?
— Novantasette lire.
Corsi allora verso i tre pastori, e gridai loro, cambiando tono:
— Restituite subito a costoro il danaro rubato!
I tre uomini mi fissarono sorpresi e sgomentati, ma non fecero alcuna resistenza. Senza dir motto, tolsero da tasca il danaro, e me lo porsero abbassando gli occhi.
Dopo aver restituito ai tre operai le 97 lire, dissi ai pastori:
— E badate che non vi accada una seconda [244] volta! Guai a voi, se minaccierete chicchessia servendovi del mio nome!
I pastori, mortificati, ammutolirono, poichè in fondo non erano perversi. Io dissi allora, rivolto ai due operai:
— Lo vedete? Io sono appunto Giovanni Tolu, il bandito; il quale non ha bisogno di rubare, perchè ha qualche cosa del suo; e se non ne avesse, i signori glie ne darebbero!
Gli operai volevano ad ogni costo che io accettassi in ricompensa la metà della somma.
— No: tenetela tutta, perchè siete più poveri di me. Io non ne ho bisogno, mentre voi siete forestieri, che venite da lontano per lavorare. Datemi solamente notizie di mio fratello Peppe, caporale alla miniera. Lo conoscete?
— Sì, signore. Gli parliamo ogni giorno. Egli sta bene in salute.
— Grazie. Di che paese siete?
— Siamo piemontesi.
— Continuate pure la vostra strada, e fate buon viaggio!
Arrivati la sera a Portotorres, i due forestieri narrarono il caso a molte persone, fra le quali a Cosimo Cucinotto, più tardi mio teste di difesa a Frosinone.
Ricevetti in quel tempo diverse lettere da Sassari e da Florinas, colle quali mi si chiedevano schiarimenti sul fatto, che si voleva pubblicare. Io però non volli dargli importanza, nè [245] risposi ad alcuno, per non dar dispiacere ai miei amici della Nurra. Temevo anche di pregiudicare i tre pastori, che in fondo erano buona gente. Essi avevano ceduto ad un’allucinazione momentanea, e mi confessarono d’esser stati trascinati a quell’eccesso, senza ponderarne le conseguenze.
L’anno seguente — all’apertura del nuovo esercizio della miniera — si presentò un operaio all’ovile di Peppe Sechi, in Palmadola, chiedendo ospitalità per la notte.
— Non mi conosce?
— Io no: chi sei?
— Sono uno dei due operai derubati, a cui Giovanni Tolu fece restituire il danaro.
— Mi fa piacere. Passa pure la notte nel mio ovile, e cena co’ miei uomini.
Quando Sechi, all’indomani, mi riferì le parole dell’operaio, gli risposi:
— Mi dispiace che si meni tanto rumore di un fatto, che potrebbe mettere in mala vista i poveri pastori della Nurra. Ladri di pecore e di porci, forse sì! — ma ladri di danaro, no certo!
[246]
Fu ben numerosa la schiera dei curiosi, che, in ogni tempo, vollero conoscermi da vicino. La fama delle mie gesta, de’ miei scontri coi carabinieri, e di non so quante altre avventure bizzarre (in gran parte fantastiche ed esagerate) mi sottoponeva ad un continuo esame, che molte volte m’irritava. Tutti si rivolgevano ai miei intimi amici per ottenere il favore di parlarmi, di ascoltarmi, e sovratutto di vedermi tirare al bersaglio.
Superfluo dirvi, che il ceto dei signori era in numero preponderante. Militari alti locati, alti magistrati, negozianti, giornalisti, signori d’ogni genere, sentivano più o meno il bisogno di rivolgere la parola al bandito di Monte fenosu, all’uccisore di tanti nemici, al benefattore della Nurra.
Antonio Giuseppe Zara, d’ordinario, era l’uomo più ricercato per ottenere da me una intervista, come oggi si dice con parola di moda.
[247]
Essendo egli mio compaesano ed intimo amico, a lui si ricorreva, come a colui che conosceva il rifugio del tigre benefico, o la parola d’ordine che doveva strappare dalla tana la belva addomesticata
Contandosi a centinaia i miei incontri coi curiosi, mi limiterò a riferire i pochi che mi vengono alla memoria.
Devo anzitutto dichiarare in coscienza, che la fama di non essere un ladro, nè un sicario, fu quella che mi attirò maggior numero di simpatie. Ond’è, che io tenevo a questa stima, la quale forse non fu estranea a farmi perdurare nel proposito di dar la caccia al malandrini, in favore dei deboli e degli onesti[35].
I più smaniosi di vedermi furono sempre i continentali, e non solamente quelli residenti in Sardegna. A Frosinone ed a Roma, per esempio, fui assalito dai curiosi; e basti dire, che in quest’ultima città dovetti cedere alle insistenze del mio avvocato, il quale volle presentarmi ad un pezzo grosso del Ministero di Grazia e Giustizia. Costui aveva esternato il desiderio di vedermi da vicino, supponendo forse che io avessi gli occhi di lince e il muso d’una jena.
[248]
***
Un distinto pittore di Sassari, che desiderava ardentemente di conoscermi, si rivolse al solito Zara per un’intervista. Accondiscesi alle preghiere dell’amico, e gli diedi appuntamento alla Valle della noce, nelle vicinanze di Campomela.
Il pittore venne in compagnia di altri curiosi, portando seco una grande quantità di viveri, di polvere e di palle — solito regalo che d’ordinario mi facevano i visitatori.
Per dar gusto a costoro, prendevo sempre parte alle partite di caccia; ed essi si divertivano un mondo, nel vedere che le lepri e le pernici non sfuggivano al mio tiro. Era mio costume, in simili partite, di regalare ai cacciatori la selvaggina che prendevo.
Non devo qui tacere, che anche fra quei cacciatori non mancavano gli scrocconi. Col pretesto di vedermi e di conoscermi, essi tornavano a casa colle bisaccie piene di cacciagione, mentre io qualche volta ci rimettevo la polvere e la fatica. Volendo lor dare una lezione, mi appigliai al partito di regalare al solo Zara le lepri e le pernici, facendo capire che non ero tanto gonzo. Si noti che in simili caccie io giunsi a prendere persino una trentina di pezzi, facendo altrettanti spari. La polvere era preziosa, nè volevo sprecarne nemmeno una carica.
[249]
***
Un giorno, nella Nurra, fu concertata una partita di caccia grossa, a cui vollero ch’io prendessi parte. Assegnatami una posta insieme ad un altro signore, volle il caso che un enorme cinghiale passasse a me dinanzi. Lo puntai e l’uccisi.
Tutti i cacciatori corsero sul luogo, gridando:
— Chi lo ha ucciso?
— Questo signore! — risposi con finta mortificazione.
Il signore tacque, ma sottomano mi regalò dieci lire, tenendosi una gloria, che volentieri gli cedetti. Mi era stato dato a compagno, e volevo fargli fare una bella figura. Non paleso il suo nome, perchè ancor oggi egli si dà vanto di quel tiro, che mi fruttò due scudi.
***
Venuto per diporto in Sardegna uno dei fratelli Rocca (banchieri genovesi) fu concertata una caccia alla Nurra da diversi signori di Sassari. Il banchiere volle conoscermi e mi pregò di narrargli alcuni episodi della mia vita. Convintosi ch’ero un disgraziato, più che un malfattore, mi propose di prendermi seco sulla sua nave, per farmi sbarcare in terra straniera, dove sarei tornato [250] libero. Rifiutai recisamente la generosa offerta, dicendogli:
— Che mi vale la libertà, quando mi allontana dalla mia figliuola e dai luoghi che mi videro nascere? Non tarderei a morirne di crepacuore. Meglio, dunque, che affronti il mio destino!
***
Altra simile proposta mi era stata fatta da parecchi viaggiatori continentali, poco prima dell’annessione delle due Sicilie all’Italia. Mi si voleva condurre a Napoli, e di là in Grecia. Il pensiero della mia bambina (che da un anno appena avevo strappato alla madre) mi consigliò a respingere la libertà, che mi si voleva concedere fuori dell’isola mia.
***
Mentre mi trovavo a Sassari, in salvacondotto, fui chiamato un giorno dagli ingegneri inglesi, incaricati dello studio delle strade ferrate nell’isola.
Recatomi nel loro ufficio (posto allora nella casa Crispo) vollero consultarmi a proposito del tracciamento:
— Siccome vi sappiamo pratico dei luoghi, che per molti anni avete battuto, noi chiediamo [251] il vostro parere sulla strada più comoda e più breve per andare a San Michele. Diteci qual via scegliereste: quella che passa per i bagni di San Martino — quella che va per il Piano di coloru — o quella che prende la vallata di N. S. di Saccargia?
Risposi agli inglesi, senza punto esitare:
— Per San Martino avreste molte aperture da praticare e molti rialzi da formare. Per la Valle della Trinità dovreste costruire una galleria molto lunga. Io, dunque, sceglierei il Piano di coloru, poichè il terreno è meno accidentato e più comodo per la linea.
Seppi più tardi che fu scelta la linea da me suggerita. La cosa era chiara: le strade battute dai banditi sono quelle più costose nel tracciamento d’una ferrovia.
In compenso del parere dato, gli inglesi mi offrirono una ricca fiaschetta da polvere ed una rivoltella, che rifiutai[36].
***
Un’altra volta, trovandomi in Sassari (sempre in virtù di salvacondotto) l’amico Zara mi prevenne, che doveva condurre alcuni inglesi in [252] campagna, per visitare un nuraghe. Avendone poco prima veduto uno in sughero ad un’Esposizione, essi volevano esaminarlo al naturale.
Desiderosi di conoscermi, montai con loro in carrozza, e lungo il viaggio diedi spiegazione su molte località della Sardegna. Fra essi erano due signore, a cui regalai diverse monete antiche, da me trovate nella Nurra. Mi pregarono di mandargliene altre in Anversa, dov’erano domiciliati.
***
Taccio molti altri incontri di simil genere, perchè tutti si rassomigliano.
Tanto nelle vicinanze di Florinas durante il primo periodo, quanto nelle terre della Nurra quando la prescelsi a mia stabile dimora, non mi mancarono mai le visite dei curiosi, appartenenti ad ogni ceto. Ho notato altra volta il piacere che provavano le dame e i cavalieri dei villaggi, quando andavo a visitarli in campagna.
In seguito. — dopo la mia assoluzione — cominciarono a piovere le interviste dei redattori delle gazzette; i quali (come accennerò a suo tempo) non riuscirono a strapparmi che confessioni monche, che alteravano sconciamente.
[253]
Nel primo anno di lavoro, a Lèccari, si ebbe in generale un buon raccolto, poichè il grano aveva reso dell’uno dodici, e si stava bene.
In quel tempo mio fratello Giomaria aveva bisogno di essere aiutato nell’agricoltura; e sebbene mi fosse debitore di un centinaio di scudi, ordinai a’ miei figliuoli di prestargli sette rasieri di grano, senza interesse. Venuta la stagione del nuovo raccolto, era sorta contestazione a proposito di questo prestito; e mio fratello, un po’ irritato, osò rispondere a mia figlia, ch’era pronto a restituirle il grano, purchè avesse affermato la sua pretesa con un giuramento dinanzi al pretore. Maria Antonia, rifuggendo da una pubblicità scandalosa, preferì rinunziare a una parte del suo credito.
Questo incidente provocò malumori in famiglia. Quando l’appresi mi spiacque, e ne mossi aspra lagnanza a Giomaria.
Pur scorrazzando da un punto all’altro della Nurra, non trascurai di visitare i miei figliuoli; [254] e se avevo urgente bisogno di conferire con essi, davo loro un appuntamento in uno dei soliti punti designati.
I malumori continuarono. Da qualche tempo mia cognata — per istigazione dei parenti lontani — andava brontolando con dispetto ch’era stanca della Nurra, e che aveva in animo di stabilirsi a Portotorres. Avendo una figlia da marito, preferiva un centro popoloso ai luoghi deserti, dove non capitava mai un cane. Giomaria, che subiva l’influenza della moglie, volendo appagarla, si era dato alla ricerca di una casa in Portotorres, e di terreni in vicinanza.
Nati nuovi diverbî alla mia presenza, un bel giorno dissi con durezza a Giomaria, che il rimedio più spiccio sarebbe stato quello della separazione delle due famiglie.
Le cose per un po’ di tempo furono messe sul tacere, ma i bronci si allungarono.
Nei tre anni di vita comune, che si erano succeduti con alterna vicenda, il dissidio non era mai mancato. In ogni nonnulla si cercava un appiglio. Ne noterò alcuni per non tediare il lettore.
Venni un giorno a sapere, che le due famiglie di Agostino e di Giomaria solevano fare il pranzo in comune — meno il pane, che ciascuna in proporzione forniva a parte. Questo sistema non mi andava a genio. Io desiderava che anche le mense fossero separate, poichè se un mio amico [255] capitava nella cascina, volevo che mangiasse a spese mie, non a spese degli altri. Così pure non mi garbava, che gli amici di Giomaria fossero lautamente trattati col mio danaro. Sono numerosi gli ospiti che capitano a Lèccari, ed è nostro dovere di offrir loro buoni cibi, e non le fave ed il lardo, che mangiamo noi. Non volevo dare il minimo pretesto a nuovi screzi e a malumori nuovi.
Giomaria aveva un cognato (marito della sorella di mia moglie) il quale faceva il vignataro nelle campagne di Sassari, campando miseramente colla famiglia. Capitato un giorno da lui e udite le sue lagnanze, lo invitai a stabilirsi a Lèccari, dove gli avrei fornito buoi, casa, terra e semente, lasciandogli la metà dei guadagni. Venne egli infatti con tutta la famiglia alla Nurra, e Giomaria mi fu grato.
Le cose andarono bene per un po’ di tempo; ma nata questione fra le donne, per certi pomidoro che i nuovi arrivati si permettevano di regalare agli antichi loro padroni di Sassari, dovetti intervenire per mandarli via.
— Se tu li licenzi, ce ne andremo anche noi! — uscì a dirmi Giomaria, di mala grazia.
— Io non ho parlato che de’ tuoi cognati — risposi pacatamente — tu però sei padrone di fare quello che ti piace!
Giomaria, senz’altro, mi restituì i buoi che gli avevo prestato, e se ne andò a vivere altrove [256] insieme alla famiglia ed ai cognati. Io e mio genero tenemmo le terre di Lèccari, che quell’anno avevamo seminato a granone.
Essendo le tanche di mio fratello e dei cognati vicine alle nostre, avveniva che il loro bestiame venisse assai spesso a far danno al nostro seminerio. Me ne dolsi vivamente, e se ne dolse anche Agostino; ma le nostre doglianze si perdevano nell’aria. I buoi, persino in numero di dodici, continuavano a danneggiare il nostro granone.
Perduta alfine la pazienza, e veduto che il brutto giuoco assumeva la parvenza di un dispetto, una mattina feci denunziare il bestiame in contravvenzione; e mio fratello e i cognati furono costretti a pagare la multa d’una ventina di scudi.
Questo fatto finì per farci guastare con Giomaria, nonchè coi cognati; i quali per molti anni ci trattarono sul tirato — ora con una benevolenza pelosa come le mani di Esaù, ed ora con un muso lungo come la scala di Giacobbe.
Io narro queste minuzie, unicamente per dimostrarvi quanto poco duratura sia la pace domestica, sempre quando sotto un medesimo tetto si raccolgono più donne di diversa famiglia. Come nella torre di Babele, si finisce sempre per non intendersi, e i contendenti hanno bisogno di separarsi, per metter casa a parte. I capi di famiglia, istigati dalle proprie donne, che li menano [257] per il naso, non tardano a cedere alle gonnelle. E grazia, quando questi futili appigli non vengono risolti con le coltellate!
***
Rimasto solo a Lèccari, Agostino si trovò in condizione di potersi dedicare al lavoro, disponendo di quattro paia di buoi, di due servi fissi, e di quattro o cinque uomini a giornata, a seconda le esigenze del seminerio. Venuto il tempo della messe, egli salariava un numero di lavoratori, adeguato all’entità del raccolto. Per venti rasieri, per esempio, abbisognavano 25 uomini per otto giorni. Se poi il seminerio toccava i trenta rasieri, le persone da impiegarsi erano una quarantina.
I nostri affari andavano abbastanza bene, e non risparmiavamo mezzi per far progredire in tutti i modi l’agricoltura.
Una volta ebbi bisogno di 2000 lire, e le ottenni facilmente da un istituto di Sassari, per mezzo d’una cambiale firmata da Zara, con avallo di un ricco proprietario di bestiame. La pagai intieramente, con diminuzioni trimestrali.
Eravamo da una diecina d’anni a Lèccari, quando mi venne l’idea di tentare la trebbiatura per mezzo della nuova macchina di Maurizio Pintus; e si ottenne un risultato soddisfacente. Da ogni parte della Nurra erano accorsi uomini [258] e donne, curiosi di veder funzionare la trebbiatrice a vapore, da loro mai veduta. Fu una vera festa campestre. In soli quattro giorni si trebbiarono 330 rasieri di grano, 100 rasieri d’orzo, e 20 di fave.
Fu quello un anno miracoloso. Le spese nostre, fra trebbiatura e fitto delle terre, si calcolarono dai 60 ai 70 rasieri di grano — il rimanente fu tutto guadagno.
Appunto in quell’annata abbondante, io volli dare alcuni consigli ad Agostino; il quale, debbo dichiararlo, peccava assai d’imprevidenza.
— Sai tu, che cosa devi fare? Vendere cinque cavalli e tre paia di buoi. Con due paia di buoi e coi tre cavalli, che a te resterebbero, ne avresti a sufficienza per tirare innanzi l’azienda. Dovresti parimenti ridurre in danaro tutto il grano che hai raccolto, lasciando in casa la sola quantità necessaria per il seminerio e per la provvista del pane. Fa soldi di tutto e compra altre terre, Agostino; poichè queste non ti verranno portate via dal vento, nè da nessuno; e così riuscirai a risparmiare il fitto gravoso, che paghi per i terreni.
— Non è questa la mia idea! Io penso invece a continuare il seminerio in larga scala. — rispose Agostino, stringendosi nelle spalle, senza riflettere che a me doveva la sua posizione.
— Il giorno che riuscirai a far grano in questi terreni, mi lascierò tagliare il collo! — soggiunsi — Possibile che tu non veda, che le [259] terre nostre sono ormai disfatte ed esauste per il continuo seminerio degli stessi cereali? Esse ti saranno ingrate, e ti niegheranno il frutto. È nei tempi di abbondanza che noi dobbiamo pensare ai tempi calamitosi. Tristo colui, che non trae ammaestramento dalle sette spighe piene e dalle sette spighe vuote, di cui parla la sacra scrittura!
Agostino tornò ad alzare le spalle con noncuranza, e tacque per non provocare spiacevoli discussioni. Egli non volle tener conto del mio consiglio, e gli tenni il broncio per un po’ di tempo. Vedremo com’egli avesse torto.
***
I miei figliuoli continuarono ad abitare il tenimento di Lèccari, come l’abitiamo anche oggi, dopo avervi lavorato per quasi trent’anni.
La cascina è vasta, elegante e comoda, poichè si compone di una quindicina di ambienti: cinque a pianterreno e cinque al piano superiore; senza contare le altre casette annesse, con forno, pollaio, pagliaio, un cortile chiuso, un piccolo vigneto e giardino interno. L’estensione del terreno circostante è di circa 40 ettari, di cui 8 seminabili, e 32 occupati dalla peschiera.
La famiglia intanto si era accresciuta. Dopo il primo anno di matrimonio, Maria Antonia ebbe una figlia; e in seguito, in media, un bambino ogni due anni.
[260]
Io mi recavo ogni tanto a Lèccari a visitare i miei figliuoli e i miei nipotini, ma con molta prudenza; poichè i carabinieri vi piombavano ogni tre o cinque mesi, sempre colla speranza di cogliermi.

D’ordinario essi si presentavano, alla cascina chiedendo da mangiare e da bere; ma la mia figliuola non volle mai soccorrerli, neppure in omaggio a quella ospitalità, che nella Nurra non viene mai negata ad alcuno.
— Io non posso offrire viveri a chi viene per arrestare mio padre! — essa rispondeva.
La visita d’ispezione si praticava dai carabinieri in moltissimi stazzi della Nurra, specialmente per cercar me, condannato alla morte dalla Corte d’Assise di Sassari.
In un giorno di Pasqua d’aprile, otto carabinieri si presentarono a Maria Antonia, chiedendo un capretto.
[261]
— Ce ne ho, ma da me non ne avrete. Cercate pure e frugate da per tutto, com’è il vostro dovere, ma andate a mangiare altrove.
— E zio Giovanni lo mangerà, oggi, il capretto di Pasqua?
— Zio Giovanni lo mangerà di certo... ma non qui!
— Davvero?... vogliamo accertarcene.
— Visitate pure tutte le camere. Se foste sicuri che mio padre si trovasse in casa, certo non vi fidereste ad affrontarlo in tal modo.
I carabinieri fecero la perquisizione, e se ne andarono. Avevano forse sperato, che in un giorno così solenne io non dovessi mancare alla mensa di famiglia.
Quel giorno invece, mi trovavo lontano da Lèccari, perchè avevo preveduto la visita sgradita. Ero stato a visitare la mia famiglia tre giorni innanzi, a notte inoltrata, per regalare ai nipotini l’agnello bianco. I miei figliuoli, in precedenza, mi avevano preparato il pranzetto pasquale, che avevo portato meco sulla montagna, per godermelo tutto solo, facendo un brindisi alla salute dei cari assenti.
[262]
Si era verso la metà di settembre del 1880 — precisamente l’anno del miracoloso raccolto, da me altrove menzionato.
Contavo 57 anni Non ero vecchio; ma la vita randagia, durata per trent’anni, mi aveva ormai stancato, sfinito. Il mangiar male e senza alcuna regola; il dormire all’aria aperta, sfidando uragani e intemperie; il saltare continuamente roccie e macchioni; l’ansia continua per il timore di un agguato; il tendere continuamente l’orecchio ed aguzzar l’occhio ad ogni rumore e ad ogni ombra — tutto ciò mi spossava il corpo e lo spirito. Mi accorgevo già, che la vista e l’udito mi s’indebolivano. Guai a me se non avessi avuto mia figlia!
Ero da dodici giorni sofferente per una leggera slogatura al braccio sinistro, dovuta ad un salto da me fatto fra due macigni, in una notte buia.
Mi recai da mia figlia all’indomani della lussazione, e pregai mio genero che si recasse subito [263] a Sassari per comprare tre o quattro oncie di aceto di Saturno. Fattemi alcune fregagioni alla parte malata, agli otto giorni ero guarito.
Mi trattenni nondimeno ancora a Lèccari, dormendo però all’aperto, e facendomi portare il vitto in campagna dalla mia figliuola.
Durante quel tempo, per ammazzare la noia, mi ero dato a rileggere il Codice penale, fermando l’attenzione su alcuni articoli che mi riguardavano. Avevo notato con piacere: che per i delitti da me commessi era ormai prescritta l’azione penale; che una diminuzione di pena veniva concessa ad un colpevole, se questo avesse dato prove di buona condotta per un certo numero d’anni; e che, infine, un bandito, dopo trent’anni di espiazione volontaria, poteva tornarsene a casa, senza essere molestato dai carabinieri[37].
Essendomi dato alla macchia il 27 dicembre 1850, avevo dunque battuto la campagna per 29 anni e circa 9 mesi.
Durante quei giorni di sofferenza al braccio — e volendo pur soddisfare ad un impegno preso, come dirò in seguito — mi ero avvicinato con troppa frequenza alla cascina. Qualche tristo, certamente, mi aveva veduto; e costui non poteva essere che Giuseppe Fraizzu, il quale meditava [264] da tempo una vendetta, sì per il bue nero da me fatto restituire ai banaresi, come per l’umiliazione subita nanti il pretore d’Ossi.
Ruminando nel mio cervello, non vedevo altri che lui, capace di denunziarmi ai carabinieri di Sassari, per potermi cogliere nel mio nido.
Nei giorni che a Lèccari si eseguiva la trebbiatura del nostro grano colla macchina di Maurizio Pintus, questi venne alla Nurra. Egli si era rivolto a me, pregandomi di favorirgli una quantità di buda (canne palustri) per cuoprire alcune sue capanne, costrutte di recente verso Campomela. Pintus era un uomo generoso, e mi si mostrava riconoscente per la sorveglianza che io esercitava sul molto bestiame, che teneva a pascolo nelle sue terre della Nurra.
Lieto di fargli un piacere, promisi a Maurizio Pintus di mandargliene due carri sul luogo.
Un giorno — era il 22 di settembre 1880 — verso le tre dopo mezzanotte, aiutato da mio genero, caricammo due carri di buda, che una settimana prima avevamo accuratamente tagliata, a cinquanta passi dalla cascina.
Agostino, in compagnia di un nostro servo, si mosse dalla Nurra per condurre i due carri a Campomela.
Verso le sette di mattina, dello stesso giorno, vidi una pecora sbandata, che si dava alla fuga; e diedi ordine ad un ragazzo che me la portasse per esaminarla. In agosto le zecche tormentano [265] le pecore; ed infatti glie ne trovai una, che le aveva bucato la pelle.
In quel momento di distrazione, mi lasciai forse scorgere dalla spia, o dai carabinieri appiattati nelle vicinanze.
Estratto il verme dalla piaga, posi la pecora in libertà; ed io m’internai, come al solito, nel folto delle canne palustri, per nascondermi durante il giorno.
Forse i carabinieri, appiattati, aspettavano che venissi loro a tiro, per farmi fuoco addosso. L’appiattamento era stato disposto alla Murella maestra, lungo il tratto che divide la Pischina dal fiume, donde ero stato veduto.
Non sospettando di nulla, ero rimasto per quattr’ore fra le bude.
Verso le 11 venni fuori con precauzione dal canneto, ed entrai prestamente in casa per mangiare un boccone.
Trovai il desinare, già preparato da mia figlia, sulla tavola della sala centrale. Ivi mangiai, in piedi, armato come sempre di fucile, di pistola e di stile.
Nella palazzina (composta di dieci ambienti) non c’era altri che mia figlia e i suoi tre bambini. Mio genero era in viaggio coi carri di buda, e la serva era al fiume per lavare.
Ero solo nella sala terrena.
Finito ch’ebbi di pranzare, mi feci all’uscio; indi mi spinsi fino all’angolo della casetta del [266] forno, per esplorare in basso, verso la Murella. Ivi scorsi molti carabinieri sparpagliati, che venivano avanti, in direzione della cascina.
Indovinai tutto, e non pensai che a mia figlia, allora incinta grossa. Per evitarle uno spavento, che poteva riuscirle fatale, rientrai in casa, e mi diedi a cercarla di camera in camera. La trovai finalmente nel cortile interno, insieme ai bambini.
— Figlia mia! — gridai concitato — fa coraggio e non spaventarti: ci sono i carabinieri!
Così dicendo mi slanciai fuori della cascina, dalla parte di ponente; voltai a sinistra, e mi diressi correndo verso il canneto, distante un cinquanta passi.
Il tempo impiegato alla ricerca di mia figlia mi aveva perduto. Mi era impossibile raggiungere la palude, perchè 14 carabinieri stavano a trenta passi da me.
Pur continuando a correre, spianai prontamente il fucile ed armai i due grilletti, deciso di ucciderne almeno due.
Mi fermai quindi di botto, mentre gli armati continuavano ad avanzare, un po’ sconcertati, nè certo di buon animo!
Se essi in quel momento non furono i primi a farmi fuoco, fu certo perchè una quindicina di agricoltori, che lavoravano la terra a poca distanza, sarebbero stati testimoni di un’infrazione ai regolamenti militari.
— Metti il fucile a terra! — mi gridò il [267] maresciallo, alla distanza di una quindicina di passi.
Per un’istantanea decisione — frutto di mille ragionamenti fatti in un attimo — deposi il fucile a’ miei piedi, poi la pistola e lo stile, e mi rizzai con fierezza, guardando in faccia il carabiniere comandante.
In quei due o tre minuti di corsa affannosa, (dalla casa del forno al cortile interno, e dal cortile alla discesa della palude) molte idee m’erano balenate alla mente.
Anzitutto ricordai la ragguardevole quantità di grano depositato nella cascina, che rappresentava la nostra fortuna; e questo pensiero mi distolse dallo sprangare la porta, chiudermi dentro casa, ed opporre viva resistenza alla forza di quattordici carabinieri, che avrei combattuto dalle piccole finestre ovali del piano superiore. Oltre alle armi che portavo addosso, avevo in casa cinque fucili, due pistole e due rivoltelle. Dirò ancora, che in un ripostiglio, ignorato dalla famiglia, tenevo in custodia, insieme a molta polvere, venti grosse cariche di dinamite, che avrei potuto gettare dalle finestre, per far pagar cara l’audacia a’ miei assalitori.
Mi bastava l’animo di tradurre in atto il mio disegno; ma... e poi? Si sarebbe finito per incendiare la cascina, bruciando tutta la nostra fortuna: circa 3000 scudi.
Poco male anche questo; ma... e la mia figliuola? [268] i miei nipotini? E i 29 anni e 9 mesi di buona condotta, che avrebbero potuto rendere più benigni i miei giudici?
Tutto questo in un attimo ho pensato. Certo è, che se il destino non mi avesse spinto sulla traccia di mia figlia, io mi sarei lanciato ad occhi chiusi fra le canne della palude — o per salvarmi come a Monte rasu e a Monte fenosu, o per morire fulminato dalle palle di quattordici carabinieri.
Rimasi là come pietrificato, coll’occhio sempre fisso sui carabinieri, e le due braccia tese in avanti: quasi implorando che me le legassero subito, prima che mi pentissi d’una docilità in me insolita ed umiliante.
Quattro carabinieri si erano intanto avanzati a grandi passi, per legarmi le braccia e i polsi con catene. Come alzai gli occhi, vidi il maresciallo che mi puntava il fucile a dieci passi di distanza.
Il sangue mi salì alla testa, e gli gridai con fierezza:
— Fa mettere quante catene vuoi; ma togli il fucile dalla faccia, chè non sai ancora portarlo in mano!
Il maresciallo abbassò subito l’arma[38].
[269]
Non ero del tutto legato, quando la mia figliuola venne fuori dalla cascina e corse a me, dando in ismanie. Le gridai con dolcezza:
— Non piangere, Maria Antonia, chè non è nulla! Toglimi il portafoglio da tasca, e gli altri oggetti dalle bisaccie.
La mia figliuola, sempre piangendo, mi alleggerì di ogni cosa, salvo del portafoglio, che volle io tenessi. Conteneva da sette ad otto scudi in biglietti di banca.
Com’ebbero finito di legarmi, i carabinieri si diedero a bere dalle fiaschette, che portavano addosso.
Il maresciallo, dopo aver bevuto, porse a me gentilmente la fiaschetta.
— Grazie — risposi — Non sono uomo di troppo vino, io! Ho già mangiato... ed anche bevuto!
Dopo aver salutato la mia figliuola, che lagrimava [270] sempre, m’incamminai, scortato dai 14 carabinieri.
Fatti un centinaio di passi, i carabinieri si lamentarono di aver le fiaschette vuote.
Mi rivolsi ad uno di essi:
— Va a casa, e fa riempire il tuo fiasco dalla mia figliuola. Dille che voglio bere anch’io.
Pregai in seguito il maresciallo, perchè mandasse un carabiniere da mia figlia per farmi dare un fazzoletto; ma non mi venne concesso, come per il vino! Esternai pure il desiderio di venir portato a Portotorres, per esser di là tradotto a Sassari col treno, pagando io i biglietti; ma mi si rispose, che i regolamenti lo vietavano.
***
Era circa mezzogiorno; il sole scottava, ed io grondavo sudore. Il maresciallo mi offrì il suo fazzoletto, che accettai volontieri, perchè ne avevo bisogno.
Prendemmo il sentiero della Crucca, e poi si camminò lungo lo stradone, in mezzo ad un nugolo di polvere che mi soffocava.
Quando eravamo ad un’ora da Sassari, vennero staccati due carabinieri, che si mossero al trotto per dar l’avviso in caserma.
Impiegammo circa quattro ore ad arrivare alle porte della città.
I due carabinieri, che ci avevano preceduto, [271] si erano affrettati a dar la notizia del mio arresto. Lungo lo stradone, e sui muri di cinta delle vigne, accorreva la gente a frotte per vedermi.
Nel largo di Porta Sant’Antonio era sì fitta la calca, che a stento ci riuscì ad aprici un passaggio. Da destra e da sinistra mi si gridava dai popolani:
— Coraggio, zio Giovanni! non sarà niente! Due mesi, e a casa!
I carabinieri, imbronciati, lanciavano torve occhiate ai malaugurati profeti.
Erano le 4 pomeridiane.
Condotto alla caserma dei carabinieri, venni messo in camera di sicurezza. Diedi subito una lira ad un servo, perchè mi comprasse un fazzoletto, non volendo più servirmi di quello del maresciallo.
La sera stessa venni tradotto alle carceri nuove, dinanzi alle quali faceva ressa una folla enorme.
Mi cacciarono subito in una cella poco spaziosa.
Ero stanco del lungo viaggio a piedi, ma mi sentivo l’animo tranquillo.
Poco dopo l’imbrunire, non sapendo cosa fare, mi cacciai addirittura fra le coltri.
Era la prima volta, dopo trent’anni, che mi spogliavo per andare a letto!
[273]
A questo punto tolgo la parola a Giovanni Tolu, per prenderla io. Coll’arresto a Lèccari si è chiusa la storia del bandito.
Il vecchio florinese continuò a narrarmi minuziosamente gli episodi della sua vita in carcere; le fasi del processo e del dibattimento; il suo ritorno alla Nurra; le peripezie domestiche e i suoi contrasti in famiglia. Io mi limiterò a riassumere gli avvenimenti principali, non volendo tirare più in lungo la narrazione con particolari insignificanti. Ripeto solo, che ho sempre riportato fedelmente quanto Giovanni Tolu mi espose, senza nulla aggiungere, nè togliere. Trattandosi di una storia contemporanea dettata dal protagonista, il romanziere non poteva in coscienza permettersi la minima alterazione, senza compromettere la verità.
[276]
Pur riassumendo i fatti, riporterò qua e là le parole del bandito, quando le crederò necessarie all’efficacia della narrazione.
***
«— Entrato in carcere — continuò Tolu, stuzzicando il tabacco nella pipa — i guardiani mi costrinsero a cambiar d’abiti. Diedi un’occhiata alla mia persona, e mi venne da ridere; poichè mi parve di trovarmi nelle stesse condizioni di Bertoldo, dinanzi al re Alboino: nè nudo, nè vestito. Al terzo giorno venni condotto nel parlatorio, dove mi aspettava il giudice istruttore.
«Appena mi vide, mi disse:
«— Hai un bel ceffo!
«— Perchè? forse perchè mi vede in questi panni? Ella dovrebbe capire, che non sono tagliati a misura.
«Il giudice si fece allora serio, e cominciò l’interrogatorio, chiedendomi soltanto i particolari sull’attacco di Nuzzi e di Monte Rasu.»
***
Giovanni Tolu continuò a narrarmi i particolari della sua vita di carcerato, che io ometto.
Le prime pratiche furono fatte per una cella [277] separata, a pagamento, che gli venne subito concessa. Avendo pure ottenuto che l’amico Zara gli mandasse ogni giorno il pranzo da casa, egli voleva che si passasse la sua zuppa ad un carcerato vicino, col quale si era messo in relazione. Ciò niegatogli, dispose che fosse data ai poveri.
Il contegno di Giovanni Tolu in carcere (secondo la sua confessione) non era stato troppo edificante. Egli perdeva facilmente la pazienza, s’irritava per ogni nonnulla, ed ebbe più volte aspre parole coi carcerieri e con qualche detenuto. Lo star chiuso da mattina a sera in una cella angusta, priva d’aria e di sole, non poteva certo confacersi ad un uomo, abituato da trenta anni a battere la campagna sterminata, sotto l’immensa volta del cielo.
***
Non appena corsa la voce dell’arresto, si era manifestata nel popolo una corrente simpatica, favorevole a Giovanni Tolu. La lunga serie d’anni trascorsi aveva gettato un velo pietoso sulle colpe giovanili del bandito florinese, e più non si volevano ricordare che le azioni generose, compiute durante l’ultimo ventennio. Il popolo entusiasta esaltava le virtù dell’arrestato; le vicende della sua vita leggendaria furono per molti giorni l’argomento di tutte le conversazioni, di tutti i discorsi; e l’autorità giudiziaria [278] se ne impressionava, prevedendo l’influenza che avrebbe esercitato quella simpatia sull’animo dei giurati.
Fu dunque creduto cosa prudente togliere Giovanni Tolu ai suoi Giudici naturali, per rinviarlo ad altra Corte d’Assise dell’isola.
Il 9 luglio 1881 la Corte di Cassazione di Roma dichiarò prescritti quattro processi; revocò la sentenza contumaciale di morte del 1869; e per i reati di Nuzzi e di Monte Rasu rinviò Giovanni Tolu alle Assise di Oristano.
Prima di lasciare le carceri di Sassari, il cappellano si presentò a Tolu, chiedendogli se volesse confessarsi, in occasione del Giubileo.
— Non sono disposto! — rispose secco l’ex bandito.
Dopo un anno e tre mesi d’ingrato soggiorno nelle carceri di Sassari, Giovanni Tolu fu trasferito a quelle di Oristano, il 9 gennaio del 1882.
***
Il bandito mi dichiarò, che nelle carceri di Oristano fu trattato più umanamente, e si sentì più tranquillo. Egli fece amicizia coi bambini del direttore, e passava con essi ore deliziose, parendogli di trattenersi co’ suoi nipotini.
Nel giorno di Pasqua un amico gli mandò una caraffa di vernaccia ed un piatto di lunghe [279] frittelle alla sarda. Tolu chiamò la bambina del direttore; le adattò al collo un pezzo di frittella a mo’ di collana, e le disse:
— Va dal babbo, e pronuncia queste parole in nome mio: «— Come facilmente si spezza la mia collana, così fra poco si spezzeranno le catene di Giovanni Tolu!»
Anche ad Oristano si era presentato in carcere un frate dalla lunga barba, che aveva domandato a Tolu se intendeva confessarsi.
— Non sono disposto! — rispose il bandito.
— Perchè?
— Perchè io mi confesso quando a me piace: quando la coscienza me lo suggerisce. La legge di Cristo non m’insegna altro!
— Che ne sai tu?
— Sono stato sagrestano, reverendo!
Il frate se ne andò borbottando. Appena uscito, fu detto al Tolu che era l’arcivescovo.
Avevano annunziato al bandito, che il suo dibattimento si sarebbe tenuto in quelle Assise nei tre giorni dal 14 al 16 giugno. Nuovi incagli, però, nuovi timori, e nuovi scrupoli, consigliarono i giudici a non fidarsi dei giurati d’Oristano, dove si erano manifestate le stesse simpatie in favore del bandito.
Il 29 maggio di quello stesso anno (1882), dopo quattro mesi di detenzione, Giovanni Tolu fu tolto dal carcere di Oristano, per essere trasferito a quello di Cagliari.
[280]
***
Le carceri di Cagliari non gli lasciarono grata impressione. Cominciò dal bisticciarsi coi carabinieri, che lo avevano tradotto alla torre di San Pancrazio, stringendogli le manette in modo inumano.
Chiuso in cella, ebbe più tardi un battibecco a causa dei fornitori del vino e del tabacco, i quali defraudavano i poveri prigionieri. Se ne lamentò col direttore, che finse di dargli un po’ di ragione...
Neppure a Cagliari Giovanni Tolu ebbe il giudizio. Si tornò a tirar fuori la corrente troppo favorevole al detenuto, le simpatie per le azioni generose, le influenze degli avvocati, e simili. Si parlò d’altra Assise.
— Se si continuerà la linea retta, mi manderanno a Tunisi! — disse Tolu al direttore.
Il procuratore del re aveva trasmesso gli atti alla Corte di Cassazione di Roma; e questa designò per il giudizio la Corte d’Assise di Frosinone.
— Ho capito! — fece Tolu — mi si manda da Erode a Pilato. Si finisse almeno col lavarsene le mani![39]
[281]
Nella prima diecina del settembre successivo (dopo altri tre mesi di detenzione) il bandito florinese fu portato alla darsena; lo si gettò nella stiva del piroscafo, e lo si fece sbarcare a Civitavecchia, per poi proseguire fino a Frosinone, nella Romagna, dove le memorie del brigantaggio erano ancora vive.
— Il quarto carcere? — esclamò — Speriamo almeno che sia l’ultimo!
[282]
Tutti i giornali della penisola si occupavano intanto di Giovanni Tolu, chiamandolo brigante, e trovando di lui riscontri nella storia francese e nella napolitana. L’Avvenire di Sardegna rispose con un articolo, conchiudendo: — «Certo è, che dopo Tolu noi avremo il brigantaggio anche in Sardegna; e così entreremo un po’ nella via della civiltà!»
Dopo un mese di detenzione nelle carceri di Frosinone, fu annunziato a Tolu, che il suo dibattimento avrebbe avuto principio il 19 ottobre (1882) e sarebbe durato tre giorni.
Le avventure di Giovanni Tolu ebbero un’eco pietosa anche a Frosinone. Tutti leggevano, con avidità curiosa, uno scritto a stampa, che circolava per la città col titolo: l’ultimo bandito sardo. Lo spirito della popolazione si era subito affermato favorevole all’accusato, e si facevano voti per la sua liberazione. E fu fortuna per i sardi che Giovanni Tolu fosse giudicato fuori dell’isola. [283] Dio sa a quali insolenze sarebbe stata esposta la Sardegna, se i suoi cittadini giurati avessero liberato il brigante di Florinas!
***
Il 19 ottobre 1882, alle ore 9 ant., si apre il dibattimento nella Corte d’Assise.
I testimoni a carico e in difesa, che in origine erano 28, ora sono ridotti a soli 18, poichè dieci morirono.
La folla è immensa; nella sala non mancano le signore.
Giovanni Tolu è accusato:
1. Di ribellione alla giustizia, e dell’omicidio del carabiniere Sassu, commesso la sera del 10 giugno 1853 nel luogo detto Nuzzi, nel territorio d’Osilo, in complicità con Pietro Cambilargiu.
2. Degli omicidi, con ribellione, dei carabinieri Delrio e Catte, commessi la mattina del 21 maggio 1859 nel luogo detto Monte Rasu.
Si fa notare, che Tolu nel 1869 fu condannato in contumacia alla pena di morte, ma che la sentenza fu annullata per difetto di procedura nella notifica di diversi atti.
L’accusato fa il racconto dei fatti, risalendo al prete Pittui.
Le frasi più salienti di Giovanni Tolu, raccolte dai giornalisti, sono le seguenti:
«Mi resi latitante perchè il prete era ricco [284] e prepotente e poteva mandarmi in galera. In Sardegna si manda la gente in galera per piccoli motivi. Non mi arresi alla giustizia, perchè la giustizia non è giusta!»
Il presidente chiede all’accusato:
— Eravate tenuto per un uomo possessore di un talismano, che vi rendeva invulnerabile alle palle dei carabinieri. È vero?
— Lo dicono i vanarelli. (Si ride).
Vengono interrogati i testimoni a carico, la maggior parte dei quali non sono che i carabinieri dello scontro di Nuzzi e Monte Rasu.
Si chiamano in seguito i testimoni a difesa, dei quali riassumo le deposizioni:
Maurizio Pintus dichiara, che, se potè più volte riavere il bestiame rubatogli, lo deve a Giovanni Tolu, il quale faceva a tutti bene. Altra simile dichiarazione fanno Vincenzo Pes e Antonio Beccu, il primo per sette buoi, il secondo per una cavalla, che i ladri avevano loro involati.
Andrea Nuvoli parla della disonesta condotta della moglie di Tolu, dichiarando che costui avrebbe potuto facilmente uccidere il drudo, che ha voluto risparmiare.
Antonio Piu dice, di essere stato minacciato di morte dai propri nemici; ma intromessosi Tolu, questi riuscì ad ottenere una riconciliazione generale, che da quel giorno li fece vivere tranquilli. Conchiude asserendo, che il bandito florinese era il loro giudice di pace; epperciò tutti lo soccorrevano, regalandogli bestiame.
[285]
Sebastiano Branca fa l’apologia dell’accusato, chiamandolo un benefattore; e Antonio Giuseppe Zara conchiude esclamando: — Giovanni Tolu è il Dio della campagna![40]
Si leggono all’udienza i certificati rilasciati dai sindaci, i quali affermano, che Tolu mantenne da oltre vent’anni una condotta esemplare; e che era ritenuto per un uomo di sentimenti nobili e generosi, il quale rendeva segnalati servigi, riuscendo a riconciliare i nemici ed a tutelare l’altrui proprietà[41].
[286]
***
La parola è al pubblico ministero. Egli deplora, che i sindaci e i municipi abbiano rilasciato certificati così larghi di lode. Ammette le azioni generose, ma dice che ogni bandito suol farne; dichiara che Tolu non è un ladro, ma osserva che la frase Dio della campagna è un’esagerazione. Chiede infine una condanna per l’uccisione dei carabinieri.
Parlano in seguito gli avvocati difensori, che sono il Prof. Antonio Piras di Florinas (per il quale Tolu ha una profonda venerazione) e il Cav. Gavino Scano di Cagliari, (oggi Senatore).
Il primo ribatte ad una ad una tutte le accuse. Si scaglia contro il Pubblico Ministero, che ha voluto evocare la memoria dei delitti di Tolu, per alcuni dei quali fu riconosciuta la prescrizione, e per altri fu dichiarato non farsi luogo a procedimento. «È indegno della maestà della Giustizia (egli dice) far rivivere delitti, di cui Tolu non è chiamato a rispondere, e per i quali la stessa Giustizia ha ricacciato la spada nel fodero». Egli dimostra non veritiere le relazioni sui fatti di Nuzzi e di Monte Rasu, pur dicendo: «Io m’inchino all’arma benemerita dei carabinieri: a questi modesti e ignoti eroi, vittime oscure e grandi, che ubbidiscono tacendo, e tacendo muoiono.»
[287]
L’avvocato Scano difende anch’esso valorosamente l’accusato; e conchiude con enfasi: «— Giovanni Tolu è uno sventurato, ma non è un brigante! In Sardegna briganti non ci sono: vi sono banditi, che, come Tolu, lo divennero per aver compiuto una vendetta!»
Sono le otto di sera del 21. I giurati si ritirano per rispondere ai 36 quesiti, formulati dal presidente.
L’ansia è grande e la commozione è profonda nel pubblico.
Alle 10 e mezza i Giurati riprendono i loro seggi, e si dà lettura del verdetto, che ammette la legittima difesa ed assolve l’accusato.
Il pubblico prorompe in applausi, e si riversa sulla piazzetta per acclamare il bandito assolto, che esce trionfante dalla gabbia.
***
Seguìto da una folla di popolani, Giovanni Tolu percorre alcune vie al grido di: viva Tolu! Tutti vogliono vederlo da vicino, e gli offrono da bere.
L’assolto è fuori di sè dalla contentezza. Passando a quell’ora dinanzi ad una chiesa, egli s’inginocchia sui gradini esterni, per ringraziare Iddio che ha parlato al cuore dei giudici. Insieme a Tolu s’inginocchiarono, scoprendosi il capo, i popolani entusiasti.
[288]
Curiosa invero, e caratteristica, quella preghiera in piazza, al chiaror della luna, che splendeva in tutta la sua pienezza! Un testimonio occulare mi assicurava, che giammai avrebbe dimenticato il pio raccoglimento dei popolani di Frosinone, spinti a pregare insieme al bandito, per un sentimento misterioso e inesplicabile.
***
L’indomani Giovanni Tolu partì da Frosinone diretto per Roma, in compagnia del genero Agostino, di Antonio Giuseppe Zara e dei due avvocati.
Volli conoscere l’impressione che la capitale d’Italia aveva prodotto sull’animo di un bandito, vissuto per trent’anni nelle terre deserte della Nurra. Ei mi rispose:
— A Roma c’è troppa gente e troppo rumore. Non m’incantarono i suoi monumenti, poichè son lavoro degli uomini. Anche la Sardegna potrebbe vantarli, se si spendessero centinaia di milioni. Io non m’incanto che dinanzi alle meraviglie della natura, poichè nessun danaro può riprodurle!
[289]
Imbarcatosi a Civitavecchia, il bandito assolto giunge a Terranova. Sparsasi la voce del suo arrivo, una folla curiosa gli va incontro per conoscerlo da vicino.
Montato sul vagone co’ suoi compagni, si mette in viaggio. Alla stazione di Ploaghe lo aspettano un’infinità di parenti, di amici e di altri compaesani, venuti da Florinas per vederlo e salutarlo.
Prosegue per Sassari, dov’era già pervenuta la notizia del suo arrivo. Trova alla stazione gran folla di popolani, ed a stento gli avvocati riescono ad aprirsi un passaggio fra la calca immensa e chiassosa.
Giovanni Tolu si reca alla casetta di Antonio Giuseppe Zara, verso la piazzetta dell’Università. La folla fa ressa alla porta, e le visite sono tante, che non lasciano un momento di tregua al bandito.
Qualche giornale continentale ebbe parole di biasimo per questo ricevimento chiassoso, [290] che fu chiamato entusiastico e indegno di un popolo civile. La censura era ingiusta. Sarebbe stato più ragionevole inveire contro il verdetto della Giuria di Frosinone, anzichè contro il presunto entusiasmo del popolino sardo, che plaudiva al giudizio dato in una città continentale.
D’altra parte, era proprio seria l’invettiva? era essa frutto d’un retto criterio? Bisogna andar cauti nell’apprezzamento del così detto trasporto popolare. Non bisogna mai confondere il vero spirito entusiastico, colla curiosità morbosa e suggestiva, propria delle masse inconscienti. Se invece del bandito assolto, fosse arrivato il bandito condannato, la folla sarebbe accorsa a vederlo con pari curiosità febbrile. Sarò più crudo: se invece dell’arrivo di Giovanni Tolu fosse stato annunziato l’arrivo di un tigre o di un coccodrillo, la calca non sarebbe stata meno curiosa e tumultuante. L’entusiasmo popolare è un sentimento, che, dato un po’ di lievito, può crearsi anche artificiosamente. Esso è morboso, comunicativo, fittizio, e guai a colui che ci crede e se ne fida!
E qui non voglio fermarmi, nè discutere sullo spirito pubblico italiano (non sardo solamente!), il quale è quasi sempre favorevole all’arrestato, all’accusato, ed all’assolto[42].
[291]
***
Rimasto a Sassari per alcuni giorni, Giovanni Tolu si recò a Florinas per salutarvi gli amici e i parenti. Egli volle rivedere alla luce del sole, il suo paesello natìo, che trovò molto cambiato dopo trent’anni di assenza. Di là, finalmente, fece ritorno al suo nido di Lèccari, dove ansiosamente lo aspettavano la figliuola e i nipotini.
Intanto i proprietari della Nurra e dei villaggi vicini (amici e conoscenti di Tolu) fecero a gara per costituire la dote al bandito rimesso in libertà. Ciascuno gli regalò una vitella del valore di dieci a quindici scudi; e Tolu potè raccoglierne una quarantina, fra la Nurra, Ozieri, Florinas, Banari, Mores, Chiaramonti, Martis e Santo Lussurgiu. Questo numero di vitelle, unito a un centinaio di pecore che già possedeva, gli formarono un patrimonio abbastanza rilevante per rimettersi al lavoro.
[292]
L’usanza di soccorrere un assolto, od un reduce da un luogo di pena, è molto antica in Sardegna. Anche Tolu, quando era bandito, offriva qualche pecora, montone, o vitella in soccorso di un disgraziato, o in regalo ad una ragazza povera che andasse a marito.
Questa generosità verso uno scarcerato risolve il problema, tante volte messo in campo, e mal tradotto in atto: mettere un condannato in condizione di non dover ricorrere a un nuovo furto per sostentare la propria famiglia. Oh, quante consuetudini umanitarie fra queste genti barbare, che vivono lontane e dimenticate dai popoli civili!
***
Informatosi subito dell’andamento dell’azienda di Lèccari, Giovanni Tolu dovette ricordare al genero il pronostico fattogli due anni addietro, prima di essere arrestato. Le cose erano tutte andate alla rovescia. I proprietari dei terreni avevano elevato il prezzo dei fitti di oltre 19 rasieri di grano; le terre, stanche ed esauste, non erano state rimuneratrici; e così gran parte del ricco raccolto del 1880 era stato assorbito dalle perdite subite in quei due anni di penuria e d’imprevidenza. E il bandito tornò a metter fuori il sogno di Faraone, colle famose sette vacche grasse.
[293]
Giovanni Tolu era ormai libero; egli viveva tranquillo, senza preoccupazioni di spie e di carabinieri; epperò aveva più tempo ed agio a sorvegliare le faccende proprie e quelle del genero. Con un uomo come Tolu, abituato a comandare e ad essere ubbidito, Agostino poteva brontolare, ma non ribellarsi. E da ciò qualche broncio e qualche dissidio, calmato da Maria Antonia, che s’intrometteva fra padre e marito, con quella furberia pietosa di cui la donna è maestra.
Durante i due anni che Tolu fu in carcere, la cascina di Lèccari era stata frequentata da un suo cognato, resosi debitore verso il genero e la figliuola di una quantità di grano. Il vecchio bandito ebbe aspre parole con costui, e l’attrito giunse a tanto, che dovettero intervenire diversi amici di Portotorres e di Sassari per mettere gli animi in pace.
Ometto tutte le peripezie di questi dissidî, che l’ex bandito mi narrò minutamente, ma che io ho creduto superfluo trascrivere. Riporterò solamente un suo sfogo, che io credo frutto d’irascibilità di carattere, più che di giusto risentimento per torti ricevuti. Egli disse:
— Ebbi dunque a comprovare anche gli effetti dell’ingratitudine altrui; ma io la prevedeva. I figliuoli ed i generi, dimenticando i benefizî da noi ricevuti e i sagrifizî da noi fatti, ci trascurano sempre quando diventiamo vecchi; [294] essi ci rispondono di mala grazia, quando più non hanno bisogno di noi. I vecchi sono sempre messi in disparte. Io ciò vedeva, ma non ero l’uomo da tollerare la voce grossa, nè da lasciarmene imporre da generi e da figliuoli!
***
Giovanni Tolu, nondimeno, amava molto i suoi figliuoli ed i nipotini, quantunque (così mi diceva) non si fosse mai stemperato in quelle tenerezze che davano tanto ai nervi al suo babbo Pietro Gavino.
Egli non lavorava più, perchè si sentiva stanco. Mi confessò, che lo avevano più abbattuto i 25 mesi di prigione, che i 30 anni di banditismo. Si era dato a dar consigli a’ suoi nipotini, coi quali stava sempre. Egli mi disse:
— Non m’immischio più nelle cose dell’azienda per non farmi cattivo sangue. Ognuno ha i suoi sistemi e le sue vedute, nè sempre si può andare d’accordo. Dicono che i vecchi tornano bambini; ed è forse perciò, che io vivo co’ miei piccoli nipoti. Prendo loro la lezione ogni giorno e li costringo a leggere nel primo libro di lettura.
— Ditemi qualche cosa di vostra figlia e di vostro genero.
— Maria Antonia è una buona massaia; sbriga le faccende domestiche, e non vive che del lavoro e de’ suoi figliuoli. Ella sorveglia le [295] serve ed i servi, tiene d’occhio l’azienda, e segna in un registro tanto le entrate, quanto le uscite. Ha tutte le ore occupate, perchè i figli non la lasciano in pace; però non manca ogni sera, prima di andare a letto, di trattenersi un’oretta a leggere libri ameni ed utili. — Agostino bada all’agricoltura e sorveglia tutti i lavori di campagna, prendendo anche la zappa, per risparmio di spese, o per aiutare gli altri, quando il bisogno lo richiede. Tutti lavorano in casa nostra, grandi e piccoli: di ozioso non ci sono che io!
***
Fra i molti episodî della vita domestica, Giovanni Tolu mi narrò il seguente.
«— Da otto mesi appena ero ritornato da Frosinone, quando un’orribile disgrazia venne a turbare la tranquillità della nostra famiglia,
«A occidente della cascina — fra il caseggiato e la palude — era il nostro pozzo, scavato a fior di terra, senz’alcun parapetto, e coperto d’ordinario con alcune tavole.
«In una calda giornata di luglio, mio nipote Giovannino — il maggiore dei figli di Maria Antonia, di nove anni — si trastullava stando seduto accanto al pozzo, mentre un servo vi attingeva l’acqua per trasportarla alla cascina. Costui si era già incamminato verso la casa, quando udì un sordo tonfo. Voltatosi, e [296] non veduto il fanciullo, quell’imbecille, invece di tornare indietro per apprestargli un soccorso, si era dato a correre verso casa, gridando a squarciagola:
«— Giovannino è caduto nel pozzo!
«Sentendomi quel giorno indisposto, mi ero sdraiato da pochi momenti sull’erba, a pochi passi dalla cascina. Alle grida del servo, balzai in piedi, corsi di un salto al pozzo, e vidi mio nipote, cogli occhi spalancati e le mani tese verso di me, dibattendosi nell’acqua, profonda due metri.
«— Coraggio, Giovannino! — gli gridai.
«Il poveretto portò l’indice della mano destra alle labbra, come per raccomandarmi il silenzio; poi si sommerse, e scomparve.
«Sedetti sull’orlo del pozzo, e sostenendomi colle due mani, allungai le gambe quanto potei, sfiorando quasi la superficie dell’acqua. Speravo che Giovannino riuscisse ad afferrarsi a’ miei piedi; ma il poveretto non tornò più a galla.
«Tutto questo era accaduto in meno di tre o quattro minuti.
«Ad un tratto Maria Antonia, al cui orecchio era pervenuto l’annunzio fatale, si slanciò fuori della cascina, e corse disperata verso il pozzo, mandando urli strazianti. Di un salto fui in piedi, le corsi incontro, e giunsi in tempo per accoglierla fra le mie braccia, mezzo svenuta.
«— Coraggio, figliuola mia — le dissi — ogni [297] soccorso è ormai inutile, perchè il nostro Giovannino è già morto!
«Lascio immaginare le smanie della povera madre, e lo strazio di Agostino quando apprese la sciagura toccatagli![43]
«Il nipotino portava il mio nome, e gli volevo bene. La sua scomparsa da Lèccari, e più il pensiero di sì brutta morte, ci tenne intontiti per lungo tempo. Ma, già! era da prevedersi, poichè eravamo in luglio, il mese delle disgrazie!
«Partecipammo il giorno stesso il triste caso ai parenti, ai compari ed agli amici della Nurra e di Portotorres, come voleva l’usanza. E vennero in molti a farci le condoglianze e a rendere gli onori alla salma.
«Esposto per alcune ore il cadavere dentro casa, preparammo il solito carro a buoi per il trasporto funebre al camposanto di Portotorres.
«Messo uno strato di verdi frasche in fondo al carro, vi fu disteso un materazzo, sul quale venne collocato il morticino, ricoperto da un bianco lenzuolo.
«Appena tutto fu pronto, il carro si mosse lentamente.
«Col cappuccio tirato sugli occhi (in segno di lutto) i congiunti e gli amici montarono tutti a cavallo, per accompagnare la salma di Giovannino all’ultima dimora.
[298]
«Sebbene l’usanza vieti alle donne di prender parte a simili cortei, Maria Antonia non volle lasciar solo il suo figliuolo. Agostino se la prese in groppa, e per due ore circa di strada non fece che sospirare e piangere amaramente.
«Anch’io montai a cavallo per unirmi al corteo; e lungo il cammino non feci che fissare quel lugubre carro, che, rimbalzando e scricchiolando, inoltrava a stento fra sentieri angusti, incomodi, e quasi impraticabili.

«Arrivati a Portotorres la stessa sera, deponemmo il cadavere in casa di mia sorella Andriana, e di là l’indomani fu portato a seppellire nel cimitero[44].
[299]
«Ai sette giorni ebbe luogo a Lèccari l’uscita, secondo l’usanza della Nurra e di altri paesi sardi. Essa consiste in un pranzo che la famiglia dell’estinto offre a quelli che accompagnarono la salma; più in un’elemosina di bestiame, di grano, e d’indumenti usati, che si regalano in quel giorno ai poveri[45].
***
«Il tempo, che tutto sana, rimarginò la profonda ferita che il destino aveva aperta nel nostro cuore.
«Io continuai a vivere tranquillo a Lèccari, fra i miei buoni figliuoli ed i nipotini, che mi vogliono bene. Sono ormai quattordici anni, che vi godo la pace dell’uomo libero.
«Non devo nascondere, che un po’ di noia l’ho risentita, e la risento; ma io cerco di ammazzarla con qualche ora di lettura, o con viaggi che intraprendo ogni tanto. Mi reco con frequenza a Portotorres, a Sassari, a Florinas, od in altri paesi, per visitarvi i parenti e gli amici; nè dimentico di fare un giro per gli ovili nurresi, [300] per riandare coi pastori un po’ del passato, or buono, ed or cattivo.
«A Lèccari, d’altronde, non c’è da annoiarsi: è un luogo di molto passaggio, e le visite non ci mancano mai. L’ospitalità è sacra nella Nurra, nè c’è pastore, per quanto povero, che nieghi un letto o il vitto a chicchessia. Basti dire, che la nostra casa, per i soli ospiti, aggrava l’annuo bilancio di cinque rasieri di grano. A tavola non ci troviamo mai soli.
«Le visite più opprimenti furono sempre quelle dei curiosi. Dopo il mio ritorno da Frosinone, specialmente nei primi anni, esse non mi diedero tregua. Mi si voleva strappare ad ogni costo qualche episodio della mia vita avventurosa, che poi vedevo pubblicato nei giornali di Roma o di Milano, con inesattezze ed esagerazioni che m’irritarono. Decisi allora di non dire più nulla.
«Ricordo, fra gli altri, tre signori che vennero a Lèccari e che invitai a pranzo. A tavola si cercò con arte di farmi cantare, ma io dissi agli ospiti:
«— Se lor signori parlano a tavola, mi toglieranno il piacere di vederli a mangiare. Diano retta a me: non posino le forchette, altrimenti le vivande si raffredderanno!
«Credo che l’abbiano capita, perchè mi lasciarono in pace. Nondimeno, prima di andarsene, si diedero a rovistare la casa, toccando tutti gli [301] oggetti che mi appartenevano (il mio fucile, le mie pistole, le mie bisaccie, la fiaschetta della polvere) per fabbricarvi sopra, Dio sa quante diavolerie!
«Fu, appunto, dietro a queste false od esagerate interviste pubblicate, che mi venne l’idea di narrare la vera storia della mia vita. Ho scelto lei per mio confessore, ed ho la coscienza di aver detto la verità, tutta la verità, nient’altro che la verità! —»
[302]
Con queste parole Giovanni Tolu chiuse la sua storia.
Come se si fosse liberato da un gran peso, egli si alzò, tolse da tasca le inseparabili pinzette, si chinò sul camino, frugò nella cenere, e vi prese un po’ di bragia per riaccendere la pipa.
Anch’io avevo deposto la penna, fedele raccoglitrice della narrazione del bandito, quasi parola per parola.
— Ho detto la verità — soggiunse Giovanni Tolu, premendo il tabacco nella pipa coll’unghia del pollice. — Non ho dimenticato alcun mio delitto, mentre ho voluto omettere non pochi atti di beneficenza[46]. — Molto ho peccato, ma ho molto perdonato. I miei vent’anni di buona condotta hanno forse cancellato i dieci anni che si [303] dicono di condotta cattiva. Non è questo un merito mio: è merito della mia figliuola. Con trent’anni di vita errante, trascorsi fra disagi ed amarezze indicibili, credo di aver espiato le mie colpe. Non mi resta oramai che aspettare serenamente la morte, confortata dall’ultimo bacio dei miei nipotini. Altro non desidero, poichè la vita non può offrirmi nuove attrattive. Ho dimenticato le offese fattemi, ed ho perdonato ai nemici tutti, meno ad uno: al prete Pittui, causa unica di tutte le mie sciagure. Chi lo sa? Forse riuscirò a perdonarlo il giorno della mia morte!
Giovanni Tolu tacque, e si diede a stuzzicare nervosamente il tabacco, il quale si ostinava a non voler bruciare.
Io lo guardavo di sottocchi, titubante se dovevo, o non, rivolgergli una domanda che più volte mi era venuta sulle labbra.
Mi feci alfine coraggio e gli dissi:
— Giovanni Tolu; avrei bisogno di uno schiarimento. Prima però di domandarlo, dichiaro che mi asterrò dall’insistere, se troverete indiscreta la mia curiosità.
Il vecchio bandito tolse la pipa di bocca, e mi fissò con un senso di stupore. Io gli chiesi:
— Non avete altro a dirmi a riguardo di prete Pittui?
— Nulla.
— Non mi avete taciuto, per riguardi di famiglia, qualche sua azione disonesta?
[304]
— Nessuna. Ma perchè simile dubbio?
— Sarò schietto. Nel pubblico è fondata la credenza, che Giovanni Tolu siasi vendicato del prete, solo perchè costui gli aveva oltraggiato la moglie...
— Ciò è falso!
— Eppure così fu detto fin dal giorno che vi deste alla macchia.
— È una menzogna!
— Eppure così si legge nel foglio pubblicato a Frosinone nel 1882, col titolo: l’ultimo bandito sardo. In questo scritto si parla chiaramente della tresca del prete con vostra moglie, della corruzione ottenuta per mezzo di doni, e del vostro dispetto quando sapeste che Maria Francesca frequentava la casa di quel sacerdote.
— Non è la verità!
— Ma non basta. Dal resoconto giudiziario pubblicato dai giornali si deprende, che altrettanto voi asseriste dinanzi ai giudici, alla Corte di Assise di Frosinone. Faceste capire, che vostra moglie non si era mantenuta onesta in casa del prete Pittui; che invano cercaste strapparla a quello sfacciato, il quale osò persino condurla ai balli pubblici per compiacerla.
— Tutte menzogne. Alle Assise non potevo ciò dire; altri certo lo disse, ed io forse, col silenzio, lo lasciai credere, sperando che quella circostanza potesse giovare alla mia difesa. Dentro la gabbia l’accusato non può, nè deve tutto dire!
[305]
— Dunque voi smentite il fatto?
— Recisamente, e ve lo giuro. Mia moglie non aveva che sedici anni; e devo dichiarare sulla mia coscienza, che fino al giorno della nostra separazione non ebbi a farle il minimo appunto a riguardo dell’onestà, della condotta, e de’ suoi costumi. Ella si perdette in seguito, quando venne da me separata. Il difetto di Maria Francesca era nella lingua; nel pettegolezzo; nella facilità di cedere alle altrui insinuazioni; nel mal vezzo d’inasprirmi con sfuriate inopportune. Della sua inesperienza approfittarono appunto gli scaltri, per renderla a me ribelle.
— Permettete allora che io vi dica, che non trovo giustificata la vostra ferocia nell’attentato contro il prete Pittui.
— Fu l’ira del momento quella che mi acciecò. Se avessi premeditato l’assassinio, non avrei affrontato il prete senza un fucile, od un pugnale. Vi confesso, nondimeno, che deplorai la mia imprevidenza. Se avessi ucciso il prete, sarei stato subito sciolto dalle legature fattemi.
— Vi inasprì dunque tanto la sua prepotenza?
— In modo indicibile. Chi lo sa? forse sarei stato meno feroce, se si fosse trattato di una tresca. O avrei subito ucciso i due colpevoli, o mi sarei limitato a scacciar di casa la moglie infedele, abbandonandola al suo rimorso ed al suo disonore. Ma quel continuo torturarmi entro alle pareti domestiche; quel continuo intromettersi nei [306] fatti miei; quel continuo sindacare ogni azione della mia vita coniugale; quell’eccitamento continuo perchè mia moglie si separasse da me; oh, perdio! tutto ciò doveva inasprirmi e farmi perdere la pazienza! Ero io il marito, ero io il padrone in casa mia; e quel prete doveva badare alla sua sagrestia, senza mettere ogni tanto il suo tricorno fra marito e moglie.
— E non sospettaste mai di una tresca?
— Mai, quantunque il volgo vi alludesse prima e dopo il mio matrimonio. Mia moglie era una ragazza sedicenne, al servizio, fin da bambina, in casa di prete Pittui; e di là io l’aveva tolta incontaminata. Se il prete avesse avuto intenzioni disoneste, o avrebbe prima impedito che la ragazza mi fosse data, o avrebbe impedito dopo che mi venisse tolta. Sarebbe stato suo interesse a mantenerci uniti, tanto più che io mi assentavo con frequenza dal villaggio. Basta questo per dimostrare, che tresca alcuna non poteva sussistere.
Le ragioni del bandito erano molto assennate, e mi facilitavano la strada per poter esternare un dubbio, che mi era sorto nell’animo.
— Ma perchè, dunque — chiesi — quel sacerdote prepotente si preoccupava tanto di Maria Francesca, quando i genitori di lei non se ne preoccupavano? Ma perchè il solo prete, e non altri, osò chiedervi conto dei maltrattamenti fatti a vostra moglie? Ma perchè dal solo prete doveva [307] venir l’ordine di strapparvi alle braccia di Maria Francesca? È mai possibile che l’affetto di Giovanni Maria Pittui fosse più forte di quello di Salvatore Meloni Ru?
Il bandito, dopo avermi a lungo fissato, come uomo a cui si strappa dall’anima un segreto geloso, abbassò il capo dicendo:
— È appunto questo il mistero che per lungo tempo mi tenne agitato...
— Ma che in seguito vi parve di spiegare... non è così?
Giovanni Tolu tacque esitando, ed io continuai:
— Proprio così! Bisognava risalire alla gioventù scioperata di Masala Pittui — alla sua vita scandalosa — alle sue libidini abituali, per ricercare le cause intime che spingevano l’anziano sacerdote a proteggere la servetta di casa. Non era febbre di amore impuro, nè gelosia di ganzo senile, quella che riscaldava il sangue di prete Pittui — era forse affetto di padre che parlava con rimorso alla sua coscienza! Un padre, non un amante geloso, poteva consigliare la sua creatura a distrarsi nei divertimenti, per dimenticare la supposta infelicità coniugale... Non è così...?
A questo punto il bandito prese a dire con vivacità:
— Ora posso confessarlo: fu appunto questo il mio pensiero; e sono ben lieto di non averlo per il primo a lei rivelato. Debbo però soggiungere, [308] che neppure l’affetto di padre potè far presa nella coscienza di quell’anima nera, negli ultimi otto mesi che rimase in questo mondo. Il prete Pittui non porse mai la mano a Maria Francesca per trarla dalla miseria e dal peccato. Abbandonata a sè stessa, la poveretta non ebbe l’aiuto di nessuno — nè del prete protettore, nè dei genitori indifferenti. Il frutto del peccato fu lasciato al peccato, e il peccatore fu punito dalla stessa sua colpa. Il tradimento fatto ad uno stupido o compiacente marito era ridondato a danno di prete Pittui. Io non fui che il cieco strumento della collera divina!»
***
Così conchiuse Giovanni Tolu, in un impeto di profonda amarezza. Io avevo letto nel suo pensiero e messo il dito sulla piaga; ma non volli più oltre fermarmi sopra un argomento scottante. Compresi che un mistero doveva celarsi in quel complesso di fatti, che non giustificavano il feroce attentato della piazzetta di Santa Croce. Ma a che servirebbero le ulteriori indagini, quando il prete Pittui ha portato il suo segreto nella tomba?[47].
[309]
***
La storia del bandito è finita. Vittima più del pregiudizio e della superstizione, che della malvagità degli uomini, Giovanni Tolu ha scontato [310] le sue colpe. Egli ha detto tutta la verità; ed io son lieto di aver potuto narrare ai lettori la storia di un uomo co’ suoi vizi e le sue virtù, anzichè quella di un eroe benefico, quale il popolo la vuole, o quella di un volgare delinquente, come altri la vorrebbero.
A coloro che mi facessero carico di aver aderito a pubblicare la confessione di Giovanni Tolu, risponderò: che non vi ha storia al mondo, la quale non dia campo a profonde meditazioni, a studi serî, e ad ammaestramenti proficui. È questa la mia convinzione!
Non al legislatore, non al giudice, non al carabiniere, non al psichiatra verrà affidato il còmpito di liberare la società futura da questi esseri perniciosi, i quali, (cattivi o buoni) lasciano sempre una traccia di sangue sulla strada che percorrono — e sono nocivi sempre, anche quando riescono a fare il bene!
Ad altro benemerito sarà in avvenire riserbata l’alta missione civilizzatrice: — al maestro di scuola.
Ma — intendiamoci bene! — non al maestro di scuola che insegni solamente a leggere un libro; ma a quello che illumina le menti, educa il cuore, indirizza il sentimento al benessere di tutte le classi sociali, unite in un vincolo d’amore e di fratellanza.
[311]

La storia fin qui narrata (meno alcune note) è quella contenuta nel manoscritto da me consegnato all’editore Dessì, verso gli ultimi di maggio. Non immaginavo, certo, di dover aggiungere quest’ultimo capitolo!
Posto termine alla narrazione delle sue avventure, Giovanni Tolu era ritornato alla Nurra. Continuò nonpertanto a recarsi con frequenza a Sassari, per fornirmi gli schiarimenti che mi abbisognavano.
Ero già stato con lui a Monte Fenosu, e col prof. Piras a Florinas, per prendere alcuni schizzi sui luoghi dell’azione. Volendo pur visitare la cascina di Lèccari, informai l’ex bandito del giorno della mia partenza.
[314]
La mattina del 21 giugno, col primo treno, mi recai a Portotorres. Come smontai dal vagone, vidi venire al mio incontro un uomo sulla cinquantina, dall’occhio vivo e intelligente, dalla lunga barba brizzolata, e dal grigio cappellone a larghe tese. Era Giovanni Agostino Tolu, il genero dell’ex bandito.
Montati su due ottime cavalle, ci mettemmo in viaggio per Lèccari, dove arrivammo alle nove.
Giovanni Tolu mi presentò alla sua figliuola ed ai nipoti, i quali mi accolsero con un’infinità di cortesie.
Tutta la mattina fu da me impiegata a visitare la vasta cascina ed i dintorni, e a prendere alcuni schizzi[48]. Giovanni Tolu volle che io vedessi tutto, compreso il pollaio, ricco di galline, di tacchini e d’oche; e l’orto, ben assortito di erbaggi d’ogni genere.
Nel centro della palazzina è l’ampia sala da pranzo, a cui si accede dalla porta principale, difesa da una bussola in legno. A destra della sala, verso levante, è la camera dei coniugi Tolu; a sinistra quella dell’ex bandito. In questa ultima vedesi, appiedi del letto, un armadio scavato nel muro, a quattro piani: i due primi destinati alle stoviglie, i due inferiori alla libreria di Tolu; la quale si compone di una quarantina [315] di volumi dai dorsi sgangherati, dai cartoni logori, e dai fogli colle punte accartocciate. La biblioteca di Giovanni Tolu non ha che un pregio: quello di esser letta e riletta! Presi in mano alcuni libri per leggerne i titoli: — Ufficio della Beata Vergine; Bibbia di Diodati; I Reali di Francia; Bertoldo e Bertoldino; Guerrino il meschino; Ettore Fieramosca; Carlo Magno; Vita dei Santi; l’Inquisizione di Spagna.
La famiglia di Agostino si compone di cinque figli, fra i quali una ragazza da marito e un giovanotto ventenne.
A mezzogiorno si andò tutti a pranzo — e ricorderò sempre la cordialità affettuosa di quella buona famiglia.
A tavola l’ex bandito tirò in campo la pubblicazione imminente della storia veridica da lui narratami, che doveva far dimenticare l’altra fantastica, messa in giro dal popolo[49].
Notai che fra padre e figlia non correva [316] armonia d’intendimenti. Maria Antonia, sempre seria e riflessiva, pareva soffrisse, non condividendo l’entusiasmo paterno. Rispondendo ad una frase del vecchio, che alludeva ai torti della propria moglie, ella disse a me rivolta:
— Il torto fu di entrambi. Con qualche buona persona per lo mezzo si sarebbero potuti evitare molti malumori e molti guai. La mia mamma era troppo giovane, e fu lasciata sola; il mio babbo fu troppo puntiglioso e troppo aspro. Non so, d’altronde, chi sia dei due il più disgraziato. Non credo un’invidiabile celebrità quella cui aspira un bandito, dopo aver ucciso, a torto od a ragione, il proprio simile. Spetta a Dio, non agli uomini, togliere la vita ad altri!
Erano sante parole, che il vecchio certo non afferrò intieramente, perchè un po’ sordo.
[317]
Si parlò in seguito della disgrazia di Giovannino, morto annegato; e Maria Antonia, colle lagrime agli occhi, esclamò vivamente:
— La colpa fu tutta del poco spirito degli uomini presenti alla disgrazia. Se ci fossi stata io, lo avrei di certo salvato!
Verso le 5, io ed Agostino montammo a cavallo. Il bandito, la figliuola e i nipoti vennero tutti sul piazzale per salutarmi. Promisi loro una seconda visita in settembre.
Giovanni Tolu era di buon umore, e mi colmava di cortesie. Voleva essere scrupoloso nel fare gli onori di casa. Egli mi disse:
— Noi ci rivedremo fra pochi giorni!
Dopo un’ora di cavalcata arrivammo a Portotorres. Agostino volle accompagnarmi alla stazione, ed io fui di ritorno a Sassari col treno della sera.
***
Erano appena trascorsi tredici giorni dalla mia gita a Lèccari, quando il 4 luglio 1896 l’editore Dessì ricevette da Portotorres la seguente cartolina:
«Oggi, alle ore 13, morì qui di carbonchio Giovanni Tolu. Partecipi la notizia al Cav. Enrico Costa.
Gio. Agostino Tolu.»
[318]
Il disgraziato bandito, che ogni due o tre settimane veniva a Sassari, smanioso di veder pubblicata la sua storia, non fu appagato nel suo desiderio.
Era stata una vera fatalità! Per trent’anni Giovanni Tolu aveva taciuto le sue avventure; e finalmente si era deciso a raccontarle... quasi alla vigilia della sua morte. Vi ha di più: da soli due mesi l’editore Dessì lo aveva indotto a farsi fare il ritratto, riprodotto in questo libro.
Or ditemi: non vi par tutto questo il romanzo d’una storia, o la storia di un romanzo?[50]
[319]
***
Abboccatomi nella prima metà di luglio colla figlia e coi parenti dell’ex bandito, appresi i particolari della sua morte.
Il giorno 28 giugno Giovanni Tolu aveva deciso di recarsi a Portotorres, per assistere l’indomani alla festa di San Pietro. Siccome dovevano pur recarvisi alcuni servi, la mattina del 29 egli si affrettò ad aiutarli, per chiudere il bestiame grosso nel recinto a ciò destinato. Egli si era dato a spingere i tori e le vacche, percuotendoli colla palma della mano; e, dopo aver molto faticato, sì era messo in viaggio per Portotorres.
Tornato il martedì (30) a Lèccari, si lamentò di un piccolo foruncolo ad una mano, che lo tormentava alquanto. Entrata l’indomani la figliuola nella sua camera, avvertì la gonfiezza della mano; ma Tolu, burbero com’era, le rispose:
— Cose da nulla; non dartene pensiero!
Il giorno seguente crebbe l’enfiagione; e quantunque il vecchio persistesse nell’assicurare che non era nulla, la figliuola gli bruciò alla meglio la ferita col nitrato di argento.
Di ciò non ancor contenta, Maria Antonia costrinse il vecchio a montare a cavallo; gli sedette in groppa, e si avviarono a Portotorres per consultare il medico.
[320]
Il giorno 2 il medico avvertì il carbonchio, fece il taglio, cauterizzò la ferita, e fece stare a letto l’ex bandito, in casa del nipote (figlio di Giomaria).
Non tardò il male ad aggravarsi. Giovanni Tolu cadde in un torpore, che lo rendeva ignaro della gravità del male.
Fu supposto che il vecchio, aprendo il cancello, avesse riportato qualche leggera scalfitura; nella quale, o si era comunicato il carbonchio per le percosse date alle vacche, oppure per qualche mosca (come comunemente avviene) che avesse deposto il veleno sulla ferita.
Poche ore prima di morire furono consigliati al vecchio bandito i conforti religiosi. Egli assentì col capo, senza pronunciar parola.
A un’ora dopo mezzogiorno, del sabbato, egli spirava.
***
Quasi tutti i giornali italiani annunziarono la scomparsa di Giovanni Tolu sotto la rubrica: la morte di un celebre brigante[51].
Niente di più erroneo. Il bandito sardo non è il brigante; e, per convincersene, basta riandare le gesta dei famosi capi squadriglia, che, in [321] tempi civili (1860-1896) infestarono le due Sicilie, la Romagna, ed altre regioni d’Italia: — gesta, che hanno destato il terrore per la ferocia dei misfatti, per il sangue freddo con cui vennero preparati, e per il cinismo degli assassini dopo averli commessi. Dal complesso dei fatti fin qui narrati, il lettore avrà rilevato quanto diverse siano le cause che hanno spinto alla delinquenza i disgraziati banditi.
Giovanni Tolu non era Ninco Nanco, non era Caruso, non era Cipriano La Gala, non Torrigiani, non Mistretta, non Domenichino Tiburzi. Molta differenza corre fra l’uno e gli altri. Il brigante si dà alla macchia per formare una banda di malfattori; il bandito rifugge dai compagni per meglio meditare nella solitudine; il primo non pensa che al furto e all’assassinio, il secondo non sogna che la vendetta[52].
***
Da pochi giorni era morto Giovanni Tolu, quando la sua figliuola ricevette una lettera da un avvocato di Cagliari. Costui, per incarico di Maria Francesca Meloni, domiciliata a San Gavino [322] Monreale, chiedeva informazioni sul patrimonio lasciato dall’estinto, non volendo la vedova rinunciare alla quarta uxoria, che le spettava per disposizione dell’art. 753 del Codice civile.
La domanda di quella vecchia, pervenuta a Lèccari in un giorno di dolore, era stata una spina al cuore di Maria Antonia. La povera figliuola rispose di proprio pugno alla madre, e venne a me per leggermi la brutta copia della lettera inviata.
Lo scritto di Maria Antonia era forse assai povero di grammatica, ma il concetto era grande, nobile, generoso, e rivelava un profondo sentimento di amor figliale.
Riassumo fedelmente i pensieri contenuti in quel foglio.
«Carissima madre,
«Sono più di trent’anni che mi avete dimenticata, ed io ignoravo persino la vostra esistenza. Oggi solamente vi siete ricordata di me, per chiedermi conto, in nome della legge, dei beni lasciati dal disgraziato padre mio. Mi meraviglio come non abbiate riflettuto, che un bandito non può aver patrimonio. Il poco che oggi possediamo è frutto del mio sagrifizio e del lavoro di mio marito. Nostro padre non ha lasciato che un pezzo di terra in Uccareddu, che ci darà molti fastidi, per una lite pendente, a causa di delimitazioni.
[323]
«Io non ho accuse da farvi, nè vi rinfaccio alcuna colpa, poichè una figlia non può avere il diritto di giudicare la propria madre. Ho il dovere di rispettarvi; ed oggi vi dico, anche a nome di mio marito: — Qui a Lèccari abitiamo una casa vasta e molto comoda; vi crescono i nostri figliuoli, e non vi mancano i servi. Venite pure: mi aiuterete nel disbrigo delle faccende domestiche, se lo desiderate — oppure non lavorerete, se così vi piace. Vostra figlia apre a voi la sua casa, affinchè in essa possiate passar tranquilli gli ultimi anni della vecchiaia.
«Altro non abbiamo a dirvi.
Maria Antonia Tolu.»
Questa lettera, fino ad oggi, è rimasta senza risposta. La madre tacque, forse perchè pentita dell’imprudenza commessa, non prevedendo la generosità della figliuola.
Chi lo sa? forse nella mente della povera vecchia sarà passata, come in una visione, tutta la storia del suo primo amore e della sua prima colpa. Forse erale mancato il coraggio di dire, che non poteva accettare l’ospitalità generosa di una figliuola, senza distaccarsi da altri figli... che Maria Antonia non avrebbe potuto chiamare fratelli!
[324]
Il destino ha scritto la parola fine sul triste libro di Giovanni Tolu. A noi non è lecito leggere più oltre.
Il vecchio bandito dorme l’ultimo sonno nel camposanto di Portotorres; e la vecchia peccatrice, ferita al cuore dalla generosità figliale, espia forse l’ultima colpa alle falde del castello di Monreale.
Irrisione dell’umano destino! — Giovanni Tolu, il ministro di morte e di pace; il superbo bandito che riuscì a sfuggire alle palle di cento fucili; che nessun nato di donna giunse mai ad atterrare, morì anch’esso di morte violenta, avvelenato da un insetto. — Gli uomini lo temettero, ed una mosca l’uccise.
FINE
[325]
| PARTE SECONDA | ||
| IL BANDITO DI FLORINAS. | ||
| (Continuazione) | ||
| Cap. | ||
| XXI. | Spigolatrice e spigolatore | Pag. 5 |
| XXII. | Gita notturna | 15 |
| PARTE TERZA | ||
| IL BANDITO DELLA NURRA. | ||
| I. | Alla Nurra | 33 |
| II. | I nuovi pirati | 42 |
| III. | Antonio Careddu | 53 |
| IV. | Gli amori del bandito | 65 |
| V. | Occupazioni e passatempi | 77 |
| VI. | Tra carabinieri e spie | 86 |
| VII. | Strumento d’odio altrui | 97 |
| VIII. | La bambina nell’aia | 106 |
| IX. | A San Paolo di Monti | 119 |
| X. | La scolara insegna il maestro | 124 |
| XI. | Vita nuova | 133 |
| XII. | Il giudice di pace | 140 |
| XIII. | A Monte Rasu | 154 |
| [326] | ||
| XIV. | Lo scandalo d’una tresca | 165 |
| XV. | I ladri di buoi | 173 |
| XVI. | Bue per bue! | 182 |
| XVII. | Fra giudici e avvocati | 192 |
| XVIII. | Fra ladri di bestiame | 202 |
| XIX. | Salvacondotti | 213 |
| XX. | Fidanzamento e sponsali | 222 |
| XXI. | Arma bianca e bestia nera | 232 |
| XXII. | In difesa del debole | 238 |
| XXIII. | Nel mondo dei curiosi | 246 |
| XXIV. | Vita e azienda a Lèccari | 253 |
| XXV. | L’arresto | 262 |
| PARTE QUARTA. | ||
| DOPO L’ARRESTO. | ||
| I. | In carcere | 275 |
| II. | A Frosinone | 282 |
| III. | Il bandito in libertà | 289 |
| IV. | Il mistero | 302 |
| APPENDICE | ||
| Morte di Giovanni Tolu | 313 | |
NB. Il buon senso del lettore correggerà di leggieri i pochi errori di stampa, sfuggiti al proto in questo libro; come, per esempio, nel Volume I, sollecirare per sollecitare (pag. 108) — ammicarseli per amicarseli (314) — parecchie volte Assisie per Assise; e nel Volume II, identicità per identità (p. 29) — arruffatta per arruffata (p. 74) — volla per volta (93) — appettito per appetito (115) — lavorare per lavare (174) — stringendogli strette per stringendogli (280); ed altri insignificanti, che facilmente verranno avvertiti.
[327]
VOLUME SECONDO
| Uccisione di Salvatore Moro | Pag. 27 |
| Testata allegorica sui personaggi della storia | 33 275 |
| Il bandito e la sua bambina | 126 |
| I carabinieri a Monte Rasu | 157 |
| La cascina di Lèccari | 260 |
| I funerali del nipote di Tolu | 298 |
| Lettera iniziale allegorica al banditismo | 313 |
1. Veramente, Tolu fu poco cavalleresco e molto rusticano!
2. Ricordo per l’ultima volta al lettore, che io non aggiungo una sillaba alla narrazione del bandito.
3. Omicidio commesso il 10 dicembre 1856. Vi fu sospetto, forse per la dichiarazione delle moglie dell’ucciso; ma fu dichiarato non farsi luogo a procedere con ordinanza del 5 gennaio 1862. Il Tolu, però, confessa schiettamente l’omicidio; e ciò prova la veridicità della sua confessione.
4. Pare incredibile! E si era nel 1854!
5. — Che cosa vuol dir Basto? — chiesi a Tolu.
— È il nome di una città! — fece il bandito, come sorpreso ch’io non lo sapessi. — Scriva così!
6. Nè alcuno potrà spiegarlo, quantunque consimili casi siano stati da altri avvertiti.
7. Giovanni Tolu conosceva il codice della pirateria!
In tempi amichi, e fino al primo ventennio del secolo spirante, molti pirati si gettavano sulle spiaggie della Nurra e dell’Asinara. A quest’isoletta approdò, il 19 settembre 1812, uno sciabecco turco, che fece schiavi 20 individui, fra uomini, donne e fanciulli. Un turco fu ucciso da un pastore.
8. Traduco sempre le parole di Giovanni Tolu, che invitavo a parlare in sardo per meglio capirlo. Lascio intatta la sua narrazione, sebbene in qualche punto non ci accordi colla storia di quei tempi.
9. I sicari erano scrupolosi nell’adempimento del loro dovere. L’ho detto altra volta: fare il sicario era ritenuto a quel tempi un mestiere come un altro! — Questi fatti accadevano nel 1851.
10. Questo caso di Sant’Agostino mi fu citato parecchie volte dall’ex bandito. Non poteva tollerarlo!
11. Tolu non volle dirmi neppure il nome di battesimo di questa donna, mentre mi confidò quello delle altre donne, con preghiera di non pubblicarlo.
12. Durante il tempo che avvicinai Giovanni Tolu, mi divertivo ogni tanto e farmi dir l’ora. Non si sbagliò mal di oltre una quindicina di minuti; e quando lo correggevo esclamava: — È il suo orologio che va male! Quella di Roma è un’ora falsa per noi.
13. L’agguato era per Tolu, come mi risulta da un processo. I carabinieri Virdis e Nuvoli, nella loro relazione scritta, dichiararono ch’era loro intenzione di far fuoco su Tolu, senza neppure intimargli il ferma!
14. A quest’ambasciata prese pur parte il Dott. Antonio Francesco Satta, il quale lodò Tolu per il disdegnoso rifiuto a intingere in un tradimento. I florinesi erano gelosi della propria dignità, e preferivano un feroce bandito ad un vil traditore.
15. Abbiamo veduto come le Autorità, più tardi, cercarono di aver nelle meni Tolu per mezzo di Derudas, che si trovava in carcere. Pare che il sistema del governo assoluto perdurasse anche in quello costituzionale.
16. Stirare il cavallo: esercitarlo alla corsa alcuni giorni prima della festa. Espressione sarda.
17. Corre nel popolo insistente la voce, che il bandito avesse in precedenza fatto un segno alla bambina per riconoscerla più tardi. Tolu la smentisce, e con ragione. Quando poteva farle il segno, se non l’aveva mai veduta? Il primo suo dubbio, comunicato ad altri, diede forse appiglio alla diceria.
18. A costo di annoiare il lettore, ho voluto riportare le minuzie di queste scene puerili, che Giovanni Tolu mi narrava con tanto trasporto.
19. Trascrivo fedelmente la lettera, dettatami in italiano da Tolu.
20. Ho già detto che su Tolu caddero i sospetti di questo colpo, ma in seguito fu dichiarato non farsi luogo a procedere. Ora l’ex bandito si dichiara colpevole, volendo confessare tutti i suoi delitti.
21. Io credo che Antonio fosse sempre risentito per essere stato accusato dai fratelli; e lo desumo dalla sua deposizione alle Assise per il fatto di Monte Rasu. Egli rivelò alcune confidenze fattegli da Tolu, a proposito dell’odio che nutriva verso il brigadiere Piettone.
22. Noti il lettore la paura che si aveva dagli sconosciuti negli ovili della Nurra.
23. Il fatto avvenne la mattina del 21 maggio 1859.
Darò il sunto della relazione dei carabinieri e di altri testimoni, che tolgo dagli atti del processo.
Il brigadiere Antonio Piettone, il vice brigadiere Giuseppe Delrio, e i due carabinieri Antonio Catte e Raimondo Argiolas erano usciti dalla stazione di Portotorres, fin dal 19 maggio, in perlustrazione. Nella mattina del 21 si presentarono all’ovile della vedova di Paolo Sechi per abbeverare i cavalli.
Il vice brigadiere Delrio precedeva i compagni, avendo il cavallo indomito. Giunto alla porta della capanna che guarda levante, mentre un mastino abbaiava, gli fu fatto fuoco da dentro, e cadde.
Piettone e Argiolas spinsero allora i cavalli in avanti, mentre Catte si dirigeva alla porta opposta, volendo impedire l’uscita all’ignoto assassino. Uscito il bandito, e veduto a 30 metri il carabiniere, lo sparò scaricando l’altra canna.
Il bandito prese la fuga verso tramontana, e Piettone e Argiolas si diedero ad inseguirlo per 10 minuti, tirandogli dietro tre fucilate. Quantunque sicuri di averlo ferito, tonarono indietro per andare in cerca di carri per trasportare i feriti. I due carri furono somministrati da L. Gianichedda, da D. Atzoni e da Gio. Sechi.
Il vice brigadiere Delrio e Catte furono trasportati a Portotorres, indi all’ospedale militare di Sassari, dove morirono: il Catte l’indomani, e Delrio il 1º luglio, 40 giorni dopo.
Nell’ovile erano due sole donne: la vedova Sechi, e Maria Rita, la moglie del servo pastore. Quest’ultima preparava alcuni laticini per i bambini, nell’ovile; la Sechi era nella capanna.
Dice quest’ultima, che per Tolu fu tutt’uno: udire il cane, vedere il vice brigadiere, spararlo, fuggire, e far fuoco su Catte.
Gio. Sechi dice, che Tolu fece gli spari per mera vendetta.
Antonio Sechi afferma, che avendo più tardi rimproverato Tolu per la catastrofe, questi gli disse che non aveva potuto farne a meno, poichè in tali casi l’unico mezzo di scampo è sempre il far fuoco sull’arma. Più dice, avergli Tolu confidato, che uccise Delrio credendolo il brigadiere, di cui andava sempre in traccia perchè lo perseguitava.
Il Tolu niega tutto, e dice che i carabinieri andarono ad arrestarlo, perchè a Boturru vi fu chi volle informarli del suo ritiro nell’ovile di Paolo Sechi.
24. Risulta che questa voce si sparse a Florinas verso il 1863.
25. Assennate considerazioni, che mi sorpresero in un rozzo bandito.
26. Ecco i nomi di tutti i banditi, ch’ebbe a compagni Giovanni Tolu, durante il primo decennio di latitanza:
1. Antonio Rassu d’Ittiri — 2. Leonardo Piga — 3. Giomaria Puzzone — 4. Antonio Maria Derudas — 5. Pietro Cambilargiu — 6. Pietro Deligios, d’Osilo — 7. Sebastiano Branca, d’Ossi — 8. Gio. Andrea Ilde, di Nurra — 9. Antonio Careddu — 10. Giomaria Cossu, di Nulvi — 11. (ed ultimo) Giomaria Ibba.
Quasi tutti vennero arrestati od uccisi da carabinieri o da nemici. Tranne Derudas, col quale Tolu visse due anni, gli altri non gli furono compagni che per pochi mesi, o parecchie settimane.
Di questi banditi il Tolu narrò le brutte azioni, tacendo le buone, che pur non sono ignote. In ciò non fu scrupoloso; e mi accorsi ch’ei tacque per un sentimento di gelosia. Questo lo noto per la verità, volendo scrivere una storia, non un romanzo.
27. Quantunque da un quarto di secolo siano avvenuti i fatti che qui si narrano, ho creduto conveniente tacere, cambiare, o alterare diversi nomi di persone, che l’ex bandito mi declinò scrupolosamente per avvalorare la sua narrazione.
28. Per cavallo dei morti s’intende un tumulo, formato da un’alta panca ricoperta da un manto nero, sul quale si collocano alcuni ceri, due teschi e un crocifisso.
29. Screpolarsi la pianta dei piedi, è bestemmia sarda che allude al cadavere.
30. Giovanni Tolu era molto inasprito per l’uccisione de’ suoi buoi, e forse non tutte le sue induzioni saranno state fondate, a proposito della complicità di compare Maurizio nello scannamento.
31. Il lettore avrà notato la facilità e la fretta con cui nella Nurra si riportavano le parole pronunziate da questo e da quello. Queste parole (gonfiate ed alterate ad arte) forse eccitavano gli odî e provocavano le vendette di sangue. La maggior parte dei misfatti dei latitanti dell’isola hanno per origine la leggerezza dei referendari. Qui, per esempio, vediamo Tolu avvertito da quel Tignosu, che altrove ci venne indicato come il fiduciario dei carabinieri nell’assalto di Monte Rasu. E fidatevi di queste prove, che ciascuno crede avere sulla reità dell’avversario!
Le passioni, che in quel tempo agitavano gli animi degli abitanti della Nurra e di quasi tutti i paesi del Logudoro, erano fomite di dicerie, di denunzie e di sospetti, non di rado privi di fondamento. Anche certi giudizi di Tolu, o per antipatie, o per false referenze, saranno stati erronei. Quanto ho asserito per i buoi, valga per altre asserzioni di Tolu, da me riportate; come, per esempio, i sospetti su Francesco Serra (pag. 160, I.) — il giudizio per l’assassinio di Bazzone (pag. 162, I.) — la vendita dell’oliveto di Giacinto (pag. 59, II.) — la complicità di Manunta e di Deroma nell’assassinio di Antonio Careddu (pag, 63, II.) e così altri. Rimando il lettore alla mia nota, a pag. 159, vol. I.
32. Trovasi presentemente a Milano, colonnello giubilato.
33. La sentenza contumaciale ha la data del 14 luglio 1869.
34. Vento buono e vento cattivo: espressione dei pastori e contadini sardi, per dire che il vento è favorevole o contrario all’olfato o all’udito degli animali, l’uomo compreso.
35. Se è vero che questa curiosità entusiastica eccitava il bandito a perseverare nelle azioni generose, è pur vero che in altri tempi essa dovette incoraggiarlo a cimentarsi in imprese, non sempre nobili, nè degne di plauso.
36. Pare che il bandito sperasse in un maggior compenso, credendo sul serio che la strada l’avesse fatta lui! Gli Inglesi certamente avevano inventato un pretesto per avvicinare il famoso bandito.
37. Pare che Tolu desse un senso troppo largo all’art. 137 del Codice penate, dimenticando la sentenza del 14 luglio 1869, che lo condannava a morte.
38. Ecco un brano del verbale di arresto, eseguito il 22 settembre 1880, firmato dal maresciallo Guangani; dal brigadiere Badino, dal vice brigadiere Cicotti, e dai carabinieri Morelli, Gallu, Zunchelli, Mirra, Battiston, Spada, Vagnone, Banalli, Concu, Agostini e Dalpozzo:
«Non appena Tolu si avvide del gruppo dei carabinieri, tentò sottrarsi colla fuga, uscendo dalla porta laterale e dirigendosi verso il suo nascondiglio; ma non appena ebbe percorso circa 80 metri, si trovò di fronte a noi. Gli intimammo il ferma e di arrendersi. Egli si fermò, continuando sempre a tenere il fucile impugnato con ambe le mani, a braccia distese; ma vistosi attorniato in modo da aver preclusa ogni via di scampo, sia colla fuga, come col far fuoco, e in seguito pure alle continue minaccie di arrendersi, con un certo malincuore gettava il fucile a terra, le pistole cariche, e pugnale, e ventriera con entro 35 palle, e capsule, e fiaschetta di polvere.»
39. Riporto fedelmente alcune frasi, per dimostrare il buon senso e lo spirito di Tolu, che faceva entrare dappertutto la storia di Bertoldo, la Storia Sacra e quella dei Reali di Francia.
40. Fra le deposizioni scritte, trovo nel processo quella di Don Antonio Pitzolo; il quale asserisce, che Giovanni Tolu s’impietosì quando un giorno vide nella Nurra i figli del drudo di sua moglie, ch’erano laceri, scalzi e in uno stato miserando. Egli disse loro: — Assicurate vostro padre, che da me non avrà mai male!
Questo fatto mi venne taciuto dall’ex bandito, non so se per dimenticanza, o per altro scopo.
41. I certificati sono delle Giunte comunali e Sindaci di Ploaghe, Florinas, Cargeghe, Banari, Portotorres, Ossi, Alghero a Sassari; più del capitano dei barracelli e del parroco di Florinas.
La Giunta di Florinas (7 Agosto 1869) certifica, come il prete Pittui inveleniva i dissidî fra Tolu e la moglie, anzichè consigliar loro la pace e la concordia. Accenna a vari documenti ufficiali, fra cui alla nota in data 21 agosto 1850, rilasciata dall’Intendente Generale, nella quale si biasima la condotta del prete e si dà incarico al Sindaco di Florinas di chiamare Maria Francesca, invitandola a far la pace col marito, con minaccia, in caso contrario, di ricorrere alla forza.
Il parroco di Florinas (nel luglio del 1869) certifica, che Tolu adempì alle pratiche religiose e frequentò i sacramenti. Dice, che nell’ultimo triennio, conosciuta l’infedeltà della moglie, invece di pensare alla vendetta, egli si contenne da buon cristiano, e perdonò, in modo da lasciare ai suoi conterranei un esempio splendido da imitare.
Questi documenti (da me consultati dopo la morte di Tolu) attestano la scrupolosa narrazione del bandito.
42. L’egregio Antonio Pezzini scrisse testè nel pregievole suo opuscolo Sulle condizioni d’Italia, e sue riforme, queste dure parole:
«Nella bizantina e inconseguente Italia, noi consideriamo il delinquente in generale come un perseguitato ingiustamente dalle leggi, tanto che molti ascrivono a merito di nasconderlo, e possibilmente anche di salvarlo.»
Ho parlato nelle pagine storiche di un bandito raccomandato al re dal cardinale Alboni nel 1733. Il detto Pezzini parla dei briganti Crocco e La Gala, che sotto la bandiera francese, verso il 1860, ricevettero dal Papato onori, benedizioni, sicurezza, e mezzi.
43. La disgrazia avvenne il 14 luglio del 1883.
44. D’ordinario i carri funebri si fermavano al Ponte romano. Di là veniva dato avviso al prete, che vi si recava per accompagnare il cadavere al cimitero. Da una diecina d’anni a questa parte, i morti della Nurra vengono seppelliti nel cimitero di Sassari o dell’Istintino.
45. L’uscita ha luogo ai tre, ai cinque, o ai sette giorni dopo i funerali. Se venisse fatta in giorni non dispari sarebbe per il popolo un malaugurio!
46. Ed infatti fu scrupoloso e disse la verità. Tacque molti atti di beneficenza che risultano dal processo; e si accusò di molte colpe, ignorate o dubbie — come, per esempio, la morte di Salvatore Rassu nel 1854, ed i delitti per cui fu dichiarato non farsi luogo a procedimento, come lo sparo a Piana nel 1851 — la ferita al brigadiere Andorno nel 1852 — e l’omicidio di Salvatore Moro nel 1856.
47. Era già in corso di stampa il presente libro, quando una novella prova venne ad avvalorare la misteriosa relazione fra il prete Pittui e la moglie di Giovanni Tolu.
Fatti da me consultare i libri della parrocchia di Florinas, non vi si rinvenne l’atto di nascita di Maria Francesca, mentre nessuno vi mancava degli altri figli di Salvatore Meloni Ru. Sospettai subito, che la moglie di Tolu non fosse che una figlia adottiva, affidata alle cure dei coniugi Meloni da qualche ragguardevole e misterioso peccatore.
Recatomi nel passato febbraio (1897) a Florinas, in compagnia dell’amico Giuseppe Dessì, andammo a visitare Peppe, il gemello di Giovanni Tolu. Egli ci dichiarò francamente, di aver sempre ritenuto Masala Pittui come padre, non come amante di Maria Francesca, da lui ritirata in casa fin da bambina. Peppe Tolu non si mostrò meravigliato dell’omissione dell’atto di nascita nei libri della parrocchia, perocchè il caso si era verificato altre volte a Florinas. Egli, per esempio, volle citarci il proprio fratello Giomaria, il cui nome non figura nei registri di quella parrocchia.
Il fratello di Tolu volle consultare in proposito, alla nostra presenza, una vecchia più che ottantenne, la quale ci dichiarò che per la gravidanza di Caterina Merella (madre di Maria Francesca) nacquero malumori e scompigli in casa di Salvatore Meloni — tanto che i due coniugi vissero separati per oltre tre mesi. Dietro questi trambusti, fu omesso, (forse per trascuranza, forse per diffidenza di Salvatore, o per altre ragioni occulte) di registrare l’atto di nascita della bambina.
Sulla grave e inaspettata rivelazione dalla vecchia, potrebbero farsi non pochi commenti, che io lascio tutti al lettore. Misteri dell’amore o del capriccio, comuni in ogni luogo, in ogni tempo, e in ogni classe sociale!
Il gemello Peppe rassomiglia perfettamente a Giovanni Tolu nella sembianza, nella voce e nelle movenze — non nelle forme, assai più delicate. È un vecchio pieno di spirito e di buon senso, ed ha un ingegno acuto, forse superiore a quello di Giovanni. Nel narrarci diversi episodi (che combinano con quelli narrati dal fratello) egli non dimenticò, come antico sagrestano, d’infiorarli con qualche citazione in latino.
48. Vedi la vignetta della cascina a pagina 260.
49. Sono non poche le inesattezze e gli episodi fantastici, che corrono sulla vita di Giovanni Tolu. Basti, fra gli altri, la storiella del marito, che ha ucciso il prete per vendicare il proprio onore oltraggiato. In una recente conferenza, letta a Roma, si osò asserire, che Tolu fosse un laureato (!), e che uccise il prete sull’altare, al momento dell’elevazione (!!).
Questo valga per dimostrare, come la fantasia del popolo riesca a creare le leggende, anche su personaggi contemporanei. Che diremo di certi fatti, a noi trasmessi dai secoli più remoti? Povera Storia, se mancassero i documenti o la buona fede!
Meno fantastici, in generale, sono gli scrittori stranieri, nel parlare di Giovanni Tolu. Ecco quanto scrive il valente pittore e poeta francese Gustavo Vuillet, nel pregievole suo libro illustrato: Le isole dimenticate. (Parigi, 1893).
«Certains BANDITI, tels que Giovanni Tolu, ont rendu de grands services au pays. Tolu purgea toute une région de malfaiteurs à ses risques et pèrils au milieu de continuels dangers. Il se rendit aussi dans la Nurra, ou les habitants ètaint en armes: il éteignit les haines, réconcilia les familles, et delivra le pays de brigands (?) qui l’infestaient; souvent il protegea les volés contre le voleurs, et, gràce à lui, plus d’un brave paysan vit revenir à l’étable, ou à l’ècurie, les bêtes dont des mècréants l’avaient soulagè. On racontait bien que Tolu avait tuè quelques carabiniers, mais en cas de lègitime défense, et tout le monde lui donnait raison.»
Il quadro, sebbene a tinte color di rosa, ha un fondo di vero.
50. Giovanni Tolu, di statura media, era robusto, tarchiato, diritto della persona, sebbene contasse 74 anni. Aveva grave il portamento, fiero lo sguardo, folta e bianca la barba.
Serio, compassato, sentenzioso, di poche parole, egli rideva di rado, ma aveva sempre pronta la barzelletta e il motto di spirito, per lo più sarcastico. Di carattere piuttosto burbero, tenace delle proprie idee, difficilmente cedeva all’altrui consiglio. Menava vanto, assai spesso, della propria forza e della propria perspicacia, forse perchè troppo magnificate dal volgo.
Era diventato un po’ sordo, e inforcava gli occhiali quando voleva leggere o scrivere. Sobrio e frugale, non beveva mai vino fuor di pranzo.
Da una trentina d’anni indossava una giacca di fustagno o di velluto, pantaloni lunghi, berretto alla sarda, e cappottone con cappuccio nell’inverno. Usava da qualche tempo fasciare il collo con una larga pezzuola di lana bianca, come lo si vede nel ritratto, eseguito a Sassari dal fotografo Lori.
51. Diversi giornali aggiunsero: «l’uccisore di diciasette carabinieri (!?)».
52. A proposito di quanto asserisco, si legga la storia di Domenico Tiburzi (ucciso nell’ottobre del 1896) di recente pubblicata dal Conte Alvise da Santafior, nel Corriere Agricolo Commerciale di Milano, (in 20 puntate).
Nota del Trascrittore
Ortografia e punteggiatura originali sono state mantenute, correggendo senza annotazione minimi errori tipografici. Le correzioni indicate nella Nota a fine indice sono state riportate nel testo.
Copertina creata dal trascrittore e posta nel pubblico dominio.